“Supponiamo che io abiti al pianterreno di un vecchio edificio; sul mio pianerottolo c’è un’altra porta dove abita un altro inquilino. Non lo conosco: ogni tanto sento che esce di casa o che rientra a tarda sera ma non so neppure che faccia abbia. L’amministratore è latitante, non c’è il portiere. Il problema è chi debba pulire il pianerottolo. Posso scegliere fra alcune alternative: a. non occuparmene lasciando che questo spazio diventi nell’arco di 2-3 mesi impresentabile; b. pulire solo davanti alla mia porta sperando che lui pulisca davanti alla sua, ma se lui non lo farà il pianerottolo continuerà ad essere quasi impresentabile, e la cosa mi seccherà molto; c. il prossimo sabato mattina pulire tutto il pianerottolo, e magari anche l’androne, sperando che la settimana successiva lui afferri l’idea e prenda a sua volta il secchio e strofinaccio” (Jervis, 2002, p. 224).
Al protagonista di questa scena si pone un dilemma che attraversa molti ambiti dell'esistenza individuale e collettiva: meglio occuparsi solo di ciò che ci riguarda immediatamente e personalmente (la nostra parte di pianerottolo) oppure gettare lo sguardo un po’ più in là e prenderci cura anche di qualcosa che è dell’altro? Gettare lo sguardo più lontano nello spazio, quindi metaforicamente oltre il me e tutto ciò che sfiora la sfera personale di ciascuno di noi, e nel tempo, oltre il qui e ora. In altri termini, per rifarci alla teoria evoluzionistica dei giochi (Maynard-Smith, 1976): meglio comportarsi da falchi o da colombe? Meglio essere egoisti (in senso tecnico: dare priorità all’interesse personale, vincere o perdere tutto) o cooperare, anche laddove questo possa implicare un costo (pareggiare)?
Il problema – lo si comprende bene nella situazione di condivisione degli spazi comuni – è quello dell’interdipendenza tra i soggetti. La prospettiva dominante nello studio della cooperazione è rappresentata dalla letteratura sui dilemmi sociali, ossia situazioni di conflitto tra interesse individuale e interesse collettivo. La teoria dei giochi, e successivamente la psicologia sociale, hanno studiato i comportamenti di interdipendenza utilizzando il paradigma sperimentale del dilemma del prigioniero, un gioco proposto da Merrill Flood e Melvin Dresher nel 1950 (Kuhn, 2009).  L’espressione deriva dal seguente gioco: due sospetti vengono presi sotto custodia e separati. La polizia è certa che essi siano colpevoli di un crimine ma non ha potuto raccogliere prove sufficienti. Viene detto ai prigionieri che hanno due alternative: confessare e o tenere il silenzio. Se entrambi non confesseranno, saranno loro addebitate colpe mai commesse ma di minor conto, e riceveranno una piccola sanzione. Se entrambi confesseranno, saranno condannati, ma riceveranno una pena inferiore al massimo previsto. Se uno dei due confessa e l’altro mantiene il silenzio, il delatore sarà libero mentre l’altro, che ha mantenuto il silenzio, riceverà il massimo della pena. La scelta migliore per entrambi, sarebbe, dunque, quella di non confessare, ma per fare questo dovrebbero accordarsi e, soprattutto, dovrebbero fidarsi l’uno dell’altro. I risultati degli studi condotti utilizzando questo paradigma indicano invece che, nella gran parte dei casi, i soggetti scelgono di sfruttarsi l’un l’altro, cioè di non cooperare. Essi tendono ad adottare, in linea con la razionalità individuale, una strategia egoistica. Questa scelta si rivela, tuttavia, dannosa per l’interesse di entrambi, che si avvantaggerebbero di una soluzione cooperativa, tale cioè da non produrre la vittoria dell’uno e la sconfitta dell’altro. Il dilemma illustra, dunque, un conflitto tra la razionalità individuale e la razionalità collettiva, mettendo in evidenza come, se i membri di un gruppo perseguono individualmente il proprio interesse, essi possono ottenere risultati inferiori a quelli che potrebbero essere raggiunti da un gruppo i cui membri agiscano in modo cooperativo.
L’espressione deriva dal seguente gioco: due sospetti vengono presi sotto custodia e separati. La polizia è certa che essi siano colpevoli di un crimine ma non ha potuto raccogliere prove sufficienti. Viene detto ai prigionieri che hanno due alternative: confessare e o tenere il silenzio. Se entrambi non confesseranno, saranno loro addebitate colpe mai commesse ma di minor conto, e riceveranno una piccola sanzione. Se entrambi confesseranno, saranno condannati, ma riceveranno una pena inferiore al massimo previsto. Se uno dei due confessa e l’altro mantiene il silenzio, il delatore sarà libero mentre l’altro, che ha mantenuto il silenzio, riceverà il massimo della pena. La scelta migliore per entrambi, sarebbe, dunque, quella di non confessare, ma per fare questo dovrebbero accordarsi e, soprattutto, dovrebbero fidarsi l’uno dell’altro. I risultati degli studi condotti utilizzando questo paradigma indicano invece che, nella gran parte dei casi, i soggetti scelgono di sfruttarsi l’un l’altro, cioè di non cooperare. Essi tendono ad adottare, in linea con la razionalità individuale, una strategia egoistica. Questa scelta si rivela, tuttavia, dannosa per l’interesse di entrambi, che si avvantaggerebbero di una soluzione cooperativa, tale cioè da non produrre la vittoria dell’uno e la sconfitta dell’altro. Il dilemma illustra, dunque, un conflitto tra la razionalità individuale e la razionalità collettiva, mettendo in evidenza come, se i membri di un gruppo perseguono individualmente il proprio interesse, essi possono ottenere risultati inferiori a quelli che potrebbero essere raggiunti da un gruppo i cui membri agiscano in modo cooperativo.
Tuttavia, anche nei dilemmi sociali possono verificarsi esempi di soluzione cooperativa; Axelrod (1984) ha dimostrato che nelle versioni ripetute o prolungate del dilemma del prigioniero emerge spontaneamente una strategia non intenzionale basata sulla reciprocità, che tende a ribattere “colpo su colpo” (tit for tat) all’azione dell’avversario: l’opzione cooperativa è mantenuta fino al momento in cui l’altro non sceglie la defezione; a questo punto si risponde, per rappresaglia, con un’ulteriore defezione, spingendo l’avversario a riprendere la scelta cooperativa. E’ il principio del rinforzo: la cooperazione è premiata con la cooperazione e lo sfruttamento con un’analoga reazione di sfruttamento; ma è la norma di reciprocità, ovvero l’aspettativa che l’altro ricambi, a porre le basi della cooperazione.
In definitiva, quindi, la teoria dei giochi non riesce a dimostrare compiutamente che l’insorgenza della cooperazione derivi da un calcolo di utilità. L’interazione tra gli individui e le risorse comuni è molto più complessa e varia di quanto tale modello presuma (Schlager, 2002) e, come attestano molti esempi della vita reale, la valutazione costi-benefici non è l’unica a guidare i comportamenti dei singoli e dei gruppi. I fattori che promuovono la cooperazione sono un intreccio di motivazioni altruistiche, norme morali e norme sociali (Elster, 1989), a cui si aggiungono, sul piano strettamente cognitivo, le illusioni derivanti dalla credenza quasi-magica che il proprio comportamento possa determinare le azioni altrui nella direzione voluta (Girotto, 1996).
Ma alla base dei comportamenti cooperativi si pone, essenzialmente, la fiducia: la disponibilità ad accettare una condizione di vulnerabilità nella relazione con l’altro, a partire dall’aspettativa che il comportamento dell’altro non sarà di danno (Rousseau, Sitkin, Burt, & Camerer 1998). In termini psicologici, la fiducia è un particolare livello delle probabilità soggettive con cui un attore valuta che altri compiranno una certa azione; è una teoria circa il comportamento altrui in un’occasione futura, in funzione di affermazioni presenti o passate. Fidarsi implica anche accettare di incorrere nel rischio di non essere ricambiati (Song, 2009). Riprendendo l’esempio riportato in apertura: “Se, come un qualsiasi altro cittadino, io ho fin dall'inizio una qualche fiducia nel mio vicino è perché ritengo di vivere in un contesto sociale amichevole, dove prevale la disponibilità. In caso contrario non prevedo che i miei vicini saranno cooperativi e suppongo che la pulizia del pianerottolo – oltre che all'androne e così via, e sempre che io ami gli spazi puliti – resterà a mio carico (Jervis 2002, p. 225). Insomma, il vicino può non raccogliere il messaggio e non voler cooperare, e in questo caso il protagonista avrà fatto del lavoro in più senza ottenere i frutti sperati, e la sua aspettativa sarà andata delusa. In ogni caso, la capacità della fiducia di stimolare comportamenti cooperativi appare piuttosto marcata. Possiamo generalizzare questo principio all’insieme dei rapporti sociali? Immaginare che esso valga non solo nell’interazione interpersonale, ma anche quando gli attori sono entità collettive, cioè gruppi, organizzazioni, istituzioni, comunità?
Cooperazione e fiducia nei processi decisionali inclusivi
Consideriamo le manifestazioni della fiducia all’interno di un particolare ambito d’azione: quello dei “processi decisionali inclusivi”: questa etichetta include una variegata pletora di situazioni in cui le istituzioni politiche, chiamate a compiere scelte di e nell’interesse collettivo, istituiscono un setting partecipativo in cui gruppi di cittadini e stakeholder (associazioni, imprese, ecc.) sono chiamati a cooperare tra loro e con le istituzioni stesse per la risoluzione di problemi collettivi. Interdipendenza e incertezza, le due condizioni basilari per lo sviluppo della fiducia, costituiscono caratteristiche intrinseche di questi setting. E dunque, come si declina la fiducia in queste pratiche decisionali?
Fidarsi degli sconosciuti
I processi decisionali inclusivi coinvolgono piccoli gruppi di persone, potenzialmente in grado di agevolare l’interazione diretta, le relazioni e gli scambi d’informazioni, facilitare l’espressione dei punti di vista e favorire la comunicazione circolare, facendo sentire le persone relativamente “al sicuro”. Tuttavia, interagire all’interno di un gruppo non è, per gli individui, un comportamento naturale. Mentre la tendenza che spinge le persone, quando si trovano in una situazione non familiare, a cercarne un’altra, è istintiva e immediata, il passaggio che fa transitare i soggetti dalla dimensione di coppia alla dimensione di gruppo non è altrettanto fluido (Trentini, 1997).
Dal punto di vista strutturale, i gruppi che si formano nell’ambito dei processi decisionali partecipati sono costituiti da sconosciuti, chiamati a cooperare, per un tempo breve, in un’attività finalizzata. Nelle situazioni spontanee la fiducia si sviluppa a mano a mano che l’interazione progredisce e le persone imparano a conoscersi. Tuttavia, la fiducia può emergere anche in intervalli di tempo molto brevi: si tratta di una fiducia “rapida” (Meyerson, Weick, & Kramer 1996), che non richiede la presenza di quegli elementi che nella vita di tutti i giorni sono associati allo sviluppo della fiducia reciproca (per esempio la familiarità, la condivisione di esperienze, o il rispetto delle promesse). La fiducia rapida si basa, più che sulla conoscenza degli altri come individui unici e particolari, sulle informazioni che possiamo trarre dal loro ruolo sociale e da alcune caratteristiche generali come il sesso, l’età, la professione. In altri termini, si tratta di una conoscenza superficiale, che fornisce però le informazioni necessarie per consentire alle persone una reciproca apertura di credito. Tipicamente, ciò si verifica quando ci si trova in un contesto ignoto, tra individui sconosciuti; in situazioni di questo genere, in cui si è costretti all’interdipendenza con gli altri, non si si può far altro che accordare la propria fiducia anche correndo il pericolo che venga tradita. Tuttavia, se è vero che la fiducia rapida può formarsi velocemente, essa può ancora più rapidamente disfarsi.
Fidarsi delle istituzioni
Nelle pratiche decisionali di tipo partecipato la fiducia investe non soltanto le relazioni tra i partecipanti, ma anche il rapporto tra i cittadini e le istituzioni politiche. La qualità di tale rapporto, e il grado di affidabilità che lo contraddistingue, influiscono, infatti, sull’atteggiamento con il quale i cittadini si predispongono a cooperare (o a non cooperare) per la soluzione dei problemi collettivi.
Si ritiene generalmente che un atteggiamento fiducioso nei confronti delle istituzioni politiche favorisca la partecipazione nelle sue forme più tradizionali, mentre un atteggiamento disilluso e cinico incoraggi l’adozione di forme di protesta (Craig, Niemi, & Silver, 1990; Shingles 1988). Secondo una proposta teorica di tipo cognitivista (Castelfranchi & Falcone, 2000) l’atto del fidarsi presuppone che un soggetto A reputi l’individuo/sistema B di cui fidarsi come competente. Tuttavia, ciò non è sufficiente: è anche necessario che l’istituzione voglia agire nella direzione che il soggetto si aspetta. La fiducia dipende, secondo Newton (1999), oltre che dalla coincidenza tra aspettative e risultati, anche dal grado di consapevolezza che i soggetti possiedono del funzionamento delle istituzioni. Sono quindi molteplici i concetti che orbitano attorno all’atto del fidarsi; c’è una dimensione legata all’altro (percepire l’altro competente e riporre in esso delle aspettative) e ve ne è una di tipo individuale, connessa al livello di conoscenza. Secondo Pasquino (2002) si creerebbe una sorta di circolo vizioso tra la scarsa conoscenza e la scarsa fiducia: quest’ultima rappresenterebbe l’origine del disinteresse verso la politica che, a sua volta, condurrebbe a delle limitate conoscenze politiche. Da qui, poi, genererebbe un senso d’inefficacia personale il quale, infine, non farebbe altro che alimentare ulteriormente la sfiducia verso il mondo politico.
Significativa è anche la fenomenologia del rapporto decisori-cittadini. Se i decisori si collocano nella relazione secondo la logica del gioco a somma zero (per richiamare il paradigma del dilemma del prigioniero), consentire ai cittadini una partecipazione reale significa perdere quote di potere, dunque la strategia delle cooperazione risulta perdente. Al contrario, se essi si pongono nella logica del gioco a somma positiva, aprire la strada al coinvolgimento del cittadino nei processi decisionali significa accrescere il potere di entrambi. Analogo discorso riguarda i cittadini: quale vantaggio traggono dal partecipare? La valutazione varia in base al grado di fiducia riposto nelle istituzioni e, più in generale, al tipo di rappresentazione che le accompagna: in presenza di scarsa fiducia, è probabile che l’individuo ritenga più vantaggioso agire a tutela dei propri bisogni e interessi. Se l’istituzione è percepita come inaffidabile, altro da sé, nemica, elemento da negare, la scelta cooperativa non è sentita come opzione praticabile. In definitiva, in situazioni di crisi della fiducia nelle istituzioni, le persone giudicano rischioso adottare comportamenti cooperativi esponendosi al rischio di essere “sfruttati” da istituzioni egoiste.
Fidarsi dei gruppi
I processi decisionali inclusivi interpellano la cittadinanza su un tema/problema in una duplice forma: come singoli individui, membri di una comunità, e come portatori d’interesse (stakeholder): imprenditori, attivisti, operatori professionali, eccetera. In questa seconda veste, le persone esprimono una posizione che è personale ma che è allo stesso tempo rappresentativa della categoria cui appartengono: un imprenditore parla a nome proprio, ma anche come esponente della categoria degli imprenditori. Questa condizione influisce sulla dinamica fiduciaria. Bisogna, infatti, considerare che l’identità sociale che deriva dal fatto che un individuo si percepisce come membro di una certa categoria (gli imprenditori, per continuare con questo esempio), fa sì che egli/ella entri in relazione con l’altro in una modalità diversa di quella che contraddistingue il rapporto tra due individui in cui è l’identità personale ad essere saliente. Quest’assunto, che in psicologia sociale è stato avanzato dalla Teoria dell’Identità Sociale (Tajfel & Turner, 1979; 1986) e dalla Teoria della Categorizzazione del Sé (Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987) e che innumerevoli studi empirici hanno confermato, indica che c’è una discontinuità tra il livello della relazione interpersonale e il livello della relazione intergruppi: infatti, nel momento in cui il nostro imprenditore (Paolo) si rapporta ad un altro stakeholder, per esempio un operatore sociale (Giovanni), in quanto imprenditore, il confronto che si instaura non è più quello tra Paolo e Giovanni (io-tu), ma tra due gruppi o categorie sociali: gli imprenditori e gli operatori sociali (noi-voi). Questo salto nei livelli di funzionamento del sociale si riflette nella dinamica della fiducia. 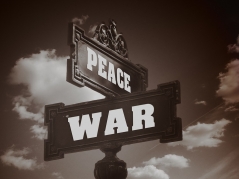 Numerosi studi, condotti in vari ambiti – pregiudizio e relazioni interetniche, cooperazione e conflitto – ispirati dalla Teoria dei giochi o dalla Teoria dell’Identità Sociale, mostrano chiaramente che le relazioni intergruppi sono significativamente più competitive e meno cooperative delle relazioni interpersonali. In sostanza, ci si fida di meno degli altri se gli altri sono categorizzati come membri di un gruppo diverso dal proprio. E questo comportamento si riscontra anche quando le persone interagiscono con altri come rappresentanti di un gruppo (Song, 2009). Maggiore competitività e minor fiducia possono verificarsi non solo in una situazione d’interdipendenza negativa – quando cioè un gruppo rappresenta per l’altro una minaccia simbolica o reale – ma anche in situazioni d’interdipendenza positiva, ossia quando i gruppi sono costretti a cooperare per raggiungere un obiettivo comune; può, infatti, accadere che, mancando una base fiduciaria basata su un’identità comune ai diversi gruppi, anche l’interdipendenza positiva possa generare ostilità e conflitto (Brewer, 1999). L’importanza dei processi di categorizzazione sociale appare in tutta la sua evidenza nei dilemmi sociali che implicano molteplici livelli di conflitto e molteplici appartenenze categoriali (sé, gruppo, comunità), in cui cioè entrano in gioco gli interessi individuali, gli interessi di specifici gruppi e l’interesse collettivo. In pratica, nelle relazioni che vanno oltre il livello interpersonale, la fiducia fa più fatica a stabilirsi, e questo fa sì che le probabilità di cooperare diminuiscano.
Numerosi studi, condotti in vari ambiti – pregiudizio e relazioni interetniche, cooperazione e conflitto – ispirati dalla Teoria dei giochi o dalla Teoria dell’Identità Sociale, mostrano chiaramente che le relazioni intergruppi sono significativamente più competitive e meno cooperative delle relazioni interpersonali. In sostanza, ci si fida di meno degli altri se gli altri sono categorizzati come membri di un gruppo diverso dal proprio. E questo comportamento si riscontra anche quando le persone interagiscono con altri come rappresentanti di un gruppo (Song, 2009). Maggiore competitività e minor fiducia possono verificarsi non solo in una situazione d’interdipendenza negativa – quando cioè un gruppo rappresenta per l’altro una minaccia simbolica o reale – ma anche in situazioni d’interdipendenza positiva, ossia quando i gruppi sono costretti a cooperare per raggiungere un obiettivo comune; può, infatti, accadere che, mancando una base fiduciaria basata su un’identità comune ai diversi gruppi, anche l’interdipendenza positiva possa generare ostilità e conflitto (Brewer, 1999). L’importanza dei processi di categorizzazione sociale appare in tutta la sua evidenza nei dilemmi sociali che implicano molteplici livelli di conflitto e molteplici appartenenze categoriali (sé, gruppo, comunità), in cui cioè entrano in gioco gli interessi individuali, gli interessi di specifici gruppi e l’interesse collettivo. In pratica, nelle relazioni che vanno oltre il livello interpersonale, la fiducia fa più fatica a stabilirsi, e questo fa sì che le probabilità di cooperare diminuiscano.
Conclusioni
In una situazione sociale come quella rappresentata da un setting partecipativo istituzionalizzato, in cui l'individuo entra in contatto con altri sconosciuti, il passaggio dalla relazione uno-a-uno alla relazione uno-a-molti fa i conti con una fisiologica resistenza alla cooperazione. E tuttavia, quando il gruppo e il suo obiettivo si definiscono, scatta un’interdipendenza legata al compito, e l'incertezza che caratterizza la situazione favorisce l'emergere di una fiducia rapida. Non tutti, evidentemente, si fidano degli altri nella stessa misura, e non tutti sono, per loro natura, disponibili a cooperare: anche alcune dimensioni di personalità giocano un ruolo nei processi di decisione collettiva, contrapponendo falchi (tipi proself) e colombe (tipi prosocial) (Van Lange, 1999). Come elemento di sfondo all'azione degli attori, ma in grado di influenzare i loro comportamenti, sta la relazione che lega cittadini e istituzioni: esperienze e conoscenze pregresse, percezione di affidabilità e competenza, determinano l'atteggiamento di base con cui gli attori entrano nei processi decisionali inclusivi. Anche per questa diade composta da entità collettive (le istituzioni, la cittadinanza), vale la generale, se pur non infallibile, regola di reciprocità che governa le relazioni interpersonali: la disponibilità tende a essere ricambiata con la disponibilità, l'egoismo con l'egoismo. Infine, ci sono altre entità collettive che entrano in gioco nei contesti decisionali: sono i gruppi di riferimento dei partecipanti, che fanno sì che la relazione tra di essi possa spostarsi sul livello intergruppi, rendendo la dinamica fiduciaria meno fluida.
E' certo, tuttavia, che per trovare soluzioni ai dilemmi sociali e ai problemi che affliggono le comunità, anzi per preservare l'orizzonte di senso comune che è alla base della convivenza e fa da collante sociale, le colombe sono più utili dei falchi. Abbiamo bisogno di fidarci.
Glossario
Bibliografia
Axelrod, R. (1984). The evolution of cooperation. New York, NY: Basic Books.
Brewer, M. (1999). The psychology of prejudice: Ingroup love or outgroup hate?. Journal of Social Issues, 55, 429-444.
Castelfranchi, C., & Falcone, R. (2000). Trust and control: A dialectic link. Applied Artificial Intelligence Journal, 14, 799-823.
Craig, S. C., Niemi, R.G., & Silver, G.E. (1990). Political efficacy and trust: A report on the NES pilot study items. Political Behaviour, 12, 289-314.
Elster, J. (1989). Nuts and bolts for the social sciences. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Girotto, M. (1996). Fondamenti cognitivi dei paradossi della razionalità. In P. Legrenzi, V. Girotto (Eds.), Psicologia e politica (pp. 91-123). Milano: Cortina.
Jervis, G. (2002). Individualismo e cooperazione. Roma: Laterza.
Kuhn, S. (2009). Prisoner’s dilemma. In N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2009 Edition) <http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/prisoner-dilemma/>.
Maynard-Smith, J. (1976). Evolution and the theory of games. American Scientist, 64. 41-45.
Meyerson, D., Weick, K., & Kramer, R. (1996). Swift trust and temporary groups. In R. Kramer & T. Tyler (Eds.), Trust in organizations: Frontiers of theory and research (pp. 166-195). Thousand Oaks, CA: Sage.
Newton, K. (1999). Social and political trust in established democracies. In P. Norris (Ed.), Critical citizens: Global support for democratic government (pp. 169-187). Oxford, UK: Oxford University Press.
Pasquino, G. (2002). Una cultura poco civica. In M. Caciagli, & P. Corbetta (Eds.), Le ragioni dell’elettore pp. (53-78). Bologna: Il Mulino.
Rousseau, D., Sitkin, S., Burt, R., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 393-404.
Schlager, E. (2002). Rationality, cooperation and common pool resources. American Behavioral Scientist, 45, 801-819.
Shingles, R.D. (1988). Dimensions of subjective political efficacy and political trust: Their meaning measurement and significance. Paper presentato al Meeting Annuale della Midwest Political Science Association, Chicago.
Song, F. (2009). Intergroup trust and reciprocity in strategic interactions: Effects of group decision-making mechanisms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 108, 164-173.
Tajfel, H. , & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA: Brooks/Cole
Tajfel, H., & Turner, J.C. (1986) The Social Identity Theory of intergroup behavior. Psychology of Intergroup Relations, 5, 7-24.
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, UK: Blackwell
Trentini, G. (1997). Oltre il potere. Discorso sulla leadership. Milano: FrancoAngeli.
Van Lange, P. (1999). The pursuit of joint outcomes and equality in outcomes: An integrative model of social value orientation. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 337-349.

!["With pride" from Enrico via Flickr (https://flic.kr/p/RbADC), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/gay.jpg?itok=u6lSLsmR)
!["C'eravamo tanto amati" from Cristiano Sabbatini via Flickr (https://flic.kr/p/jeUQg7), cc [https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/comunicazione_non_verbale.jpg?itok=C6C-nRzn)
!["Love" from Letizia Barbi via Flickr (https://flic.kr/p/88tfAV), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/cuore.jpg?itok=uTsEcYXV)
!["Trust" from Joi Ito via Flickr (https://flic.kr/p/5tWgh4), cc [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/]](/sites/it-version/files/styles/im_small_600x325_/public/field/image/trust.jpg?itok=HBnwySIi)