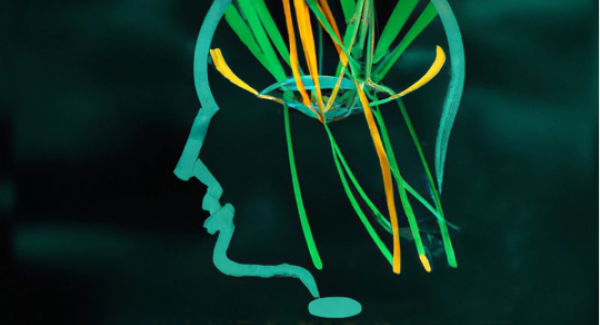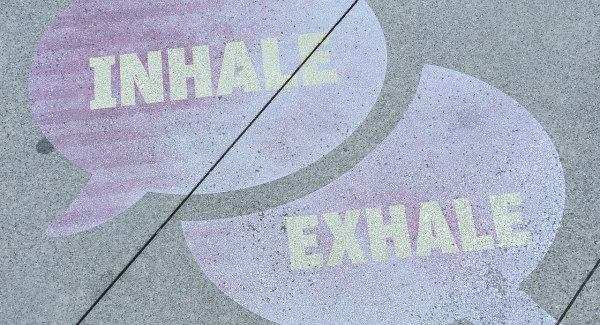Il fatto che il sonno sia essenziale per il benessere fisiologico e psicologico è oggi ben noto a tutti gli atleti e a tutte le atlete. Usain Bolt ha tagliato il traguardo per la sesta volta ai Giochi Olimpici del 2008, guadagnandosi il titolo di uomo più veloce del mondo. Dopo la gara, Bolt ha affermato che la parte più importante del suo intenso regime di allenamento era il sonno: "Il sonno è estremamente importante per me - ho bisogno di riposare e recuperare affinché l'allenamento che faccio sia assorbito dal mio corpo". Ogni sport richiede il recupero sia muscolare sia cognitivo, e solo un atleta ben riposato è in grado di raggiungere prestazioni di picco. La National Sleep Foundation (organizzazione riconosciuta a livello mondiale di medicina del sonno) raccomanda di dormire 7-9 ore per una persona adulta sana (Hirshkowitz et al., 2015). Un sonno riposante (>85% di efficienza del sonno, <30 min di latenza del sonno, <40 min di tempo di veglia dopo l'inizio del sonno) è quindi essenziale per la preparazione e il recupero della competizione. Molti fattori possono influenzare negativamente il sonno degli atleti e delle atlete: cambiamenti di temperatura e/o altitudine, viaggi attraverso fusi orari, stress e ansia legati alla competizione, nonché modifiche nella dieta e nei tempi o nella durata dell'allenamento, continui cambiamenti nell'ambiente esterno e nel sonno, e variazioni nel ritmo giorno/notte che caratterizzano la stagione di un/a atleta professionista. Questo articolo fornirà informazioni rilevanti sulla fisiologia del sonno e sui vari disturbi del sonno. Inoltre, gli effetti del sonno durante l'allenamento e la competizione, ad esempio durante i Giochi Olimpici, saranno discussi. Sulla base di ciò, saranno poi quindi fornite linee guida e istruzioni per strategie e consigli pratici per migliorare il comportamento del sonno degli atleti e delle atlete.
Perché dormiamo e quanto è importante dormire?
In media, trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. All'età di 85 anni, avremo trascorso circa 30 anni nel letto a dormire. Si sa che il sonno è molto variabile sia inter-individualmente (fra i diversi individui) che intra-individualmente (ogni individuo dorme in maniera diversa ogni notte). Numerosi studi hanno dimostrato che la durata individuale del sonno varia ampiamente (Fullagar et al., 2015): in media, gli atleti e le atlete dormono significativamente meno (6-8 ore) rispetto alle 7-9 ore raccomandate (Lastella et al., 2015) e conseguono circa 96 minuti di sonno in meno di quanto avrebbero bisogno per sentirsi riposati (Sargent et al., 2021). In generale, quindi, gli atleti e le atlete non raggiungono sempre i livelli ottimali di sonno. Recentemente, Vitale e colleghi (2023) hanno studiato il sonno degli atleti e delle atlete di livello olimpico nell'atletica leggera prima dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 e hanno scoperto che il 18,8% degli atleti e delle atlete dormiva male, con un'efficienza del sonno < 85%, e il 31,3% erano brevi dormitori, ossia atleti/e con un tempo totale di sonno < 7 ore.
Sebbene i meccanismi fisiologici che regolano il sonno siano molto complessi e non ancora completamente compresi, diverse funzioni e processi umani ne sono influenzati. Una di queste funzioni sarebbe il recupero del corpo e del sistema nervoso centrale. L'aumento dei livelli dell'ormone della crescita durante la prima metà della notte e il reintegro delle riserve di glicogeno potrebbero supportare questa ipotesi. Durante il sonno, sia il metabolismo che la temperatura corporea diminuiscono, suggerendo anche una funzione di risparmio energetico. È particolarmente importante, per gli atleti e le atlete, sottolineare l'importanza del sonno per il mantenimento di un sistema immunitario efficiente. Studi sulla privazione del sonno, condotti sia su animali sia su umani, mostrano una maggiore suscettibilità alle infezioni quando la durata del sonno è ridotta. Inoltre, la consolidazione della memoria e delle conoscenze appena acquisite durante il sonno è scientificamente comprovata (King et al., 2017). I compiti appresi prima di un periodo di sonno tendono a essere meglio trattenuti rispetto a quelli appresi prima di un periodo di veglia. Questi risultati sono in linea anche con le comuni lamentele di problemi di memoria e concentrazione tra gli atleti e le atlete che soffrono di una qualità del sonno compromessa. Fullagar e colleghi (2015) hanno scoperto che la ridotta qualità del sonno non influisce direttamente sulla performance atletica, ma piuttosto ha un effetto indiretto tramite instabilità emotiva, mancanza di motivazione e concentrazione, e compromissione delle prestazioni cognitive.
Sonno e disturbi del sonno nello sport d'élite
Sebbene l'attività fisica regolare e l'esercizio fisico siano noti per migliorare la qualità del sonno, si osserva una prevalenza di sonno insufficiente tra gli atleti e le atlete di élite (Falck et al., 2021). Generalmente, gli atleti e le atlete mostrano una prevalenza di disturbi del sonno simile a quella della popolazione generale, inclusi i disturbi respiratori legati al sonno. Ciò indica che i disturbi del sonno sono altrettanto frequenti tra gli atleti e le atlete professionisti/e quanto nella popolazione generale, ma spesso vengono trascurati. Inoltre, lo sport di alto livello presenta specifiche condizioni che possono interferire con il normale riposo: sia un eccessivo volume di allenamento (Matos et al., 2011) sia un'intensità di allenamento elevata poco prima di andare a letto (40 minuti di allenamento su tapis roulant all'80% della HRmax alle 21:30; Oda & Shirakawa, 2014) possono deteriorare la qualità del sonno. Ad esempio, un'intensità di allenamento più elevata può prolungare i periodi di veglia durante la notte. A seconda della gravità dei disturbi del sonno sviluppati, gli atleti e le atlete possono riscontrare un significativo peggioramento delle proprie prestazioni e sentirsi incapaci di esibirsi al meglio durante le competizioni. Spesso gli atleti e le atlete riportano difficoltà nell'addormentarsi, nello svegliarsi presto al mattino e nel risvegliarsi frequentemente durante la notte prima di una competizione. Ad esempio, un maggiore stress psicologico durante i Giochi Olimpici di Rio 2016 ha comportato un aumento dei disturbi del sonno e una maggiore disfunzione diurna tra gli atleti e le atlete (Halson et al., 2021). La consapevolezza di una scarsa qualità del sonno prima di una gara può portare a disfunzioni diurne, come eccessiva nervosità, scelte errate o ritiro anticipato durante la competizione. Inoltre, dormire in un ambiente non familiare e/o adattarsi a un fuso orario diverso può spesso compromettere ulteriormente il sonno. Le ricerche trasversali indicano che gli atleti e le atlete e il personale di supporto possiedono poca o nessuna conoscenza delle strategie per gestire i problemi di sonno prima, durante e dopo le competizioni. La sezione seguente esplorerà i disturbi del sonno associati ai cambiamenti di fuso orario
Jetlag e stress da viaggio
Il jetlag è un disturbo temporaneo del sonno che si verifica quando il ritmo circadiano interno è disallineato a causa di viaggi transmeridiani. Il disturbo si caratterizza per vari gradi di difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno, sonnolenza diurna eccessiva, ridotta allerta e performance durante il giorno, e sintomi vegetativi come cambiamenti dell'appetito e aumento della frequenza di risvegli notturni per urinare. Oltre a disturbare il ciclo sonno-veglia, anche altre funzioni corporee soggette ai ritmi circadiani, come la temperatura corporea e la digestione, possono essere influenzate. Si possono inoltre verificare sintomi quali mal di testa e vertigini. Iga Swiatek, numero uno mondiale ATP, condivide il suo segreto per gestire il jetlag: a volte, quando viaggia dall'Australia al Medio Oriente e poi negli Stati Uniti, va tutto bene, ma quando torna in Europa, o quando va dagli Stati Uniti alla Cina, è molto difficile. 'Andando da ovest a est, ho solo bisogno di un piccolo aiuto come la melatonina.' Anche il suo psicologo dello sport la sta aiutando, fornendole lampade di differenti intensità luminose. Queste lampade aiutano Iga a mantenere un ciclo di 24 ore e un buon ritmo del sonno. Descrive anche come mantenere una routine di allenamento la aiuti a ritrovare un buon ciclo sonno-veglia: 'Quando mi alleno, è molto più facile superare il momento. A volte, come dopo gli US Open, ho avuto una settimana libera ed è stato molto più difficile tornare al ritmo'. Molti degli atleti e delle atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi sperimenteranno sintomi di jetlag e quindi è consigliato seguire alcune linee guida per gestire i sintomi di jetlag e la fatica (van Rensburg et al., 2021; vedere Figura 1). La direzione del volo gioca un ruolo importante nello sviluppo dei sintomi di jetlag. In generale, i voli verso ovest, che allungano il giorno, sono meglio tollerati dal corpo rispetto ai voli verso est, che accorciano la giornata. Questo perché il nostro orologio interno non funziona esattamente a un ritmo di 24 ore al giorno, ma in fasi orarie leggermente più lunghe. I voli verso ovest sono quindi più adattabili all'orologio interno. Ad esempio, se si vola da Parigi in Francia a San Francisco negli USA e si atterra alle 18:00, sarà mezzanotte in Francia. Se rimani sveglio per alcune ore in più, andrai a letto molto stanco ed esausto, ma ti adatterai bene al nuovo ritmo sonno-veglia. D'altra parte, se voli da San Francisco a Parigi e arrivi alle 18:00, il tuo corpo è ancora abituato all'ora di San Francisco (sono solo le 12:00 qui). Ecco perché di solito è più difficile addormentarsi in poche ore. Più fusi orari attraversi, più gravi sono i sintomi. In generale, puoi aspettarti di impiegare circa un giorno per adattarti a ciascun fuso orario, a seconda della tua salute e dell'età, così come della tua esperienza di viaggio e del tuo cronotipo. Agli atleti e alle atlete, in particolare a quelli/e che devono cambiare frequentemente fuso orario, si consiglia di adattarsi all'orario del paese di destinazione il prima possibile. Con una differenza di tempo di 6 ore, idealmente dovresti arrivare almeno 6 giorni prima della competizione. Se ciò non è possibile, puoi prendere alcune precauzioni nel tuo paese di origine. Per i voli verso est, dovresti anticipare l'orologio interno di 3-4 giorni prima di viaggiare (ad esempio, andare a letto e alzarsi un'ora prima). Per i voli verso ovest vale l'opposto. Un adeguamento precoce, utilizzando l'esposizione programmata alla luce (ad esempio, stimolazione luminosa con una lampada da giorno) per sopprimere la secrezione di melatonina e facilitare al contempo la veglia, può essere utile. Si dovrebbe cercare luce nelle prime ore della sera ed evitarla nella seconda metà della notte e nel primo mattino. Gli occhiali da sole possono essere utilizzati per ridurre l'esposizione alla luce. È consigliabile prenotare un volo che arrivi nel pomeriggio, così da poter andare a dormire in un orario prevedibile. Si raccomanda di regolare gli orologi all'ora del paese di destinazione e di adeguare il proprio comportamento a quest'ultima durante il volo. Ad esempio, molte compagnie aeree ora servono i pasti in linea con queste raccomandazioni. È importante rimanere idratati durante il volo, ma evitare la caffeina. Una volta arrivati a destinazione, un breve pisolino (20 minuti o meno) può aiutare a recuperare dalla privazione del sonno. La luce naturale è sempre da preferire a quella artificiale e aiuta a regolare il ciclo sonno-veglia. Per strategie specifiche di gestione del jet lag prima, durante e dopo il volo si rimanda alla Figura 1. Esistono numerose tattiche per mitigare il jet lag e lo stress da viaggio, le quali variano a seconda del punto di partenza e delle risorse disponibili. Pur essendo difficile riassumere tutte queste strategie in una singola illustrazione, abbiamo evidenziato alcune chiavi essenziali. Queste possono variare a seconda di fattori come la durata del viaggio o l'ora di partenza. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un coach del sonno professionale per ottenere una guida personalizzata prima di viaggiare!
Strategie per migliorare la qualità del sonno negli atleti olimpici
È degno di nota che recenti studi hanno dimostrato che l'adozione di strategie individualizzate di igiene del sonno può portare a un miglioramento del tempo totale di sonno e a una riduzione della latenza del sonno (ossia il tempo necessario per addormentarsi dopo essere andati a letto) negli atleti e nelle atlete di livello olimpico (Pasquier et al., 2023; Vitale et al., 2023). Le regole di igiene del sonno illustrate nella Figura 2 dovrebbero essere seguite in particolare dagli atleti olimpici e dalle atlete olimpiche. Se un/a atleta lamenta problemi di sonno per più di quattro settimane, è consigliabile consultare un medico per verificare la presenza di disturbi clinici del sonno. In caso di sospetto di un disturbo del sonno organico, come un disturbo respiratorio correlato al sonno, è necessaria una polisonnografia professionale in un laboratorio del sonno.

Figura 1. Strategie per affrontare il jet lag prima, durante e dopo il viaggio.

Figura 2. Strategie per migliorare la qualità del sonno negli atleti.
Bibliografia
Falck, R.S., Stamatakis, E., & Liu-Ambrose, T. (2021). The athlete’s sleep paradox prompts us to reconsider the dose-response relationship of physical activity and sleep. British Journal of Sports Medicine, 55(16), 887-888. https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-103835
Forndran, A., Lastella, M., Roach, G.D., Halson, S.L., Sargent, C. (2012). Training schedules in elite swimmers: No time to rest? In: Zhou X, Sargent C (Eds). Sleep of different populations. Australasian Chronobiology Society, Adelaide, Australia, pp. 6-10.
Fullagar, H. H. K., Skorski, S., Duffield, R., Hammes, D., Coutts, A. J., & Meyer, T. (2015). Sleep and athletic performance: The effects of sleep loss on exercise performance, and physiological and cognitive responses to exercise. Sports Medicine, 45(2), 161–186. https://doi.org/10.1007/s40279-014-0260-0
Halson, S. L., Appaneal, R. N., Welvaert, M., Maniar, N., & Drew, M. K. (2021). Stressed and Not Sleeping: Poor Sleep and Psychological Stress in Elite Athletes Prior to the Rio 2016 Olympic Games. International Journal of Sports Physiology and Performance, 17(2), 195-202. https://doi.org/10.1123/ijspp.2021-0117
Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., Alessi, C., Bruni, O., DonCarlos, L., Hazen, N., Herman, J., Adams Hillard, P. J., Katz, E. S., Kheirandish-Gozal, L., Neubauer, D. N., O'Donnell, A. E., Ohayon, M., Peever, J., Rawding, R., Sachdeva, R. C., Setters, B., Vitiello, M. V., & Ware, J. C. (2015). National Sleep Foundation's updated sleep duration recommendations: Final report. Sleep Health, 1(4), 233–243. https://doi.org/10.1016/j.sleh.2015.10.004
Jansen van Rensburg, D. C., Jansen van Rensburg, A., Fowler, P. M., Bender, A. M., Stevens, D., Sullivan, K. O., Fullagar, H. H. K., Alonso, J. M., Biggins, M., Claassen-Smithers, A., Collins, R., Dohi, M., Driller, M. W., Dunican, I. C., Gupta, L., Halson, S. L., Lastella, M., Miles, K. H., Nedelec, M., Page, T., … Botha, T. (2021). Managing Travel Fatigue and Jet Lag in Athletes: A Review and Consensus Statement. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 51(10), 2029–2050. https://doi.org/10.1007/s40279-021-01502-0
King, B. R., Hoedlmoser, K., Hirschauer, F., Dolfen, N., & Albouy, G. (2017). Sleeping on the motor engram: The multifaceted nature of sleep-related motor memory consolidation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 80, 1–22. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.04.026
Lastella, M., Halson, S.L., Vitale, J.A., Memon, A.R., & Vincent, G.E. (2021). To Nap or Not to Nap? A Systematic Review Evaluating Napping Behavior in Athletes and the Impact on Various Measures of Athletic Performance. Nature and Science of Sleep, 13, 841-862. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34194254/
Lastella, M., O'Mullan, C., Paterson, J. L., & Reynolds, A. C. (2019). Sex and Sleep: Perceptions of Sex as a Sleep Promoting Behavior in the General Adult Population. Frontiers in public health, 7, 33. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00033
Lastella, M., Roach, G. D., Halson, S. L., & Sargent, C. (2015). Sleep/wake behaviours of elite athletes from individual and team sports. European journal of sport science, 15(2), 94–100. https://doi.org/10.1080/17461391.2014.932016
Matos, N. F., Winsley, R. J., & Williams, C. A. (2011). Prevalence of nonfunctional overreaching/overtraining in young English athletes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(7), 1287–1294. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318207f87b
Oda, S., & Shirakawa, K. (2014). Sleep onset is disrupted following pre-sleep exercise that causes large physiological excitement at bedtime. European Journal of Applied Physiology, 114(9), 1789–1799. https://doi.org/10.1007/s00421-014-2873-2
Pasquier, F., Pla, R., Bosquet, L, Sauvet, F, Nedelec., and D-Day Consortium (2023). The Impact of Multisession Sleep-Hygiene Strategies on Sleep Parameters in Elite Swimmers. International Journal of Sports Physiology and Performance, 18(11), 1304-1312. https://doi.org/10.1123/ijspp.2023-0018
Sargent, C., Lastella, M., Halson, S. L., & Roach, G. D. (2021). How much sleep does an elite athlete need? International Journal of Sports Physiology and Performance, 16, 1746-1757. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34021090/
Schmid, S. R., Höhn, C., Bothe, K., Plamberger, C. P., Angerer, M., Pletzer, B. A., & Hoedlmoser, K. (2021). How Smart Is It to Go to Bed with the Phone? The Impact of Short-Wavelength Light and Affective States on Sleep and Circadian Rhythms. Clocks & Sleep, 3(4), 558–580. https://doi.org/10.3390/clockssleep3040040
Vitale, J. A., Borghi, S., Piacentini, M. F., Banfi, G., & La Torre, A. (2023). To Sleep Dreaming Medals: Sleep Characteristics, Napping Behavior, and Sleep-Hygiene Strategies in Elite Track-and-Field Athletes Facing the Olympic Games of Tokyo 2021. International journal of sports physiology and performance, 18(12), 1412–1419. https://doi.org/10.1123/ijspp.2023-0144