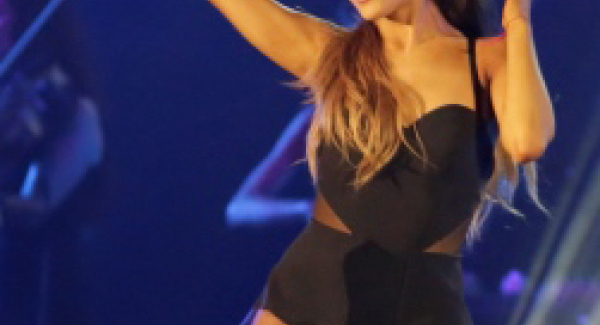“I leader migliori, mi sembra, non dicano mai ‘io’ [...]. Il fatto è che non pensano ‘io’:
pensano ‘squadra’. Sono consapevoli che il loro compito è quello di far funzionare la squadra. […]
Vi è un’identificazione con il compito e con il gruppo”. (Druncker 1992, 14).
Il fenomeno della leadership è centrale e riconoscibile in ogni ambito della vita delle persone, da quello sportivo a quello lavorativo, da quello associazionistico a quello politico. Data la costante e importante presenza della leadership nella vita sociale di ogni gruppo, in tutte le epoche storiche, le riflessioni sul ruolo di leader sono pervenute da ogni angolo della conoscenza umana, dalla filosofia alla psicologia, fino alle discipline manageriali, con il tentativo di definire come e perché proprio quell’individuo, in quel determinato momento, rivesta – o venga rivestito – del ruolo di leader (Haslam, Reicher, & Platow, 2011). In questo articolo l’attenzione sarà focalizzata sulla lettura del processo di leadership offerta da un approccio molto conosciuto e applicato in psicologia sociale e delle organizzazioni, ovvero l’approccio dell’identità sociale (vedi Glossario; Tajfel & Turner, 1979; Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987). Come si vedrà più avanti, applicare questo approccio allo studio della leadership significa considerare il processo che lega un leader ai suoi follower in termini di una definizione identitaria condivisa: in questo senso, il leader diventa l’individuo che meglio riesce ad incarnare la rappresentazione prototipica del proprio gruppo, intendendo con questa l’insieme delle caratteristiche consensualmente attribuite al gruppo, rendendone manifesta l’identità sociale. Una recente linea di ricerca sui processi di regolazione intragruppo, ovvero su quei processi che riguardano il funzionamento e lo svolgimento della vita sociale nei gruppi, ha altresì mostrato come la dimensione morale sia centrale nella definizione del sé tanto individuale quanto sociale, andando dunque a influenzare la scelta e la valutazione dei gruppi a cui si desidera appartenere (Ellemers, Pagliaro, & Barreto, 2013). Nel tentativo di coniugare questi due filoni di ricerca, di recente abbiamo dunque avanzato l’ipotesi che la valutazione di un leader, unitamente al sostegno offerto dai follower, dipenda in modo sostanziale dalla moralità attribuita al leader stesso. Nell’ultima parte di questo contributo saranno dunque presentati i risultati di questi studi recenti (Giannella, Pagliaro, & Barreto, under review).
La Psicologia della Leadership: Evoluzioni Teoriche fino all’Identità Sociale
La leadership resta uno dei fenomeni più largamente studiati in psicologia per l’indiscussa importanza nella vita sociale. Infatti, l’efficacia della leadership e delle sue relazioni con i componenti del gruppo sono cruciali per gli sviluppi positivi o negativi, per il raggiungimento degli obiettivi che tale gruppo ha, per la sua coesione, per la soddisfazione e l’identificazione dei suoi membri. E’ possibile distinguerla dall’autorità perché non impone, piuttosto si tratta di un fenomeno di influenza sociale all’interno di un gruppo, attraverso cui un individuo mobilita le risorse degli altri membri verso il raggiungimento di obiettivi comuni (Chemers, 2001; Haslam et al., 2011). Nel corso dei decenni, si sono susseguiti diversi approcci teorici nel tentativo di comprendere cosa renda un leader efficace. Le prime concettualizzazioni della leadership hanno attribuito l'efficacia del leader meramente al possesso di specifiche caratteristiche personali, che lo rendevano “un grande uomo” capace di guidare gli altri con carisma (Le Bon, 1895; Lindholm, 1990; Weber, 1946). Al di là della concettualizzazione a tratti misogina – si noti infatti che non si parla di grande persona bensì di grande uomo – in questo genere di teorizzazione non trova alcuno spazio la considerazione di aspetti sociali e contestuali. Un leader avrebbe dunque una serie di caratteristiche che lo renderebbero tale a prescindere dal contesto. Per questo motivo, sono stati poi concettualizzati modelli che hanno considerato l’efficacia della leadership come l’esito dell’interazione tra caratteristiche disposizionali del leader (per es., il fatto che un leader sia orientato al raggiungimento degli obiettivi del gruppo piuttosto che al mantenimento di un clima positivo tra i componenti del gruppo stesso) e caratteristiche contestuali (per es., il grado di difficoltà del compito) – si pensi ad esempio all’approccio della contingenza (vedi Glossario; Fiedler, 1978; Fiedler & House, 1994; Gibb, 1958).
Come anticipato in precedenza, recenti approcci alla leadership orientano la loro attenzione alla relazione leader-follower come prodotto di un’identità sociale condivisa (Haslam et al., 2011; Hogg et al., 1987). Pertanto, nell’ottica dell’approccio dell’Identità Sociale, la spiegazione del successo di un leader è legata al significato che riveste l’appartenenza ai gruppi sociali nella vita degli individui (Tajfel & Turner, 1979). La svolta teorica sta nel contestualizzare la relazione tra un leader e i suoi follower all’interno di un determinato gruppo sociale, connettendo irrevocabilmente questa relazione ai processi che avvengono al suo interno. Far parte di uno specifico gruppo contribuisce alla definizione di noi stessi, ci consente di comunicare agli altri come desideriamo essere percepiti, e modifica le aspettative che abbiamo nei nostri confronti e nei confronti degli altri. Tutto questo è possibile grazie alla tendenza del tutto spontanea a categorizzare noi stessi (e gli altri) in termini di un’appartenenza condivisa con altri membri dell’ingroup (Turner, 1982; vedi Glossario). L’ingroup al quale apparteniamo acquisisce quindi un grande potere nel definire la nostra identità: ci modifica e ci spinge a modellare noi stessi in base alle caratteristiche prototipiche del gruppo, ovvero a quelle caratteristiche che definiscono in maniera consensuale l’essenza del gruppo stesso (vedi Glossario; Turner et al., 1987; Turner, Oakes, Haslam & McGarty, 1994). Sulla base di quanto detto, un componente del gruppo che è capace di rappresentare le caratteristiche fondamentali per il gruppo, ovvero di incarnare con il suo comportamento i valori, le norme e gli ideali del gruppo stesso, sarà anche in grado di influenzare gli altri componenti in misura maggiore rispetto a uno che viene percepito come meno rappresentativo.
Molti studi hanno confermato questa ipotesi: sembra infatti che l'efficacia della leadership dipenda dalla capacità del leader di rappresentare le caratteristiche prototipiche del gruppo e promuovere l'identità condivisa. I lavori all'interno dell'approccio dell'identità sociale alla leadership mostrano che l’influenza di un determinato componente del gruppo sugli altri varia in funzione alla sua prototipicità rispetto all’ingroup (Fielding & Hogg, 1997; McGarty, Turner, Hogg, David, & Wetherell, 1992; van Knippenberg, Lossie e Wilke, 1994; van Knippenberg e Wilke, 1992). Per tale ragione, un leader percepito come più prototipico viene valutato positivamente dai seguaci, in particolare da coloro che sono altamente identificati con il loro gruppo (Fielding & Hogg, 1997). Il suo potere deriva dalla capacità di rappresentare l'identità di gruppo e dalla promozione di standard e valori legati a questa identità.
A conferma di questo, la ricerca ha dimostrato che un leader prototipico riceve maggior fiducia perché è percepito dai suoi seguaci come avente a cuore l'interesse del gruppo (van Knippenberg & Hogg, 2003; van Knippenberg & van Knippenberg, 2005) e questo aumenta la sua capacità di influenza (Giessner & van Knippenberg, 2008; Gleibs & Haslam, 2016; Platow & Van Knippenberg, 2001; van Knippenberg, 2011).
Dunque, si dimostra che la leadership, lungi dall’essere il prodotto di mere caratteristiche individuali o dell’interazione tra queste e alcuni aspetti del contesto, è a tutti gli effetti un processo di gruppo che radica le sue origini nelle identità collettive condivise (Ellemers, De Gilder e Haslam, 2004; Haslam & Platow, 2001; Haslam, et al., 2011; Hogg, 2001; Hogg & van Knippenberg, 2003; Turner & Haslam, 2001) e si conferma che, affinché sia efficace, è fondamentale che il leader rappresenti il gruppo, i suoi valori fondamentali e il suo carattere distintivo positivo. Quali sono, dunque, le caratteristiche maggiormente rappresentative di un gruppo? Quali quelle che consentono di rappresentare al meglio i valori e il carattere distintivo del gruppo stesso? Una linea di ricerca recente sembra avere identificato nella moralità la risposta a questi interrogativi.
L’Importanza della Moralità nei Processi di Gruppo
Nell’ultima decade, molti ricercatori hanno indagato l’impatto di diverse dimensioni valutative sulle percezioni e sui comportamenti delle persone. In particolare, partendo da un’evoluzione del modello a due fattori (ovvero, calore e competenza; vedi Glossario) formulato da Fiske, Cuddy, Glick e Xu (2002), diversi autori hanno esaminato il ruolo che le tre dimensioni di moralità, socievolezza e competenza rivestono nella percezione sociale e nei comportamenti degli individui (Leach, Ellemers, & Barreto, 2007). Questo filone di studi sembra evidenziare che la moralità rappresenta la dimensione più importante per la valutazione positiva di sé stessi e del proprio gruppo (Leach et al., 2007) e sembra diventare la base più solida per l’identificazione con il gruppo stesso, nonché per la regolazione delle condotte all’interno di esso e tra gruppi differenti (Ellemers et al, 2013). Ellemers e van den Bos (2012) hanno riassunto i risultati di questi studi in un modello teorico che evidenzia tre diverse funzioni regolatrici che la moralità può assolvere. In questo modello, la moralità a) svolge una funzione di definizione dell'identità, fornendo elementi informativi su chi siamo e su quali sono i gruppi a cui desideriamo appartenere; b) regola le dinamiche dell’ingroup, consentendo ai membri di un gruppo di coordinare il proprio comportamento attraverso le norme sociali e, infine, c) svolge una funzione di regolazione intergruppi, permettendo di gestire e interpretare le differenze di gruppo e le situazioni conflittuali fra i gruppi stessi (Ellemers e van den Bos, 2012).
Se dunque la moralità è un così importante regolatore delle dinamiche di gruppo, è possibile ipotizzare che anche l’efficacia del processo di leadership sia legata in modo imprescindibile alla valutazione morale che i follower fanno del leader stesso? Se la percezione di prototipicità di un leader è data dalla sua capacità di incarnare i valori fondamentali del gruppo che guida, e se la moralità rappresenta un nucleo valutativo centrale nella definizione individuale e sociale delle persone, è allora ipotizzabile che la valutazione morale di un leader contribuisca alla percezione della sua prototipicità e di conseguenza al sostegno che riceve dai follower? Vediamo di seguito i risultati di alcuni studi che sembrano confermare questa ipotesi.
L’Importanza della Moralità nella Relazione Leader-Follower
Alcuni studi hanno rintracciato evidenze indirette circa l’importanza della moralità nella valutazione e nell’efficacia di un leader, mostrando che l'integrità comportamentale di un leader - ovvero la misura in cui un leader mantiene le promesse e mette in atto i valori del gruppo - stimola l'impegno e aumenta le prestazioni dei suoi componenti (Leroy, Palanski, & Simons, 2012; Palanski & Yammarino, 2011). Inoltre, solo per citare un altro esempio, Brown, Treviño e Harrison (2005) hanno sviluppato uno strumento di misurazione della leadership etica, che correla positivamente con la fiducia nella leadership, l'efficacia percepita della leadership, la soddisfazione che sviluppano i seguaci, la dedizione che i leader dimostrano al lavoro e la tendenza dei follower a segnalare problemi alla direzione.
Stimolati da questi risultati, nel tentativo di coniugare l’approccio dell’identità sociale alla leadership con le evidenze sopra citate circa il ruolo della moralità nella regolazione intragruppo, abbiamo condotto una serie di studi sperimentali (su campioni di convenienza) e correlazionali (su lavoratori reali; Giannella et al., under review). L’ipotesi sottesa a questi studi era che la moralità (più della competenza) rappresentasse la base primaria della percezione di prototipicità di un leader e che questa poi si riverberasse sulle intenzioni di sostenere il leader in futuro. Negli studi sperimentali, abbiamo dunque manipolato il comportamento passato di un leader, presentando ai partecipanti informazioni circa la moralità e la competenza di questi comportamenti, e successivamente abbiamo rilevato il grado in cui il leader veniva percepito come un membro prototipico del gruppo e il grado di sostegno nel futuro. I risultati di tali studi hanno confermato la predominanza della dimensione morale nelle valutazioni dei follower e nel sostegno al leader, rispetto alla dimensione della competenza legata alla leadership. Le percezioni che i partecipanti esprimevano risultavano essere più positive quando il leader si comportava in modo morale, rispetto a quando si comportava in modo competente. Inoltre, se il leader si comportava in modo immorale, allora veniva percepito come meno prototipico, rispetto a quando si dimostrava essere incompetente. Il leader immorale veniva percepito anche come più minaccioso per la reputazione del gruppo, rispetto al leader incompetente. Queste informazioni influenzavano, così, le intenzioni dei follower di sostenere e riconfermare il leader nel futuro. In un follow up di questi studi abbiamo invece presentato informazioni divergenti circa la moralità e la competenza del leader: in una condizione veniva descritto come morale ma incompetente e in un’altra come competente ma immorale. Di fronte a questa divergenza, le reazioni dei follower erano ancora una volta guidate dalle informazioni circa la moralità del leader, a prescindere dalla sua competenza. Nel tentativo poi di fornire una maggior validità ecologica a questi risultati, abbiamo condotto studi correlazionali sulle percezioni di lavoratori reali in merito al proprio leader. In questo caso, tanto la percezione di moralità quanto quella di competenza del leader erano in relazione con la valutazione positiva di un leader e dell’azienda nel suo complesso: tuttavia, attraverso analisi statistiche specifiche (i.e., correlazioni parziali; vedi Glossario) siamo riusciti a dimostrare che la moralità di un leader è legata alla valutazione positiva dei follower a prescindere dalla competenza attribuita al leader stesso, un risultato apparentemente controintuitivo visto il peso che comunemente si attribuisce alla competenza in ambito manageriale.
Conclusioni
La comprensione del processo che lega un leader ai suoi follower è di fondamentale importanza in psicologia dei gruppi e delle organizzazioni. L’approccio dell’identità sociale, in questo senso, offre un supporto teorico di grande interesse per concettualizzare il rapporto tra questi due attori sociali come costruzione e mantenimento di un’identità sociale condivisa, dotata di significati simbolici e conseguenze affettive. Coniugando questo approccio con gli studi che hanno indagato l’effetto di diverse dimensioni valutative sulle percezioni e sui comportamenti delle persone, abbiamo tentato di mostrare che anche nel processo di leadership le valutazioni morali giocano un ruolo determinante sulla valutazione e sul sostegno da parte dei follower. Questo non vuol dire in alcun modo che la moralità sia l’unica dimensione importante nella formazione dei giudizi e nell’efficacia della leadership. Qualora fosse così, non avremmo così bisogno come invece abbiamo di competenza e professionalità alla guida delle organizzazioni. I risultati, invece, indicano che gli effetti dei possibili fallimenti dei leader sulle valutazioni dei follower sono più negativi quando intaccano la dimensione morale. Certamente entrambe producono valutazioni negative, entrambe producono una minore percezione di prototipicità e una maggiore minaccia reputazionale e certamente entrambe diminuiscono le intenzioni a sostenere il leader; ma le evidenze dimostrano che la moralità ne influenza gli effetti con maggior potenza e quindi si presuppone che i membri di un gruppo siano molto più attenti a come un leader si comporta nell’ambito della dimensione morale.
L’esito di questi studi e, in generale, del ragionamento proposto in questa sede ha delle implicazioni pratiche importanti in ambito aziendale e in altri ambiti applicativi (come ad esempio l’ambito politico), suggerendo che per avere successo e per produrre i cambiamenti desiderati, un leader deve essere percepito come membro prototipico di un gruppo, ne deve rappresentare i valori, l’etica e la morale, deve comportarsi in modo da non tradirne gli aspetti identitari centrali per non minare la reputazione del gruppo, per essere sostenuto e per produrre comportamenti positivi tra i membri.
Glossario
Approccio della Contingenza. Classe di teorie che spiegano un particolare processo (per esempio la leadership o il potere) nei termini dell’interazione tra la personalità di un individuo e le caratteristiche dell’ambiente in cui egli opera.
Approccio dell’Identità Sociale. Approccio teorico che comprende la Teoria dell’Identità Sociale (SIT; Tajfel & Turner, 1979) e la Teoria della Categorizzazione del Sé (SCT; Turner et al., 1987). L’approccio ritiene che una parte fondamentale dell’identità delle persone sia legata all’appartenenza ai gruppi sociali: la valenza positiva o negativa di questa identità è legata al contesto sociale di riferimento, in particolare all’esito di processi di confronto sociale con gruppi diversi dal proprio (o outgroup). Nella elaborazione cognitiva della SCT, si teorizza che il contesto renda saliente il livello di categorizzazione (individuale, sociale o umano).
Correlazione parziale. Analisi per la correlazione fra due variabili (X e Y) al netto di una terza (K). Si può quindi esprimere attraverso il coefficiente di correlazione tra due variabili da cui è stato depurato l’effetto delle altre variabili.
Ingroup. Si definisce ingroup qualsiasi gruppo al quale un individuo appartiene, per distinguerlo dai gruppi ai quali invece non appartiene, definiti outgroup.
Modello a due fattori o Modello del Contenuto degli Stereotipi (SCM). Prevede l’esistenza di due principali dimensioni su cui si fonda la percezione sociale: competenza (rappresentata da tratti come ad esempio l’intelligenza) e calore (rappresentato da tratti come ad esempio la socievolezza o la moralità), che sono influenzate rispettivamente dallo status del gruppo e dalla competizione intergruppi. La combinazione della presenza o meno di competenza e calore elicita diverse emozioni verso l’outgroup.
Prototipo. Un prototipo è l’esempio più rappresentativo di una determinata categoria sociale. Ad esempio, per definire la categoria sociale Italiani si potrebbe far riferimento a un prototipo come Alberto Sordi.
Bibliografia
Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 97, 117−134.
Ellemers, N., De Gilder, D., & Haslam, S. A. (2004). Motivating individuals and groups at work: A social identity perspective on leadership and group performance. Academy of Management Review, 29, 459–478.
Ellemers, N., Pagliaro, S., & Barreto, M. (2013). Morality and behavioural regulation in groups: A Social Identity Approach. European Review of Social Psychology, 24, 160-193.
Ellemers, N. & van den Bos, K. (2012). Morality in groups: On the social-regulatory functions of right and wrong. Social and Personality Psychology Compass, 6, 878- 889.
Fielding, K.S. & Hogg, M.A. (1997). Social identity, self-categorization, and leadership: A field study of small interactive groups. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 1, 39-51.
Chemers, M. M. (2001). Efficacy and effectiveness: Integrating models of leadership and intelligence. In R. E. Riggio & S. E. Murphy (Eds.), Multiple intelligences and leadership (pp. 139–160). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Cooper, C. L., & Robertson, I. T. (Eds.). Key reviews in managerial psychology. New York, Wiley.
Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., Glick, P., & Xu, J. (2002). A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 878-902.
Giannella, V.A., Pagliaro, S. & Barreto, M. (under review). Morality as a Fundamental Dimension of Leaders’ Evaluation and Endorsement.
Gibb, C. A. (1958). An interactional view of the emergence of leadership. Australian Journal of Psychology, 10, 101-110.
Haslam, S. A. & Platow, M. J. (2001). The link between leadership and followership: How affirming social identity translates vision into action. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 1469–1479.
Haslam, S. A., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2011). The New Psychology of Leadership: Identity, Influence and Power. Hove-New York, Psychology Press.
Hogg, M. A. (2001). A social identity theory of leadership. Personality and Social Psychology Review, 5, 184–200.
Hogg, M. A. & van Knippenberg, D. (2003). Social identity and leadership processes in groups. Advances in Experimental Social Psychology, 35, 1–52.
Leach, C. W., Ellemers, N., & Barreto, M. (2007). Group virtue: the importance of morality (vs. competence and sociability) in the positive evaluation of in-group. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 234-249.
Le Bon, G. (1895). Psychologie des foules. Paris, F. Alcan.
Leroy, H., Palanski, Y., & Simons, T. (2012). Authentic leadership and behavioural integrity as drivers of follower commitment and performance. Journal of Business Ethics, 107, 255-264.
Lindholm, C. (1990). Charisma. Oxford: Blackwell.
McGarty, C., Turner, J. C., Hogg, M. A., David, B. & Wetherell, M. S. (1992). Group polarization as conformity to the prototypical group member. British Journal of Social Psychology, 31, 1-20.
Palanski, M. E. & Yammarino, F. J. (2011). Impact of behavioural integrity on follower job performance: A three-study examination. Leadership Quarterly, 22, 765-786.
Tajfel, H. & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, CA, Books/Cole.
Turner, J. C. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. In H. Tajfel (a cura di), Social identity and intergroup relations (pp. 15-40). Cambridge, Cambridge University Press.
Turner, J. C. & Haslam, S. A. (2001). Social identity, organizations and leadership. In M. E. Turner (Ed.), Groups at work: Advances in theory and research (pp. 25–65) Hillsdale, NJ: Erlbaum, Chicago: Nelson-Hall Publishing.
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford: Blackwell.
Turner, J. C., Oakes, P.J., Haslam, S.A. & McGarty, C.A. (1994). Self and collective: Cognition and social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 454-463.
van Knippenberg, B. & van Knippenberg, D. (2005). Leader self- sacrifice and leadership effectiveness: The moderating role of leader prototypicality. Journal of Applied Psychology, 90, 25–37.
van Knippenberg, D. & Hogg, M. A. (2003). A social identity model of leadership effectiveness in organizations. In B. M. Staw and R. M. Kramer (Eds.). Research in organizational behavior (Vol. 25, pp. 243–295). Amsterdam: Elsevier.
van Knippenberg, D., Lossie, N., & Wilke, H. (1994). In-group prototypicality and persuasion: Determinants of heuristic and systematic message processing. British Journal of Social Psychology, 33, 289-300.
van Knippenberg, D., & Wilke, H. (1992). Prototypicality of arguments and conformity to ingroup norms. European Journal of Social Psychology, 22, 141-155.
Weber, M. (1946). The sociology of charismatic authority (1921). In H. H. Gerth & C. W. Milles (Eds.), Max Weber: Essays in sociology (pp. 245-252). New York, Oxford University Press.