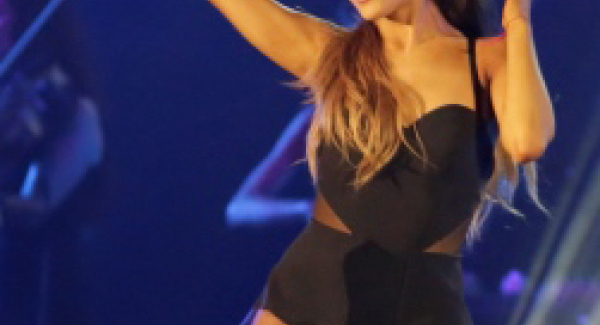"La gente non ha vie di mezzo, proprio come la malattia.
O ti sostiene al massimo, o ti affonda"
Francesca, utente di Instagram.
Introduzione
Le parole di Francesca, una delle tante ragazze affette da disturbi del comportamento alimentare che cercano supporto online. Queste parole comunicano in maniera diretta lo stato d’animo comune a chi cerca sostegno su Instagram, dove ideali di bellezza irrealistici si confondono con la realtà, fatta di piccoli traguardi e fallimenti, durante la fase di guarigione. Come succedeva con i forum, durante la prima epoca del web, anche all’interno dei social network sono nate comunità di sostegno attraverso le quali persone che soffrono dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) offrono e ricevono sostegno da altri individui nella medesima condizione.
A questo proposito, la letteratura sui DCA ha esplorato gli effetti positivi e negativi derivanti dall’utilizzo dei social media, ma il dibattito rimane ancora aperto. Il presente lavoro vuole quindi offrire una panoramica dello stato della ricerca in ambito psicosociale rispetto alla relazione tra l’utilizzo dei social media e i DCA.
Pochissimi studi hanno infatti analizzato i meccanismi derivanti dai social media nell’ostacolare o nel supportare il percorso di guarigione. Nonostante l’ampia diffusione dei social e il proliferare di fotografie legate al cibo su Instagram, la questione riguardante il loro utilizzo e i DCA, rimane ad oggi ancora da chiarire.
Social media, ideali di bellezza e disturbi del comportamento alimentare
Una delle rivoluzioni che è stata possibile grazie allo sviluppo del web è quella rappresentata dai social media (Kaplan & Haenlein, 2010) Fra questi, i social network hanno attirato maggiormente l’interesse delle scienze sociali. Essi consentono alle persone di interagire fra di loro, portando alla nascita di vere e proprie comunità online (Riva, 2010), innalzando la rete ad un ambiente in cui coltivare relazioni sociali spesso significative per la sfera personale (McKenna & Green, 2002; McKenna, Green, & Gleason, 2002). Proprio grazie a questa caratteristica, unitamente al bisogno di supporto e approvazione da parte degli altri, i social network hanno favorito negli ultimi anni la nascita di gruppi online di sostegno per persone affette da DCA. Questo tipo di disturbi è caratterizzato da una persistente alterazione dell’alimentazione, o da comportamenti collegati ad essa, che determinano un alterato consumo del cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale dell’individuo (DSM 5, 5th ed.; American Psychiatric Association, 2013). In particolare, l’anoressia e la bulimia nervose sono tra i DCA più conosciuti e più frequenti. La caratteristica principale dell’anoressia nervosa è il mantenimento del proprio peso corporeo al di sotto di quello minimo normale per età, genere, percorso di sviluppo e salute fisica (DSM 5, 5th ed.; American Psychiatric Association, 2013), un’intensa paura di aumentare il grasso corporeo e disturbi nella percezione del proprio peso e forma corporea. La bulimia nervosa è invece caratterizzata da episodi ricorrenti di ingestione e il frequente ricorso a condotte compensatorie inappropriate per prevenire l’aumento di peso (come vomito autoindotto, uso improprio di lassativi e diuretici; Crowther, Sanftner, Bonifazi, & Shepherd, 2001).
Diversi studi suggeriscono come i mass media favoriscano la diffusione di ideali di bellezza legati alla magrezza. Infatti, sono coloro che guardano di più la televisione ad essere maggiormente predisposti all’interiorizzazione dei messaggi culturali relativi alla magrezza e a sentirsi quindi meno soddisfatti del proprio corpo (Fouts & Vaughan, 2002; Stice & Hoffman, 2004). Questo confronto si traduce in un aumento del livello di insoddisfazione corporea (Botta, 1999; Tiggemann & McGill, 2004; Tiggeman & Slater, 2004). La relazione tra mass media e soddisfazione corporea non riguarda soltanto le persone affette da DCA ma influenza lo stile di vita di buona parte delle persone. La ricerca suggerisce infatti che l’influenza dei media agisca sulla percezione del proprio corpo attraverso due possibili meccanismi: l’interiorizzazione degli ideali di bellezza imposti della società e un maggiore confronto del proprio aspetto fisico con quello degli altri (Thompson, Heinberg, & Altabe, 1999; Van den Berg, Thompson, Obremski-Brandon, & Coovert, 2002) facilitando così una maggiore insoddisfazione per il proprio aspetto fisico (Grabe, Ward, & Hyde, 2008; Groesz, Levine, & Murnen, 2002)
A tal proposito, il gran numero di immagini che vengono pubblicate sui social media (Mayer-Schonberger & Cukier, 2013) offre opportunità frequenti per gli utenti di mettere in atto confronti sociali legati all'aspetto favorendo così un'immagine negativa e oggettivata del proprio corpo (Myers & Crowther, 2009).
Il social network che ha fatto della pubblicazione di fotografie il proprio punto di forza è senza dubbio Instagram. Con oltre un miliardo di utenti attivi nel 2019 (Statista, 2019), Instagram è infatti uno fra i più popolari social network. I contenuti condivisi dagli utenti vengono descritti attraverso specifici marcatori basati su parole chiave, detti hashtag e preceduti dal simbolo “#”. È possibile esprimere apprezzamento o interesse per foto e video attraverso l’ormai consolidato meccanismo dei like (Hu, Manikonda, & Kambhampati, 2014).
La ricerca nell’ambito degli effetti dei media suggerisce che l’utilizzo di Instagram, proprio perché basato sulla fruizione di contenuti fotografici, possa avere effetti negativi sulla percezione del proprio aspetto fisico (Fardouly & Vartanian, 2016; Holland & Tiggemann, 2016). Nonostante Instagram abbia visto una rapida crescita da quando è nato (Ottobre 2010), solo recentemente ha attirato l’attenzione della comunità scientifica (Hu et al., 2014).
Scegliere da che parte stare è prima di tutto una questione di hashtag
Uno dei temi più popolari su Instagram è quello del cibo (Mejova, Abbar, & Haddadi, 2016). A tale proposito infatti, uno degli hashtag più popolari è proprio l'hashtag #foodporn spesso accompagnato da un primo piano di un piatto o di un alimento (Mejova et al., 2016). Questo particolare hashtag affonda le proprie radici in una tradizione nata agli inizi degli anni ‘80 con la nascita delle prime trasmissioni televisive legate alla cucina (Mejova et al., 2016). Il caso dell’hashtag #foodporn, con oltre 210 milioni di post nel 2019, è particolarmente rilevante se considerato rispetto all’influenza dei media sul nostro comportamento. Infatti, così come la pornografia contribuisce ad una visione distorta della sessualità (Rousseau, 2014), anche i contenuti legati a questa parola chiave possono avere connotazioni negative rispetto al consumo di cibo. Infatti, l’hashtag #foodporn è associato per lo più a cibo ad alto contenuto di zuccheri e di calorie, promuovendo un rapporto non salutare con l'alimentazione e con il proprio corpo (Mejova et al., 2016). L’importante non è immortalare piatti necessariamente salutari, l’essenziale è che siano belli da guardare.
Rispetto a questa tematica, risulta preoccupante il fenomeno emergente degli hashtag relativi ai comportamenti alimentari problematici diffusi fra gli utenti di Instagram. Esistono infatti specifiche parole chiave per la promozione e l’esaltazione di comportamenti di natura anoressica o bulimica, come ad esempio #proana e #promia (rispettivamente abbreviazioni di pro-anoressia e pro-bulimia), dietro alle quali nascono e si sviluppano vere e proprie comunità virtuali di utenti (Cavazos-Rehg et al., 2019). Un recente studio (Bert, Gualano, Camussi, & Siliquini, 2016) indica che la maggior parte degli utenti di queste comunità online sono ragazze adolescenti (circa il 98%) con un’età media di 17-18 anni. I contenuti identificati con questi specifici hashtag sono legati a foto di ragazze affette da anoressia come modelli da seguire (le cosiddette “thinspiration”), sfide al digiuno, slogan motivazionali in cui gli utenti si incoraggiano vicendevolmente a non mangiare, con l’obiettivo di perdere peso, ma anche suggerimenti su come nascondere il problema a familiari e amici.
In seguito ad una serie di segnalazioni, recentemente Instagram ha introdotto delle politiche per il divieto di utilizzo di marcatori che promuovono comportamenti alimentari problematici. Tuttavia, in letteratura c'è disaccordo sull’efficacia della censura di queste comunità, che possono essere gli unici spazi in cui persone affette da questo tipo di disturbi si sentono libere di condividere le proprie esperienze (Casilli, Pailler, & Tubaro, 2013). Esistono anche hashtag attorno ai quali nascono gruppi che promuovono e sostengono percorsi di guarigione e supporto psicologico alle persone affette da DCA, le quali gestiscono la propria salute e il processo di guarigione anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali (LaMarre & Rice, 2017). È probabilmente la mancanza di comprensione nel mondo reale, insieme allo stigma associato ai DCA, che motiva gli individui a cercare ambienti sociali alternativi in cui ottenere supporto (Linville, Brown, Sturm, & McDougal, 2012; Ransom, La Guardia, Woody, & Boyd, 2010; Williams & Riley, 2013).
Un esempio in questo senso è rappresentato da un gruppo nato spontaneamente su Instagram, in cui persone accomunate dal desiderio di guarire condividono tra di loro consigli ed esperienze, con l’obiettivo di sostenersi durante il percorso di guarigione. La maggior parte dei post pubblicati all’interno di questa comunità riguarda foto di piatti pronti per essere mangiati, accompagnati dalla condivisione di pensieri, paure e ansie rispetto al superamento della malattia. La parola d’ordine, o meglio l’hashtag d’ordine, che viene più frequentemente abbinato a questi post è #recovery (circa 12 milioni di post nel 2019) ma anche altre parole chiave come #recoverywarrior e #eatingdisordersrecovery. La comunità Instagram sviluppata attorno a questo hashtag utilizza una logica di sollecitazione continua alla partecipazione dei singoli membri, con un costante posting di foto di cibo.
L’appetito vien postando, o forse non è così?
I pionieristici studi di McKenna e Bargh (1998) sulle dinamiche delle relazioni interpersonali online mostrano come gli ambienti online consentono di interagire con altre persone rimanendo nell’anonimato. La formazione di gruppi online diventa così un’opportunità, per coloro che vivono uno stigma, di rifugiarsi all’interno di un ambiente sicuro per l’espressione del sé. L'appartenenza a questi gruppi virtuali diventa così una parte importante dell'identità (McKenna & Bargh, 1998).
Partendo da questa considerazione, LaMarre e Rice (2017) hanno analizzato 1056 immagini relative al percorso di guarigione dai DCA pubblicate su Instagram e accompagnate dagli hashtag #EDrecovery, #eatingdisordersrecovery, #anorexiarecovery. #bulimiarecovery e #recoverywarrior per cercare di approfondire le rappresentazioni dei DCA sulla rete. La maggior parte delle immagini analizzate riguardavano il cibo. Questo aspetto potrebbe essere dovuto semplicemente ad un incremento generalizzato delle rappresentazioni di cibo sui siti di social media (Holmberg, Chaplin, Hillman, & Berg, 2016). Tuttavia, da una analisi più accurata, è emerso che le fotografie pubblicate sottolineavano soprattutto gli aspetti della fase di guarigione (LaMarre & Rice, 2017) suddivise in quattro differenti categorie semantiche: 1) “uno spettacolo per gli occhi”, ovvero insegnamenti su “come mangiare in modo sano” 2) “corpo del reato”, ovvero fotografie del cambiamento corporeo durante il periodo di guarigione 3) “citazioni”, ovvero citazioni che invitano alla cura della propria salute e 4) “Im(perfezione)”, ovvero fotografie in cui gli utenti analizzano la normalità nei loro schemi alimentari e stili di vita. LaMarre e Rice (2017) suggeriscono che documentare il processo di guarigione attraverso l’attività di posting frequente possa essere un modo di monitorare i propri progressi e interagire con altre persone che condividono i propri sforzi e sfide.
Similmente, McNamara e Parsons (2016) hanno analizzato le conversazioni di un gruppo di supporto online per indagare i processi di identificazione che si verificano in questi ambienti virtuali. Va sottolineato come il processo di guarigione richieda una rivalutazione di credenze e valori, l’abbandono dei comportamenti alimentari disfunzionali (Abbate-Daga, Amianto, Delsedime, De-Bacco, & Fassino, 2013; Bowlby, Anderson, Hall, & Willingham, 2015) e l’interiorizzazione di un’identità orientata alla guarigione (Best, Beckwith, Haslam, Haslam, Jetten, Mawson, & Lubman, 2016). Secondo gli autori, l'identità condivisa durante il percorso di guarigione, veicolata attraverso il senso di appartenenza a gruppi virtuali online può favorire il processo di guarigione e di ripresa.
Nonostante queste prime evidenze incoraggianti, gli effetti positivi dell’appartenenza ad una comunità virtuale di sostegno ai disturbi del comportamento alimentare sono stati spesso messi in discussione. Da una ricerca condotta da Mabe, Forney e Keel (2014) è emerso che le persone che trascorrevano più tempo su Facebook tendevano anche a riportare maggiori sintomi legati ai DCA. In diverse ricerche (Fardouly & Vartanian, 2015; Tiggemann & Miller, 2010; Tiggemann & Slater, 2013, 2014; Vandenbosch & Eggermont, 2012) viene evidenziato come spendere molto tempo sui social network sia associato a un aumento nella vigilanza del proprio corpo, una maggiore interiorizzazione degli ideali di magrezza, maggiori confronti del proprio aspetto fisico e un decremento della soddisfazione per il proprio peso. Tuttavia, altri studi (Cohen, Newton-John, & Slater, 2017; McLean, Paxton, & Wertheim, 2015; Meier & Gray, 2014) suggeriscono che non sia tanto la quantità di tempo spesa sui social ad incentivare maggiori preoccupazioni per la propria immagine corporea, quanto invece sia la specificità delle attività che si svolgono online a determinarne l’aumento. Condivisione e pubblicazione di fotografie legate al corpo, seguire account che si concentrano sull’aspetto fisico, selezionare e modificare i propri selfie prima della pubblicazione, sono tutte attività associate ad una maggiore preoccupazione per la propria immagine corporea nelle giovani donne (Cohen et al., 2017, 2018; McLean et al., 2015; Meier & Gray, 2014).
Per approfondire la relazione fra utilizzo dei social media e i comportamenti alimentari Eikey e Booth (2017) hanno condotto una ricerca qualitativa attraverso interviste semi-strutturate, per analizzare l’utilizzo da parte di alcune ragazze di diverse piattaforme online, tra cui Instagram. I risultati sono tuttavia ambivalenti. Infatti, traspare come questo particolare social media favorisca una maggiore consapevolezza degli utenti riguardo il proprio disturbo, diminuendo la minaccia dello stigma sociale ad esso associato. Allo stesso tempo però la medesima piattaforma social veniva descritta dalle partecipanti come uno strumento nocivo, in grado di innescare continui confronti che contribuivano ad un maggiore senso di inadeguatezza e di immobilità di fronte al percorso di guarigione.
Social media e DCA: direzioni future di ricerca
Il ruolo dei social media come strumento di supporto durante il processo di guarigione dai DCA rimane una questione aperta. Alcuni studi sottolineano conseguenze negative (Fardouly & Vartanian, 2015; Mabe, et al., 2014; Tiggemann & Slater, 2013, 2014) mentre altri suggeriscono che la formazione di un’identità di guarigione condivisa rappresenti un fattore di protezione e supporto (McNamara & Parsons, 2016). Se da un lato, piattaforme come Instagram favoriscono la consapevolezza della propria condizione e una diminuzione dello stigma sociale, dall’altro è plausibile ipotizzare anche il processo opposto. Infatti, l’identificazione con un gruppo virtuale di supporto alla guarigione, potrebbe mantenere salienti gli aspetti negativi della malattia attraverso il continuo confronto con gli altri membri, esacerbandone così i sintomi (Eikey & Booth, 2017; Gurrieri, Lauren, & Jenna Drenten, 2019).
Il confronto sociale con altri utenti della community potrebbe rappresentare un fattore di rischio per chi soffre di DCA. La teoria del confronto sociale (Festinger, 1954) suggerisce che le persone hanno una spinta innata a confrontarsi con gli altri, sia con persone che riteniamo migliori (confronti verso l’alto) che con individui ritenuti peggiori (confronti verso il basso). Studi precedenti hanno già messo in luce infatti come avere una maggiore propensione a confrontare il proprio aspetto con gli altri, indipendentemente dalla direzione del confronto, possa essere associata a esiti negativi come maggiore insoddisfazione corporea e sviluppo di DCA (Fardouly, Diedrichs, Vartanian, & Hailliwell, 2015; Halliwell & Harvey, 2006; Keery van den Berg, & Thompson, 2004). Proprio le occasioni di confronto sociale potrebbero risultare particolarmente frequenti nelle comunità Instagram legate all’hashtag #recovery, disincentivando così il processo di guarigione dalla malattia (Myers & Crowther, 2009). Data l’inarrestabile crescita nell’utilizzo dei social media, risulta rilevante ampliare la ricerca in questo ambito con studi sperimentali per verificare il ruolo dei contenuti fotografici legati ad hashtag come #recovery nel favorire il ruolo del confronto sociale rispetto al processo di guarigione dai DCA.
Inoltre, la maggior parte degli studi presenti in letteratura considerano solamente campioni composti da ragazze e donne. L’idea che i DCA riguardino per lo più la popolazione femminile, deriva da caratteristiche specifiche dei disturbi che spesso non vengono riscontrate nei pazienti di genere maschile. Questo ha portato a preferire campioni femminili negli studi (Murray, Griffiths, & Mond, 2016) e al conseguente sviluppo di test diagnostici e terapeutici orientati maggiormente alle donne. Tuttavia, studi recenti dimostrano che, nel corso degli ultimi vent’anni, l’incidenza dei DCA nella popolazione maschile è quadruplicata (Hudson, Hiripi, Pope, & Kessler, 2007). Per avere un quadro completo, è necessario quindi che la ricerca allarghi i propri orizzonti ed inizi ad indagare quali siano i fattori che favoriscono i DCA anche nella popolazione maschile.
L’analisi della letteratura spinge a riflettere sul ruolo che i social media, e in particolare Instagram, giocano all’interno del processo di guarigione dai disturbi del comportamento alimentare e su come l’utilizzo di tali mezzi debba essere considerato anche da chi si occupa di questi disturbi durante il periodo di riabilitazione.
Glossario
Hashtag: l’hashtag è il simbolo del cancelletto (#) che viene solitamente associato a una o più parole chiave all’interno di un contenuto pubblicato da un utente sulle pagine di un social network per facilitare le ricerche da parte di altri utenti ma anche per descriverne in maniera sintetica i contenuti fotografici o testuali.
Instagram: Instagram è un social network che permette agli utenti di condividere prevalentemente contenuti fotografici e video direttamente dall’applicazione mobile. Le relazioni fra gli utenti sono unidirezionali, ovvero un utente può seguire il profilo di un altro utente senza che quest’ultimo necessariamente segua gli aggiornamenti del profilo del primo. Instagram deve la sua iniziale popolarità all’introduzione di particolari filtri fotografici applicabili ai propri scatti.
Gruppo di supporto: gruppo di persone che si aiutano reciprocamente in diverso modo in relazione a una caratteristica condivisa, in genere un disagio psicologico, emotivo o comportamentale.
Postare o posting: Nel gergo del web, postare significa pubblicare qualcosa online. Questo neologismo deriva dal verbo inglese “to post”, che letteralmente significa «mettere nella posta, imbucare». Il termine è diventato di uso comune ed è ormai entrato anche nella lingua italiana, tanto che l’enciclopedia Treccani definisce l’azione di postare come “affiggere, impostare un messaggio in un blog o in un sito di discussione della rete telematica”.
Social media: I social media sono particolari applicazioni web basate sulle tecnologie e sulle infrastrutture tecnologiche del cosiddetto Web 2.0, che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti. In questo modo i navigatori del web, da semplici consumatori di informazione (come avveniva nella prima generazione del Web 1.0) divengono produttori di contenuti.
Bibliografia
Abbate-Daga, G., Amianto, F., Delsedime, N., De-Bacco, C., & Fassino, S. (2013). Resistance to treatment and change in anorexia nervosa: A clinical overview. BMC Psychiatry, 13, 294–311.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Bert, F., Gualano, M. R., Camussi, E., & Siliquini, R. (2016). Risks and threats of social media websites: twitter and the Proana movement. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 19(4), 233-238.
Best, D., Beckwith, M., Haslam, C., Haslam, A. S., Jetten, J., Mawson, E., & Lubman, D. I. (2016). Overcoming alcohol and other drug addiction as a process of social identity transition: The social identity model of recovery (SIMOR). Addiction Research & Theory, 24(2), 111-123.
Botta, R. A. (1999). Television images and adolescent girls' body image disturbance. Journal of communication, 49(2), 22-41.
Bowlby, C. G., Anderson, T. L., Hall., M. E. L., & Willingham, M. M. (2015). Recovered professionals exploring eating disorder recovery: A qualitative investigation of meaning. Clinical Social Work Journal, 43, 1–10.
Casilli, A., Pailler, F., & Tubaro, P. (2013). Online networks of eating-disorder websites: Why censoring pro-ana might be a bad idea. Perspectives in Public Health, 133(2), 94-95.
Cavazos-Rehg, P. A., Krauss, M. J., Costello, S. J., Kaiser, N., Cahn, E. S., Fitzsimmons-Craft, E. E., & Wilfley, D. E. (2019). “I just want to be skinny.”: A content analysis of tweets expressing eating disorder symptoms. PloS one, 14(1), e0207506.
Cohen, R., Newton-John, T., & Slater, A. (2017) The relationship between Facebook and Instagram appearance-focused activities and body image concerns in young women. Body Image, 23, 183–187.
Crowther, J. H., Sanftner, J., Bonifazi, D. Z., & Shepherd, K. L. (2001). The role of daily hassles in binge eating. International Journal of Eating Disorders, 29(4), 449-454.
Eikey, E. V., & Booth, K. M. (2017). Recovery and maintenance: how women with eating disorders use Instagram. iConference 2017 Proceedings.
Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2015). Negative comparisons about one's appearance mediate the relationship between Facebook usage and body image concerns. Body Image, 12, 82-88.
Fardouly, J., & Vartanian, L. R. (2016). Social Media and body image concerns: Current research and future directions. Current Opinion in Psychology, 9, 1-5.
Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015) The mediating role of appearance comparisons in the relationship between media usage and self-objectification in young women. Psychology of Women Quarterly, 39(4), 447–457.
Festinger, L. (1954) A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2),117–140.
Fouts, G., & Vaughan, K. (2002). Television situation comedies: Male weight, negative references, and audience reactions. Sex roles, 46(11-12), 439-442.
Grabe, S., Ward L. M., & Hyde J.S., (2008). The role of the media in body image concerns among women: A meta-analysis of experimental and correlational studies. Psychological Bullettin, 134(3), 460-476.
Groesz, L. M., Levine M.P., Murnen S.K. (2002) The effect of experimental presentation of thin media images on body satisfaction: A meta-analytic review. International Journal of Eating Disorders, 31(1), 1-16.
Guerrieri, L., & Drenten, J. (2019). The hashtaggable body: negotiating gender performance in social media. In Handbook of Research on Gender and Marketing. Edward Elgar Publishing.
Halliwell, E., & Harvey, M. (2006) Examination of a sociocultural model of disordered eating among male and female adolescents. British Journal of Health Psychology, 11(2), 235–248.
Holland, G., & Tiggemann, M. (2016) A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image 17, 100–110.
Holmberg, C., Chaplin, J., Hillman,T., & Berg, C. 2016. Adolescents’ presentation of food in social media: An explorative study. Appetite, 99, 121–29.
Hu, Y., Manikonda, L., & Kambhampati, S. (2014). What we instagram: A first analysis of instagram photo content and user types. In Proceedings of the 8th International Conference on Weblogs and Social Media, ICWSM 2014 (pp. 595-598). The AAAI Press.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media”, Business Horizons, 53(1), 59-68.
Keery, H., van den Berg, P., & Thompson, J. K. (2004). An evaluation of the tripartite influence model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image 1(3), 237–251
LaMarre, A., & Rice, C. (2017). Hashtag Recovery: #Eating Disorder Recovery on Instagram, Social Sciences, 6(3), 68.
Linville, D., Brown, T., Sturm, K., & McDougal, T. (2012). Eating disorders and social support: Perspectives of recovered individuals, Eating Disorders, 20, 216–231.
Mabe, A. G., Forney, K. J., & Keel, P. K. (2014). Do you “like” my photo? Facebook use maintains eating disorder risk. The International journal of eating disorders, 47(5), 516-23.
Mayer-Schönberger, K. & Cukier,V. (2013). Big data: A revolution that will transform how we live, work and think. New York: Houghton Mifflin Hardcourt Publishing Company.
McLean, S. A., Paxton, S. J., & Wertheim, E.H. (2015) Photoshopping the selfie: self-photo editing and photo investment are associated with body dissatisfaction in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 48, 1132–1140.
McKenna, K. Y., & Bargh, J. A. (1998). Coming out in the age of the Internet: Identity" demarginalization" through virtual group participation. Journal of Personality and Social Psychology, 75(3), 681.
McKenna, K. Y., & Green, A. S. (2002). Virtual group dynamics. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 6(1), 116.
McKenna, K. Y. A., Green, A. S., & Gleason, M. E. J. (2002). Relationship formation on the Internet:What’s the big attraction? Journal of Social Issues, 58(1), 9-31.
McNamara, N., & Parsons, H. (2016). Everyone here wants everyone else to get better: The role of social identity in eating disorder recovery. The British Journal of Social Psychology, 55(4), 662-680.
Meier, E. P., & Gray, J. (2014) Facebook photo activity associated with body image disturbance in adolescent girls. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17, 199–206.
Mejova, Y., Abbar, S., & Haddadi, H. (2016, March). Fetishizing food in digital age: #foodporn around the world. In Tenth International AAAI Conference on Web and Social Media.
Myers, T. A., & Crowther, J. H. (2009). Social comparison as a predictor of body dissatisfaction: A meta-analytic review. Journal of Abnormal Psychology, 118(4), 683-698.
Ransom, D. C., La Guardia, J. G., Woody, E. Z., & Boyd, J. L. (2010). Interpersonal interactions on online forums addressing eating concerns. International Journal of Eating Disorders, 43, 161–170.
Riva, G. (2010). I social network. Bologna, Italia: Il Mulino.
Rousseau S. (2013). Food “Porn” in Media. In: Thompson P., Kaplan D. (Eds), Encyclopedia of Food and Agricultural Ethics (pp. 748-754). Dordrecht: Springer.
Statista (2019). Social media worldwide (retrieved from https://www.statista.com/study/12393/social-networks-statista-dossier)
Stice, E., & Hoffman, E. (2004). Prevention of eating disorders. Handbook of eating disorders and obesity, 33-57.
Thompson, J. K., Heinberg, L. J., & Altabe M. (1999) Exacting Beauty: Theory, Assessment, and Treatment of Body Image Disturbance. Washington, DC: American Psychological Association.
Tiggemann, M., & McGill, B. (2004). The role of social comparison in the effect of magazine advertisements on women's mood and body dissatisfaction. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(1), 23-44.
Tiggemann, M., & Miller, J. (2010). The Internet and adolescent girls’ weight satisfaction and drive for thinness. Sex Roles, 63(1-2), 79-90.
Tiggemann, M., & Slater, A. (2004). Thin ideals in music television: A source of social comparison and body dissatisfaction. International Journal of Eating Disorders, 35(1), 48-58.
Tiggemann, M., & Slater, A. (2013). NetGirls: The Internet, Facebook, and body image concern in adolescent girls. International Journal of Eating Disorders, 46(6), 630-633.
Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetTweens: The internet and body image concerns in preteenage girls. The Journal of Early Adolescence, 34(5), 606-620.
Turner, J. C., Hogg, M., Oakes, P., Reicher, S., & Wetherell, M. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, England: Basil Blackwell.
Turner, J. C., Hogg, M., Oakes, P., Reicher, S., & Wetherell, M. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, England: Basil Blackwell.
Turner, J. C., Hogg, M., Oakes, P., Reicher, S., & Wetherell, M. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization theory. Oxford, England: Basil Blackwell.
Van den Berg, P., Thompson, J. K., Obremski-Brandon, K., & Coovert, M. (2002). The tripartite influence model of body image and eating disturbance: A covariance structure modeling investigation testing the mediational role of appearance comparison. Journal of Psychosomatic Research, 53(5), 1007-1020.
Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2012). Understanding sexual objectification: A comprehensive approach toward media exposure and girls' internalization of beauty ideals, self-objectification, and body surveillance. Journal of Communication, 62(5), 869-887.
Williams, C., & Riley, S. (2013). Finding support and negotiating identity. An analysis of the structure and content of newbie posts and their elicited replies on five pro-eating disorder websites. RESET, 2, 1–15.