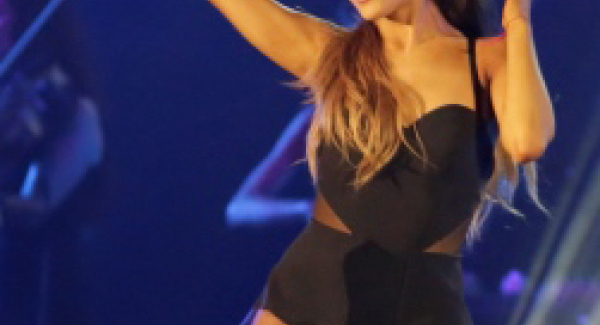"Se una viene vestita così io dico ‘ma chi è sto pu*****ne?’". Queste le parole usate da Fabio Volo per apostrofare Ariana Grande nel video del suo singolo 7rings (la Repubblica, 2019). Durante il suo programma su radio DeeJay, il conduttore radiofonico ha affermato che tale video sarebbe un continuo richiamo alla sessualità, visti i modi di vestire e di comportarsi della cantante e delle altre protagoniste femminili. Peccato, però, che la canzone inneggi a niente meno che l’emancipazione femminile! Il testo, scambiato da Volo per un richiamo sessuale (“I want it, I got it”, “Lo voglio, lo prendo”), si riferisce alla possibilità della donna di potersi comprare quello che vuole perché indipendente economicamente. Ciò che ha fatto Volo non è stato altro che sessualizzare la cantante e le sue parole. Non solo, ha anche espresso la preoccupazione che video del genere stessero “imputt****do” le sue figlie. Le parole del conduttore hanno suscitato un certo scalpore e sono state da molti giudicate doppiamente offensive. Infatti, esse non solo attaccano Ariana Grande, ma più in generale possono essere lette come una critica verso le ragazze e le donne per il loro modo di vestire e di comportarsi, che a sua volta veicola l’accusa implicita alle donne – come spesso accade nei casi di violenze sessuali – di attirare su di sé le attenzioni sessuali maschili. In termini psicosociali, le parole di Fabio Volo sembrano esprimere la preoccupazione di fondo che bambine e ragazze possano sviluppare quella che viene chiamata sessualizzazione interiorizzata.
Al fine di chiarire i rischi legati alla sessualizzazione interiorizzata, sarà innanzitutto proposto un breve inquadramento dei numerosi studi sul tema della sessualizzazione, facendo riferimento nello specifico alla sessualizzazione delle donne, sulle quali è posto maggiormente il focus in tali ricerche. Saranno quindi illustrati il concetto di sessualizzazione interiorizzata e le sue conseguenze, e saranno discusse possibili contromisure allo sviluppo, da parte di ragazze e donne, di un’idea sessualizzata di sé.
La sessualizzazione e le sue conseguenze
Ma cosa si intende per sessualizzazione? Si parla di sessualizzazione quando l’attenzione nei confronti di una persona si focalizza unicamente sul suo aspetto fisico: una persona viene sessualizzata quando le si attribuisce disponibilità sessuale o la si ritiene attraente solo in virtù di determinate caratteristiche quali abbigliamento provocante, nudità o pose ammiccanti del corpo (Bigler, Tomasetto, & McKenney, 2019; Fasoli, Durante et al., 2018; Morris & Goldenberg, 2015). Sebbene i due concetti siano correlati, la sessualizzazione non va dunque confusa con l’oggettivazione sessuale, ovvero, la rappresentazione di una persona come semplice oggetto di piacere sessuale (Ward, 2016), che implica che una persona sia “trattata come un corpo (o un insieme di parti del corpo) valutato principalmente per l’uso (o il consumo) da parte di altri” (Fredrickson & Roberts, 1997, p. 174).
Una delle principali fonti di sessualizzazione della donna sono certamente i mass-media. Pubblicità, programmi televisivi, film, ma anche videogiochi, testi e video musicali presentano le donne in modo sessualizzato sia attraverso l’esposizione della nudità femminile e l’utilizzo di vestiario provocante, sia ritraendo le donne come sessualmente disponibili o impegnate in attività associate alla sfera sessuale (Bigler et al., 2019; Grauerholz & King, 1997; Krassas, Blauwkamp, & Wesselink, 2001; Lin, 1997). Anche genitori, insegnanti e pari trasmettono inconsapevolmente rappresentazioni sessualizzate delle donne (e.g. Brown, 2003; Nichter, 2000): infatti, sebbene l’ostentazione delle proprie forme e della nudità vengano solitamente scoraggiati e mal visti in contesti quotidiani quali ad esempio scuola o lavoro (Cabras et al., 2018; Fasoli, Maas et al., 2018), il messaggio che passa è sempre che il corpo di donne e ragazze possiede costantemente ed intrinsecamente una certa sessualità, la quale andrà necessariamente ad agire sull’eccitazione maschile.
Questa idea può a sua volta causare reazioni “alla Fabio Volo”, che possono essere considerate come una delle conseguenze dell’esposizione frequente e continua, soprattutto a livello mediatico, ad una rappresentazione sessualizzata delle donne. E’ stato dimostrato, infatti, come la sessualizzazione sia associata, sia negli uomini che nelle donne, a maggior sostegno per le idee sessiste e atteggiamenti negativi verso le donne (McKenzie-Mohr & Zanna, 1990; Ward, 2002; Ward & Friedman, 2006; Ward, Hansbrough, & Walker, 2005). Per esempio, è stato evidenziato che guadare frequentemente programmi televisivi sessualizzati alimenta, negli adolescenti, una visione delle donne come oggetti sessuali e un’idea del sesso come attività ludica (Ward & Friedman, 2006). Inoltre, l’esposizione a immagini di donne ritratte in modo sessualizzato (per esempio, in videoclips o videogame) promuove una maggiore accettazione di tutte quelle credenze che “spostano” la responsabilità di molestie e violenza sessuale ai danni delle donne sulle vittime stesse, fenomeno conosciuto come “biasimo della vittima” (Penone & Spaccatini, 2019), piuttosto che su coloro che le hanno messe in atto. Questo tipo di credenze sono meglio conosciute, nella letteratura psicosociale, come “miti dello stupro”, e prevedono ad esempio l’idea che una donna se la sia “cercata” vestendosi in modo sexy (Milburn, Mather, & Conrad, 2000; Stermer & Burkley, 2015).
Interiorizzare la sessualizzazione: cosa comporta?
Numerose ricerche accennano a come l’oggettivazione sessuale possa essere fatta propria dalle donne stesse, portandole all’auto-oggettivazione e, cioè, a percepire il proprio corpo soprattutto dal punto di vista altrui, valutandolo ed adeguandolo solo in funzione dell’aspetto fisico (e.g. Calogero, 2012; Fredrickson & Roberts, 1997; Ronchetti, Fasoli & Rusconi, 2018). Lo stesso può accadere per la sessualizzazione: si parla in questo caso di sessualizzazione interiorizzata, ovvero l’interiorizzazione di un determinato ideale di bellezza e dell’idea che essere sessualmente attraenti per gli uomini sia un aspetto fondamentale della propria identità. Il processo di interiorizzazione inizia in adolescenza, quando le ragazze, costantemente bombardate dai messaggi sessualizzanti presenti nella società in cui si trovano, sviluppano la loro identità sentendo di dover aderire ai suddetti standard (Blakemore, Berenbaum & Liben, 2009; McKenney & Bigler, 2016a).
La sessualizzazione interiorizzata è un costrutto introdotto recentemente da McKenney e Bigler (2016a; 2016b), le quali hanno anche sviluppato un apposito strumento di misurazione. Secondo le autrici, il grado di sessualizzazione interiorizzata può essere rilevato misurando le preferenze delle ragazze nel campo dell’abbigliamento e di contenuti mediatici, le loro credenze rispetto al comportamento che una ragazza dovrebbe tenere nelle relazioni con persone dell’altro sesso e le energie spese in alcune attività collegate alla sfera sessuale. Per quanto riguarda il primo aspetto, lo strumento misura (a) le preferenze delle ragazze per l’abbigliamento sexy, quale ad esempio scarpe con tacchi molto alti, reggiseni in pizzo o micro-bikini, e (b) il grado in cui le ragazze preferiscono contenuti media sessualizzati, come quelli veicolati da programmi televisivi o articoli che insegnano come apparire sempre bellissime, in confronto a contenuti mediatici che affrontano altre tematiche, come documentari o articoli sull’ambiente. In secondo luogo, la sessualizzazione interiorizzata viene misurata facendo riferimento (c) all’accettazione da parte delle ragazze delle opinioni sessualizzate riguardo al proprio corpo e a quello delle altre femmine, ossia l’attribuzione di importanza all’apparire sexy (item di esempio: “L’aspetto di una ragazza è una delle sue caratteristiche più importanti”); (d) all’accettazione dell’idea che l’aspetto fisico debba essere sessualmente attraente per i maschi, anche a costo di non collimare con valori e desideri della persona (ad esempio: “Mi sono sottoposta ad una dieta, o ho pensato di farlo, così che i ragazzi pensino che sono sexy”); (e) alla convinzione che essere sessualmente attraenti dia potere alla persona stessa (ad esempio: “Avere un seno prosperoso è utile per convincere i ragazzi a fare quello che vuoi”). Infine, alle ragazze viene chiesto (f) quanto il gruppo di pari parli di attività sessualizzate o le metta in atto (ad esempio: “Le mie amiche parlano spesso dell’aspetto fisico delle altre ragazze”).
La sessualizzazione interiorizzata ha importanti conseguenze per il benessere personale e l’adattamento psico-sociale di adolescenti e donne adulte. Le ragazze che mostrano alti livelli di sessualizzazione interiorizzata, per esempio, tendono a mostrare maggiori livelli di sorveglianza e vergogna per il proprio corpo (McKenney & Bigler, 2016a). Inoltre, in uno studio McKenney e Bigler (2016b) hanno verificato che un’elevata sessualizzazione interiorizzata nelle ragazze si ricollega a minor impegno in altri ambiti, quali ad esempio quello scolastico. Per esempio, in un esperimento nel quale veniva chiesto a ragazze adolescenti di prepararsi per registrare un breve notiziario,le ragazze con più elevati livelli di sessualizzazione interiorizzata utilizzavano maggior tempo per truccarsi e meno tempo per preparare il discorso rispetto alle ragazze con bassi livelli di sessualizzazione interiorizzata. Inoltre, ragazze con più alti livelli di sessualizzazione interiorizzata hanno mostrato peggiori voti scolastici rispetto alle loro pari con più bassi livelli di sessualizzazione (McKenney & Bigler, 2016b).
Recentemente, uno studio di Moscatelli, Golfieri, Tomasetto, e Bigler (2020) ha evidenziato che la sessualizzazione interiorizzata è collegata anche ad una visione delle donne di tipo sessista da parte delle donne stesse. In altre parole, più le donne tendono ad avere una visione di sè sessualizzata, più mostrano sostegno per una rappresentazione tradizionale dei ruoli di genere (che vedono la donna come principalmente impegnata in ambito familiare e l’uomo come impegnato nella carriera e nelle attività extra-familiari) e per l’utilizzo di standard di giudizio diversi rispetto ai comportamenti di maschi e femmine (quali, per esempio, la credenza che i maschi possano godere di maggiori libertà di azione e di movimento rispetto alle ragazze). Inoltre, la sessualizzazione interiorizzata è risultata associata ad una maggiore tolleranza delle molestie sessuali. I risultati, relativi ad un campione di giovani adulte italiane, hanno infatti evidenziato che più le donne ritengono di dover essere sexy per gli uomini, più sembrano sposare una visione sessista dei ruoli di genere, che a sua volta le porta ad essere più tolleranti verso le molestie sessuali e a colpevolizzare maggiormente le vittime per averle “provocate”.
Verso un futuro migliore
Nel complesso, le ricerche sulla interiorizzazione della sessualizzazione, così come quelle sull’oggettivazione sessuale e l’auto-oggettivazione, hanno evidenziato un insieme di preoccupanti ripercussioni sul benessere psico-sociale e sul comportamento delle donne. Inoltre, questi stessi processi sembrano alimentare credenze ed atteggiamenti sessisti che a loro volta giustificano disparità e violenza di genere. Sebbene gli studi si siano focalizzati principalmente sulle conseguenze dell’interiorizzazione di un’idea sessualizzata di sé sulla popolazione femminile (McKenzie-Mohr & Zanna, 1990; Ward, 2002; Ward & Friedman, 2006; Ward, Hansbrough, & Walker, 2005) e su bambini e bambine (si veda Spaccatini, 2019, per una rassegna su questo tema), altrettanto negativi potrebbero essere gli effetti della sessualizzazione sugli uomini. Da un lato, gli uomini che sposano una visione delle donne fortemente sessualizzata e che le considerano “strumento” del piacere maschile potrebbero mostrare comportamenti sessuali svilenti nei confronti delle donne stesse (Bigler, Tomasetto e McKenney, 2019). Dall’altro, alcune evidenze suggeriscono possibili rischi anche nei casi in cui vi sia, da parte degli uomini, interiorizzazione di una immagine di sè sessualizzata. A tale riguardo, è stato ad esempio evidenziato che gli uomini che fanno propria una rappresentazione della mascolinità fondata sull’idea che un “vero uomo” debba essere “sessualmente vorace” tendono a mettere in atto comportamenti aggressivi verso le donne in situazioni in cui tale immagine di sé viene negata o messa in dubbio dal comportamento delle donne stesse (si pensi, per esempio, ai frequenti casi di violenza verso donne colpevoli di non “rispettare” il partner maschile; Bosson e Vandello, 2011).
Il quadro sottolinea, dunque, come sia necessario comprendere e contrastare le possibili cause della sessualizzazione interiorizzata, quali i messaggi e le rappresentazioni delle donne e degli uomini in termini stereotipici e sessualizzati, che sono proposti e ri-proposti dalla socità in cui viviamo sin dalla giovane età, come ampiamente documentato anche in Italia (Cosenza, Colombari e Gasparri, 2016; Valtorta, Sacino, Baldissarri e Volpato, 2016).
Come si potrebbe dunque contrastare la sessualizzazione e la sua interiorizzazione? Da un lato, sarebbe auspicabile che la fruizione, da parte di bambini e adolescenti, di tutto ciò che presenta immagini sessualizzate venisse scoraggiata. La ricerca psicosociale potrebbe contribuire in tal senso esaminando gli effetti di rappresentazioni di donne e uomini alternative a quelle fortemente sessualizzate e proponendo programmi ed interventi atti a contrastare visioni stereotipiche della sessualità maschile e femminile. Dall’altro, si può immaginare di intervenire mediante la formazione di genitori, insegnanti, educatori, allenatori sportivi e altri adulti che a vario titolo interagiscono con bambini e adolescenti e possono quindi contrastare gli effetti di modelli negativi proposti dai media. Tra i problemi alla lotta contro sessualizzazione ed oggettivazione, ad esempio, c’è il fatto che essa viene percepita come tentativo di stravolgimento dello status quo: su questo fronte, Calogero e Tylka (2014) propongono di utilizzare messaggi che provochino nelle persone la sensazione che fenomeni come la sessualizzazione e l’oggettivazione siano distruttivi per la società, piuttosto che costruttivi (ad esempio, sottolineare come l’utilizzo di tali messaggi nelle pubblicità dei vestiti per bambini fa sì che questi ultimi vengano visti con una connotazione maggiormente sessuale).
Sebbene lottare contro la sessualizzazione nella cultura possa apparire un’impresa donchisciottesca, aumentare la consapevolezza delle conseguenze personali e sociali di tale problema sarebbe un primo passo verso il suo attenuamento.
Glossario
Sessualizzazione: attribuzione di importanza unicamente all’aspetto fisico di una persona, in particolare focalizzandosi sulla bellezza e disponibilità sessuale percepita della stessa, solitamente a causa di nudità, vestiario sensuale o pose ammiccanti.
Sessualizzazione interiorizzata: convinzione di dover essere belle e/o attraenti solo in funzione dell’apprezzamento maschile.
Oggettivazione sessuale: percezione del corpo (o parti di esso) di una persona, più solutamente di genere femminile, solo come oggetto atto al soddisfacimento sessuale.
Auto-oggettivazione: adozione del punto di vista altrui per la valutazione e l’adattamento del proprio corpo, tramite il solo giudizio dell’aspetto fisico.
Sessismo: atteggiamento discriminatorio o pregiudizio verso una persona basato sul suo genere. Include la credenza che un genere sia inferiore all’altro. La forma più diffusa è il sessismo contro le donne.
Miti dello stupro: credenze stereotipiche e false riguardanti tutto ciò che concerne stupri e violenze sessuali, solitamente atti a giustificare tali aggressioni tramite la colpevolizzazione della vittima.
Molestia: comportamento che arreca disturbo o fastidio al benessere fisico o psichico di una persona. Le molestie possono assumere forme quali aggressione, intimidazione, offesa.-
Molestia sessuale: Comportamento a connotazione sessuale nei confronti di una persona che non lo desidera, e che ne offende la dignità. Può avere carattere fisico o verbale. Secondo la definizione classica di Louise Fitzgerald (1990), le molestie sessuali possono assumere le forme di: a) molestie di genere, che includono commenti offensivi, osservazioni inappropriate sull’aspetto fisico, allusioni sessuali, esposizione di immagini pornografiche; b) attenzione sessuale indesiderata, come ad esempio proposte insistenti di appuntamenti, contatti fisici indesiderati e che provocano disagio; c) coercizione sessuale, ad esempio, minacce e ricatti sessuali.
Sorveglianza del proprio corpo: atteggiamento che entra a far parte del più ampio costrutto della coscienza del corpo oggettivato, definibile come la tendenza a vedersi come oggetto ed essere valutati dagli altri.
Vergogna per il proprio corpo: vergogna che la persona prova quando il suo corpo non incontra gli standard culturali di bellezza.
Stupro: reato di violenza carnale.
Bibliografia
Bigler, R. S., Tomasetto, C., & McKenney, S. (2019). Sexualization and youth: Concepts, theories, and models. International Journal of Behavioral Development, 43(6), 530-540. doi:10.1177/0165025419870611
Blakemore, J. O., Berenbaum, S. A., & Liben, L. S. (2009). Motor development and cognition. In J. O. Blakemore, S. A. Berenbaum, & L. S. Liben (A cura di), Gender development (p. 69-94). New York, NY: Psychology Press.
Bosson, J. K., & Vandello, J. A. (2011). Precarious manhood and its links to action and aggression. Current Directions in Psychological Science, 20(2), 82-86. doi:10.1177/0963721411402669
Brown, L. M. (2003). Girlfighting: Betrayal and rejection among girls. NY: New York University Press.
Cabras, C., Marmillata, S., & Sechi, C. (2018). Sexual objectification in education: How do teachers perceive and evaluate students? Social Psychology of Education, 21(3), 743-757. doi:10.1007/s11218-018-9432-3
Calogero, R. M. (2012). Objectification theory, self-objectification, and body image. In T. F. Cash (A cura di), Encyclopedia of body image and human appearance (Vol.2, pp. 574-580). San Diego, CA: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-384925-0.00091-2
Calogero, R. M., & Tylka, T. L. (2014) Sanctioning resistance to sexual objectification: an integrative system justification perspective. Journal of Social Issues, 70(4) 763-778. doi: 10.1111/josi.12090
Cosenza, G., Colombari, J., & Gasparri, E. (2016). Come la pubblicità italiana rappresenta le donne e gli uomini. Verso una metodologia di analisi semiotica degli stereotipi. Versus, 45(2), 323-362.
Fasoli, F., Durante, F., Mari, S., Zogmaister, C., & Volpato, C. (2018). Shades of sexualization: When sexualization becomes sexual objectification. Sex Roles, 78(5-6), 338-351. doi:10.1007/s11199-017-0808-1
Fasoli F, Maass A, Volpato C and Pacilli MG (2018) The (Female) Graduate: Choice and Consequences of Women’s Clothing. Frontiers in Psychology, 9, 2401. doi:10.3389/fpsyg.2018.02401
Fitzgerald, L. F. (1990). Sexual harassment: The definition and measurement of a construct. In M. A. Paludi (Ed.), Ivory power: Sexual harassment on campus. (pp. 21–44). State University of New York Press.
Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. (1997). Objectification theory. Psychology of Women Quarterly, 21, 173–206. doi:10.1111/j. 1471-6402.1997.tb00108.x.
Grauerholz, E., & King, A. (1997). Primetime sexual harassment. Violence Against Women, 3, 129-148.
Krassas, N. R., Blauwkamp, J. M., & Wesselink, P. (2001). Boxing Helena and corseting Eunice: Sexual rhetoric in Cosmopolitan and Playboy magazines. Sex Roles, 44, 751–771.
la Repubblica. (2019, Settembre 16). Fabio Volo su Ariana Grande: "Se una viene vestita così io dico 'ma chi è sto pu*****ne?". Tratto da la Repubblica: https://www.repubblica.it/spettacoli/people/2019/09/16/news/fabio_volo-236159660/
Lin, C. A. (1997). Beefcake versus cheesecake in the 1990s: Sexist portrayals of both genders in television commercials. Howard Journal of Communications, 8, 237-249.
McKenney, S. J., & Bigler, R. S. (2016a). Internalized sexualization and its relation to sexualized appearance, body surveillance, and body shame among early adolescent girls. Journal of Early Adolescence, 36, 171-197.
McKenney, S. J., & Bigler, R. S. (2016b). High heels, low grades: Internalized sexualization and academic orientation among adolescent girls. Journal of Research on Adolescence, 26(1), 30-36. doi:10.1111/jora.12179
McKenzie-Mohr, D., & Zanna, M. P. (1990). Treating women as sexual objects: Look to the (gender schematic) male who has viewed pornography. Personality and Social Psychology Bulletin, 16, 296-308.
Milburn, M. A., Mather, R., & Conrad, S. D. (2000). The effects of viewing R-rated movie scenes that objectify women on perceptions of date rape. Sex Roles, 43(9-10), 645-664.
Morris, K. L., & Goldenberg, J. L. (2015). Women, objects, and animals: Differentiating between sex-and beauty-based objectification. International Review of Social Psychology, 28, 15–38 www.cairn.info/revue-internationale-de-psychologie-sociale-2015-1-page-15.htm.
Moscatelli, S., Tomasetto, C., Golfieri, F., & Bigler, R. S. (2020). #MeToo: how internalized sexualization predicts beliefs on harassment and on movement supporting victims. Article submitted for publication.
Nichter, M. (2000). Fat talk: What girls and their parents say about dieting. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ronchetti, S., Fasoli, F., & Rusconi, P. (2018). 50 sfumature di oggettivazione: Donne e violenza. In-Mind Magazine, 15.
Spaccatini, F. (2019). Children's sexualization and appearance focus: A literature review. Psicologia Sociale, 14(3), 343-368. doi:10.1482/94939
Valtorta, R., Sacino, A., Baldissarri, C., & Volpato, C. (2016). L’eterno femminino. Stereotipi di genere e sessualizzazione nella pubblicità televisiva. Psicologia Sociale, 2, 159-188. doi: 10.1482/84097
Ward, L. M. (2002). Does television exposure affect emerging adults' attitudes and assumptions about sexual relationships? Correlational and experimental confirmation. Journal of Youth and Adolescence, 31, 1-15.
Ward, L. M. (2016). Media and sexualization: State of empirical research, 1995–2015. The Journal of Sex Research, 53, 560–577. doi:10. 1080/00224499.2016.1142496.
Ward, L. M., & Friedman, K. (2006). Using TV as a guide: Associations between television viewing and adolescents' sexual attitudes and behavior. Journal of research on adolescence, 16, 133-156.
Ward, L. M., Hansbrough, E., & Walker, E. (2005). Contributions of music video exposure to black adolescents’ gender and sexual schemas. Journal of adolescent research, 20, 143-166.