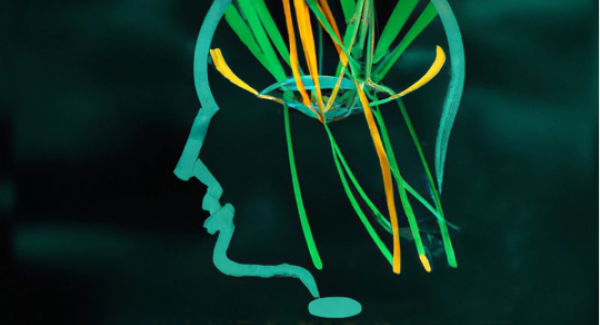Per gli atleti olimpici e le atlete olimpiche che cercano di ottenere prestazioni di alto livello sul più grande palcoscenico del mondo, alti livelli di preparazione personalizzata sono fondamentali perché anche le più sottili differenze hanno un impatto profondo sui risultati delle prestazioni (Zentgraf & Raab, 2023). Una preparazione che consiste solo nell'allenamento e nella preparazione fisica sarebbe tuttavia limitata. Essa dovrebbe piuttosto basarsi su un approccio olistico che includa alimentazione, genetica, valori ematici, abilità motorie, vita sociale e aspetti cognitivi. Gli attuali approcci di ricerca pongono quindi particolare enfasi sulla cooperazione interdisciplinare, concentrandosi sul miglioramento individuale dell'atleta in più aree e sulle loro possibili interazioni. Spesso sottovalutati perché meno visibili della forma fisica, ma fondamentali per la prestazione atletica, sono i processi cognitivi che saranno il focus di questo articolo (Figura 1).

Figura 1: Misure multidisciplinari per lo sviluppo dell’atleta con particolare attenzione alle funzioni cognitive
Le sfide cognitive negli sport agonistici sono molteplici e comprendono, ad esempio, il mantenimento della concentrazione, il multitasking, il processo decisionale o le prestazioni della memoria di lavoro (Kalén et al., 2021). La ricerca cognitiva nello sport differenzia teoricamente le abilità cognitive (cioè l'uso efficace delle conoscenze specifiche in ambito sportivo durante la prestazione) dalle funzioni cognitive (cioè i meccanismi cognitivi generali che richiedono uno sforzo e sono rilevanti per l'azione diretta all'obiettivo). Le funzioni cognitive sono state ulteriormente differenziate in funzioni di base, funzioni superiori e capacità decisionali (Kalén et al., 2021).
Soprattutto negli sport intercettivi e di squadra, è stato dimostrato che la cognizione svolge un ruolo centrale nello sviluppo di competenze sportive straordinarie (Kalén et al., 2021). Di seguito, prendiamo come esempio la pallacanestro per comprendere meglio come la cognizione si intersechi con la competenza atletica. I giocatori e le giocatrici di pallacanestro devono costantemente prendere decisioni in una frazione di secondo e contemporaneamente eseguire movimenti fisici complessi. Durante una partita, importanti funzioni cognitive di base consentono di prestare attenzione alla posizione dei/lle compagni/e o di elaborare le informazioni in arrivo, come le indicazioni dell'allenatore. Le funzioni cognitive superiori comprendono anche il recupero e l'aggiornamento delle informazioni in memoria di lavoro, l'inibizione delle risposte e il task switching (il passaggio rapido ed efficiente da un compito cognitivo a un altro) quando le circostanze cambiano. Inoltre i giocatori e le giocatrici hanno bisogno di abilità cognitive specifiche, che permettano di anticipare il comportamento degli/lle avversari/e, valutare future strategie alternative di gioco e prendere decisioni in momenti di massima pressione (Figura 2). Seguiteci durante una giornata di allenamento speciale della cestista della nazionale olimpica, Sofia, che fa parte del progetto di ricerca interdisciplinare “in:prove”, volto a migliorare le prestazioni atletiche attraverso valutazioni e interventi individualizzati. Esploreremo insieme il ruolo della cognizione e della valutazione cognitiva.
Preparazione mentale olimpica?
Ore 7.00. Sofia fa colazione prima di recarsi al palazzetto dello sport.
Ore 7.15. Prima sessione di allenamento di basket. Dopo il riscaldamento il primo esercizio cognitivo prevede la disposizione di coni, numerati e di colore diverso, in un quadrato. Sofia si posiziona al centro palleggiando. Quando l'allenatore grida un numero, lei deve toccare il rispettivo cono con la mano che non palleggia e tornare alla posizione di partenza il più velocemente possibile. Dopo qualche minuto la regola cambia e richiede di rispondere ai colori dei coni, prima di cambiare nuovamente richiedendo a Sofia di toccare i coni con la mano sinistra per i numeri e con la mano destra per i colori. Questo esercizio coinvolge molti costrutti cognitivi rilevanti: Sofia deve concentrare l'attenzione sui coni ed elaborare rapidamente i comandi dell'allenatore (velocità di elaborazione), ricordare la posizione dei coni (memoria di lavoro), adattarsi in modo flessibile alle regole che cambiano (task switching) e inibire le risposte "sbagliate" (ad esempio usare la mano "sbagliata").
Ore 8.00: Presentazione del progetto di ricerca “in:prove”. Dopo essere state accolte dal ricercatore responsabile del progetto, tutte le giocatrici eseguono un test che mette alla prova la velocità di elaborazione cognitiva. In questo test, le partecipanti lavorano sotto pressione e hanno 30 secondi, per ciascuna delle quattro prove, per collegare i numeri da 1 a 100 il più velocemente possibile. Le atlete si distribuiscono poi nei diversi punti predisposti per la raccolta e la valutazione dei dati, tra cui quelli relativi a compiti di prestazione motoria (8.15), a interviste sul ciclo mestruale (8.35), al prelievo di sangue (8.55) e a questionari psicosociali.
Ore 9.15. Test cognitivi. Sofia viene sottoposta a tre compiti computerizzati per valutare funzioni cognitive di base, come la velocità di elaborazione e l'attenzione visiva, e funzioni cognitive superiori, come la memoria di lavoro o la flessibilità cognitiva (Figura 2). Questi compiti consistono nel navigare attraverso lettere con diversi schemi o puzzle o nel rispondere a forme geometriche lampeggianti o a combinazioni di lettere e numeri pressando un pulsante, nel modo più accurato e veloce possibile. Le capacità decisionali di Sofia, inoltre, vengono valutate per mezzo di un paradigma, specifico per il basket, di generazione di opzioni: Sofia guarda scene di giocatori che si esibiscono in partite olimpiche di pallacanestro, i video si interrompono bruscamente e Sofia deve creare istantaneamente delle opzioni riguardo a come lei, come giocatrice, avrebbe potuto agire successivamente e deve infine decidere quale eseguire tra queste opzioni.

Figura 2: Illustrazione delle funzioni cognitive e del modo in cui vengono valutate nel progetto.
Ore 9.45-11.15. Seconda sessione di allenamento.
Ore 11.15. Pranzo.
Ore 12.00-13.15: Sofia completa il lavoro proposto in altri quattro punti predisposti per la raccolta e la valutazione dei dati.
Ore 15.00. Prima prova in campo. Dopo una lunga giornata di valutazione che ha richiesto concentrazione Sofia è in grado di dimostrare le sue capacità cognitive sul campo e di mostrare la stessa capacità di gioco che ha quando si sveglia riposata e piena di energia.
5 giorni dopo. I risultati individuali di tutte le valutazioni interdisciplinari sono riassunti in avatar contrassegnati da semafori (Figura 1). Questo strumento di visualizzazione aiuta i ricercatori a confrontarsi con gli atleti e le atlete e gli allenatori e le allenatrici per individuare quali capacità sono al di sopra della norma (verde), quali sono all'interno di un range normale (giallo) e quali rappresentano aree di miglioramento (rosso), guidando l’elaborazione di potenziali interventi personalizzati.
Questo programma giornaliero dimostra che la preparazione olimpica va oltre il semplice allenamento di pallacanestro, comprendendo anche diagnosi interdisciplinari e interventi individualizzati non direttamente legati alla disciplina. Come ricercatori e ricercatrici ci proponiamo di fornire approfondimenti “dietro le quinte dei test”, dove la diagnostica viene elaborata con cura e gli interventi vengono personalizzati in base ai risultati.
“Dietro le quinte” I: La diagnostica cognitiva sul campo
Selezione e sviluppo dei compiti cognitivi. Prima di avviare i progetti di ricerca i/le ricercatori/trici, gli/le allenatori/trici e i/le coordinatori/trici di ricerca dell'associazione sportiva si incontrano e discutono gli interessi particolari dell’associazione, tenendo conto anche delle abilità cognitive specifiche richieste dalla disciplina sportiva.
La psicologia dello sport distingue le competenze delle componenti cognitive (dall’inglese cognitive components skills, Voss et al., 2010) dall'approccio della prestazione esperta (dall’inglese expert performance approach, Ericsson, 2003). Secondo la prima filosofia di pensiero, la pratica a lungo termine dell'attività fisica insieme a richieste mentali progressivamente più complesse, quando si arriva al livello d'élite, influenza positivamente le prestazioni cognitive legate ad abilità cognitive generali. Al contrario l'approccio della prestazione esperta sostiene che gli atleti d'élite superano quelli non d’élite e i principianti soprattutto nei compiti cognitivi specifici dello sport. Una differenza cruciale è quindi la concettualizzazione dei test cognitivi: mentre la ricerca che segue l'approccio cognitive components skills implementa per lo più compiti cognitivi che misurano abilità cognitive generali, la ricerca che segue l'approccio expert performance approach utilizza compiti cognitivi specifici per ogni sport (Kalén et al., 2021). La prima tipologia di compiti utilizza stimoli (simboli, numeri, forme geometriche) e risposte che possono essere decodificati ed “affrontati” praticamente da chiunque, poiché non richiedono conoscenze o esperienze specifiche. Ad esempio, nel “Flanker task” gli stimoli sono frecce che puntano a sinistra circondate da due frecce che puntano a destra (e viceversa; si veda anche la Figura 2). La direzione della freccia centrale deve essere decodificata e indicata premendo un pulsante. In un test computerizzato di Corsi (per valutare la memoria di lavoro), gli stimoli sono serie di quadrati che si illuminano sullo schermo. I/le partecipanti devono memorizzare la sequenza e toccare i blocchi nello stesso ordine o nell'ordine inverso (per un'ampia panoramica dei compiti cognitivi generali si veda Diamond, 2013).
I compiti specifici per lo sport, invece, richiedono conoscenze e/o esperienze specifiche perché gli stimoli (immagini, video di una situazione sportiva), l'ambiente del compito (istruzioni, dimensioni della presentazione, posizione del partecipante) e a volte le risposte (passaggio, movimento di tutto il corpo) sono specifici per lo sport. Ad esempio, nei “Flanker task” specifici per il calcio vengono presentati 5 giocatori su uno schermo, con il giocatore centrale che rappresenta l'elemento target e i giocatori “fiancheggianti” che sono i (potenziali) distrattori (Musculus et al., 2022). Il partecipante, un giocatore di calcio, si trova di fronte allo schermo con un pallone tra un piede e l’altro, e deve passare il pallone verso l'area di porta (sinistra/destra) che il giocatore centrale sta guardando. In sintesi, anche quando sono stati identificati i costrutti cognitivi rilevanti, la selezione di compiti appropriati per la valutazione cognitiva non è banale a causa della variabilità nei disegni sperimentali (Furley et al., 2023).
I test cognitivi standardizzati che misurano abilità cognitive generali sono facilmente disponibili, spesso gratuitamente (psytoolkit o OpenSesame). Tuttavia, poiché i test che misurano le abilità cognitive specifiche per ogni sport rispondono a specifiche esigenze di valutazione o di ricerca, richiedono una stretta collaborazione tra ricercatori/trici e professionisti/e dello sport per selezionare stimoli (video) rappresentativi per una valutazione cognitiva efficace e affidabile, nonché una disponibilità di risorse significativa e procedure di validazione che richiedono molto tempo. Attualmente non esiste una batteria liberamente utilizzabile composta di compiti specifici per lo sport che misuri vari costrutti cognitivi in diversi sport, questo potrebbe essere un prossimo obiettivo prezioso sia per l’ambito della ricerca sia per l’ambito applicato.
Sfide associate ai test cognitivi sul campo. L’utilizzo di test cognitivi sul campo (ad esempio durante i ritiri di allenamento) offre la possibilità di effettuare ricerca ecologica con approfondimenti sui processi cognitivi che via via avvengono durante l’attività sportiva. ecologici. Tuttavia, i ricercatori e le ricercatrici devono trovare il modo migliore garantire la validità e l'affidabilità dei risultati.
Principali criteri di qualità (affidabilità, validità, obiettività): I test cognitivi devono essere proposti in più sessioni e risultare sempre affidabili pur tenendo conto delle variazioni nelle prestazioni influenzate da programmi di allenamento impegnativi o dalla stanchezza generale. I test cognitivi devono, inoltre, essere in linea con le richieste cognitive e gli obiettivi di allenamento specifici dello sport. La validità implica anche la considerazione del potenziale impatto della fatica fisica o mentale (Borsboom & Mellenbergh, 2007) e garantisce che i test riflettano accuratamente le capacità cognitive degli atleti e delle atlete in condizioni realistiche. L'obiettività è fondamentale per salvaguardare l'equità e la coerenza nei confronti di campioni sperimentali diversi. Per questo sono richieste procedure standardizzate, istruzioni chiare e ambienti uniformi in cui vengono somministrati i test soprattutto con atleti/e d'élite che possono avere diversi livelli di esperienza con i test cognitivi.
Standardizzazione ed equità: I test sul campo nei palazzetti dello sport e nelle stanze adiacenti comportano delle interferenze come il rumore, le interruzioni/distrazioni impreviste, allenamenti intermittenti o le variazioni di luce e temperatura. I ricercatori e le ricercatrici devono trovare spazi adeguati a condurre la valutazione cognitiva nel modo più standardizzato possibile, utilizzando anche dispositivi come cuffie per ridurre al minimo rumori e distrazioni.
Ragionevolezza: Considerando la limitata capacità di attenzione e la diminuzione del tasso di impegno degli individui nel tempo, i ricercatori e le ricercatrici devono assicurarsi che i test cognitivi si concentrino solo su fattori rilevanti e abbiano una durata minima.
Uso efficace delle risorse: È fondamentale un uso efficiente delle risorse, in termini di tempo e materiali, senza compromettere la qualità della valutazione (Moosbrugger & Kelava, 2012),
soprattutto durante la preparazione per le Olimpiadi, quando i programmi di allenamento sono così stretti che il tempo a disposizione per i test è limitato. Bilanciare brevità e completezza è un compito delicato, poiché test troppo lunghi possono affaticare la capacità di attenzione e anche causare ritardi nell'intero processo diagnostico.
Validazione/Standardizzazione (dall’inglese “scaling”): Confrontare i risultati dei compiti cognitivi con i valori standard corrispondenti all'età e al sesso è la prassi, ma è importante considerare che gli atleti e le atlete possono avere livelli di forma fisica eccezionali. Non è sempre facile distinguere se le differenze cognitive derivino da variazioni soggettive reali o dal fatto che gli atleti e le atlete presentano una forma fisica più performante rispetto alla media. Le metodologie di standardizzazione devono essere adattate all'elevato livello di base degli atleti e delle atlete, per stimare accuratamente le loro capacità cognitive (Adjetey et al., 2023).
Controllo dei dati: Garantire l'integrità dei dati sul campo è essenziale. Oltre a una base dati sicura è essenziale che gli atleti e le atlete concordino attivamente con chi e con chi non desiderano (l'allenatore/trice nazionale, il/la medico/a) condividere e informazioni personali che vengono eventualmente protette, si tratta di una scelta libera.
“Dietro le quinte” II: Progettazione e valutazione degli interventi cognitivi
La valutazione cognitiva e il feedback individuale consentono di identificare il proprio potenziale di sviluppo. L'obiettivo del progetto è quindi quello di sviluppare piani di intervento personalizzati tenendo conto sia dei punteggi individuali sul compito cognitivo sia delle esigenze specifiche dello sport. Per esempio l'allenamento della flessibilità cognitiva può essere più significativo per un giocatore di pallacanestro, che deve destreggiarsi in ambienti di gioco dinamici, che per una ginnasta che esegue delle routine. In ogni caso esistono pochissimi interventi standardizzati per funzioni cognitive specifiche o multiple (specifiche per lo sport). Un possibile approccio prevede la ripetizione quotidiana o settimanale di compiti cognitivi generali (ad esempio il multiple object tracking) per un certo periodo di tempo, per valutare se anche le prestazioni sportive migliorano. Tali effetti di trasferimento (dal compito cognitivo alla prestazione sportiva) si riferiscono ad abilità che non sono direttamente allenate e possono eventualmente manifestarsi in compiti simili (near-transfer) o in situazioni simili al gioco (far-transfer) (Fleddermann, Heppe & Zentgraf, 2019). Esistono, tuttavia, risultati contrastanti sugli effetti di near-transfer e far-transfer, che alimentano l'esigenza di elaborare compiti cognitivi e interventi specifici per lo sport. Siamo favorevoli a una strategia alternativa che non preveda interventi basati su compiti relativi ad abilità cognitive generali, ma piuttosto l'esercizio costante e l'aumento delle richieste cognitive durante l'allenamento regolare. Ad esempio, aumentando il numero di decisioni che l'atleta deve prendere, creando più richieste di doppio compito o utilizzando strumenti di allenamento come macchine lanciapalle, grandi schermi di proiezione con più zone bersaglio a cui reagire, o simulazioni di realtà virtuale e realtà aumentata. Proponiamo questa soluzione perché ci aspettiamo che, attraverso un allenamento specifico per lo sport, le richieste cognitive in situazioni competitive vengano gestite in modo più efficace a vantaggio di prestazioni superiori anche in eventi agonistici importanti come le Olimpiadi.
Nel caso dello sport d’élite la difficoltà principale consiste nel far accettare ad allenatori/trici ed atleti/e la sperimentazione di questo tipo di interventi. L'accettazione è più probabile quando le esigenze individuali vengono riconosciute e tradotte in approcci individuali personalizzati, con adeguamento di tempi e orari di tutte le parti coinvolte. Inoltre è necessario che allenatori, allenatrici, atleti e atlete siano consapevoli del valore aggiunto dell’intervento di valutazione generale e di valutazione specifica per lo sport e che siano a conoscenza del rapporto costi-benefici. Gli interventi cognitivi online rappresentano un'alternativa a basso costo che non interrompe i programmi di allenamento e può avere un rapporto costi-benefici positivo, ma in questo caso è difficile tenere sotto controllo l’adesione dell’atleta nel tempo. Anche lo/a psicologo/a dello sport può ottenere un rapporto costi-benefici favorevole concentrandosi su singole funzioni cognitive specifiche per lo sport invece di proporre batterie di test polivalenti.
In conclusione, la valutazione degli interventi individualizzati è impegnativa, soprattutto negli sport d'élite. In termini di valutazione formativa, gli interventi su misura per il/la cliente vengono seguiti documentando ogni intervento come caso di studio (Andersen et al., 2002; Keegan et al., 2017). Quindi un team composto da ricercatori/trici, allenatori/trici nazionali, scienziati/e dello sport e psicologi/ghe si confronta sui dati relativi agli interventi e garantisce che i parametri di prestazione specifici possono essere utilizzati nelle sessioni di allenamento dentro e fuori dal campo. Questo approccio di lavoro in team (dall’inglese co-productive approach, Smith et al., 2022) mira in generale a integrare le competenze multidisciplinari. La valutazione sommativa integra di conseguenza il feedback di tutti i soggetti coinvolti integrando i dati di gara e di allenamento. In questo modo atleti/e e allenatori/trici trarranno il massimo beneficio sia dalla ricerca in ambito sportivo sia dal supporto psicologico in ambito sportivo.
Come sostenere l’atleta olimpico nello sviluppo di una “mente d’oro” capace di sviluppare processi di pensiero per affrontare prestazioni atletiche eccezionali?
Come possiamo aiutare gli atleti e le altlete a sviluppare una “mente d’oro”? La ricerca interdisciplinare sottolinea l’importanza dello sviluppo individuale dell'atleta attraverso molteplici ambiti e le intricate interazioni tra essi. Le meta-analisi più recenti e la nostra esperienza dimostrano inoltre che è fondamentale considerare attentamente i processi cognitivi, in quanto hanno un impatto significativo sulle competenze atletiche e sulle prestazioni. Valutazioni cognitive efficaci e interventi individualizzati, integrati perfettamente nelle routine di allenamento, offrono strumenti promettenti per ottimizzare le capacità cognitive degli/lle atleti/e e migliorare la loro preparazione per prestazioni di alto livello sulla scena mondiale. Come ricercatori/trici ci auguriamo che la ricerca investa maggiormente nella verifica dell'efficacia degli interventi cognitivi individuali e come psicologi/ghe dello sport siamo molto impegnati allenare le menti olimpiche per prepararle ad una prestazione eccezionale a Parigi 2024.
Ringraziamenti
Questo progetto è stato sostenuto con fondi di ricerca dell'Istituto Federale Tedesco per la Scienza dello Sport (BISp) sulla base di una decisione del Bundestag tedesco; numero di sovvenzione 081901/21-25.
Bibliografia
Adjetey, C., Davis, J. C., Falck, R. S., Best, J. R., Dao, E., Bennett, K., Tai, D., McGuire, K., Eng, J. J., Hsiung, G. R., Middleton, L. E., Hall, P. A., Hu, M., Sakakibara, B. M., & Liu-Ambrose, T. (2023). Economic Evaluation of Exercise or Cognitive and Social Enrichment Activities for Improved Cognition After Stroke. JAMA network open, 6(11), e2345687. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.45687
Andersen, A. G., Miles, A., Mahoney, C. & Robinson, P. (2002). Evaluating the Effectiveness of Applied Sport Psychology Practice: Making the Case for a Case Study Approach. The Sport Psychologist 16(4), 432-453. https://doi.org/10.1123/tsp.16.4.432
Borsboom, D., & Mellenbergh, G. J. (2007). Test validity in cognitive assessment. In J. P. Leighton & M. J. Gierl (Eds.), Cognitive diagnostic assessment for education: Theory and applications (pp. 85–115). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511611186.004
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.
Ericsson, K. A. (2003). How the expert performance approach differs from traditional approaches to expertise in sport: In search of a shared theoretical framework for studying expert performance. In J. L. Starkes, & K. A. Ericsson (Eds.), Expert performance in sports: Advances in research on sport expertise (pp. 371–402). Human Kinetics.
Fleddermann, M. T., Heppe, H., & Zentgraf, K. (2019). Off-Court Generic Perceptual-Cognitive Training in Elite Volleyball Athletes: Task-Specific Effects and Levels of Transfer. Frontiers in Psychology, 10, 1599. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01599
Furley, P., Schütz, L., & Wood, G. (2023). A critical review of research on executive functions in sport and exercise. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1–29. https://doi.org/10.1080/1750984X.2023.2217437
Kalén, A., Bisagno, E., Musculus, L., Raab, M., Pérez-Ferreirós, A., Williams, A. M., Araújo, D., Lindwall, M., & Ivarsson, A. (2021). The role of domain-specific and domain-general cognitive functions and skills in sports performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 147(12), 1290–1308. https://doi.org/10.1037/bul0000355
Keegan, R. & Cotteril, S. & Woolway, T. & Appaneal, R. & Hutter, V. (2017). Strategies for bridging the research-practice 'gap' in sport and exercise psychology. Journal of Sport Psychology, 26 (4), 75-80. ttps://www.rpd-online.com/article/view/v26-n6-keegan-cotteril-woolway-etal
Moosbrugger, H. & Kelava, A. (2011). Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. Springer.
Musculus, L., Lautenbach, F., Knöbel, S., Reinhard, M. L., Weigel, P., Gatzmaga, N., Borchert, A., & Pelka, M. (2022). An Assist for Cognitive Diagnostics in Soccer: Two Valid Tasks Measuring Inhibition and Cognitive Flexibility in a Soccer-Specific Setting With a Soccer-Specific Motor Response. Frontiers in Psychology, 13:867849, 1–15. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.867849
Smith, B., Williams, O., Bone, L. & the Moving Social Work Co-productive Collective (2023). Co-production: A resource to guide co-producing research in the sport, exercise, and health sciences. Qualitative Research in Sport, Exercise & Health, 15(2), 159-187. https://doi.org/10.1080/2159676X.2022.2052946
Voss, M.W., Kramer, A.F., Basak, C., Prakash, R.S. & Roberts, B. (2010). Are expert athletes ‘expert’ in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport expertise. Applied Cognitive Psychology, 24, 812-826. https://doi.org/10.1002/acp.1588
Zentgraf, K., & Raab, M. (2023). Excellence and expert performance in sports: what do we know and where are we going? International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1–21. https://doi.org/10.1080/1612197x.2023.2229362