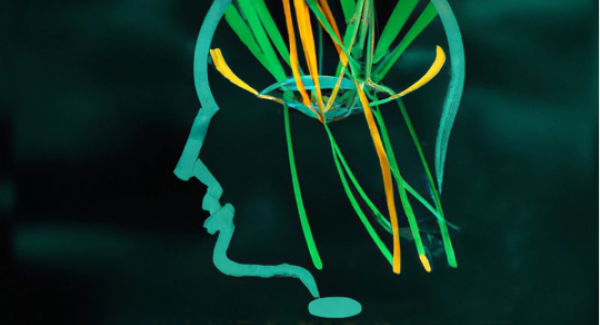Consideriamo l'esempio di Emma, una nuotatrice che si prepara per le prossime Olimpiadi estive. Per prepararsi mentalmente e fisicamente alla competizione sta creando una lista in modo da pianificare attentamente la sua routine di (pre-)performance. Dopo aver spuntato diversi elementi i suoi occhi si fermano sulla gestione del livello di attivazione fisiologica ed emotiva. Emma sa che le succede di provare ansia prima della gara e che questo richiede l’impiego di tecniche di rilassamento. Tuttavia, non vuole essere troppo rilassata quando la gara inizia ed essere, di conseguenza, svantaggiata rispetto alle altre concorrenti. Come dirimere questo dilemma e raggiungere l'attivazione ottimale di mente e corpo? Per rispondere a questa domanda, proponiamo di approfondire la modifica volontaria della respirazione.
Le quattro principali tecniche di modifica volontaria della respirazione e la loro origine
La respirazione è essenziale per la sopravvivenza di ogni essere umano. L'importanza della respirazione è stata riconosciuta in tutte le epoche sin dall'antichità; le culture orientali sono particolarmente note per lo sviluppo di tecniche di modifica del respiro come il Pranayama, ovvero il controllo delle correnti vitali attraverso la regolazione del respiro (Saraswati, 1997). Oggi le tecniche di Pranayama possono essere ancora apprese ed eseguite attraverso la pratica dello Yoga. Nel contesto sportivo le tecniche di respirazione si sono evolute per soddisfare specifiche esigenze, sono più semplici rispetto alle tecniche classiche di Pranayama e più adattabili a contesti imprevedibili come quelli che si affrontano su un campo di calcio o di tennis, una pista da ghiaccio o una piscina. Nonostante queste modifiche, le tecniche di respirazione hanno molti benefici anche quando applicate nel modo più semplice. Le tecniche di respirazione applicate nello sport possono essere differenziate in base alla frequenza e alla profondità del respiro. La frequenza respiratoria viene misurata in cicli per minuto [cpm]. Un cpm comprende una inspirazione completa e una espirazione completa. Le quattro principali tecniche comunemente applicate nello sport sono: la respirazione lenta controllata, la respirazione veloce controllata, l'iperventilazione e l'apnea (Laborde et al., 2022).
La respirazione lenta controllata (RLC) rappresenta la tecnica di respirazione che ha ottenuto il maggior interesse nella ricerca e nell'applicazione sportiva. Viene eseguita a una frequenza inferiore a 10 cpm, più comunemente a 6 cpm, inspirando attraverso il naso ed espirando attraverso la bocca con le labbra socchiuse. È importante eseguire la RLC a livello addominale, il che significa che lo stomaco (anziché il torace) si espande in inspirazione e si contrae in espirazione.
Al contrario, la respirazione veloce controllata (RVC) impone un aumento della frequenza respiratoria oltre il ritmo regolare. Questa tecnica è stata studiata in misura molto minore e un protocollo universalmente stabilito deve ancora essere sviluppato. Tuttavia la RVC viene comunemente eseguita a frequenze che vanno da 25 a 60 cpm nei/lle principianti e a frequenze più elevate (120 cpm o più) nei/lle praticanti esperti/e di Pranayama. La RVC viene eseguita inspirando ed espirando superficialmente attraverso il naso per assumere piccole quantità d'aria ed evitare l'iperventilazione. Il movimento respiratorio è guidato dall'addome, come nella RLC.
L'iperventilazione volontaria (IV) è stata spesso considerata sinonimo di RVC, con la differenza cruciale nel livello di profondità della respirazione. Quando si esegue la IV, in realtà, si respira rapidamente ma assumendo maggiore quantità d'aria rispetto a quella che si assume nella RVC. Questa tecnica viene applicata con cautela e lo stato di iperventilazione è lieve e di breve durata, come sarà spiegato più avanti in maggior dettaglio.
Infine l'apnea (AP), come suggerisce la parola stessa, comporta periodi (chiamati appunto apnee) in cui il/la praticante non inspira né espira. Le apnee possono essere eseguite dopo un'inspirazione completa o un'espirazione completa.
 Figura 1. Tecniche di regolazione volontaria della respirazione classificate a seconda della frequenza e della profondità respiratorie (proprietà degli autori)
Figura 1. Tecniche di regolazione volontaria della respirazione classificate a seconda della frequenza e della profondità respiratorie (proprietà degli autori)
Gli effetti fisiologici e psicologici delle tecniche di respirazione
In termini generali le tecniche di respirazione possono essere classificate distinguendo quelle che mirano a indurre rilassamento psicofisiologico da quelle che mirano a indurre attivazione. A livello fisiologico la modifica volontaria del respiro provoca cambiamenti nell'attività del sistema nervoso autonomo che è diviso a sua volta in: sistema parasimpatico e sistema simpatico, altresì comunemente noti come “riposa e digerisci” e “lotta o fuggi”. L'aumento dell'attività del parasimpatico riflette il rilassamento, un'attività più elevata nel simpatico segnala attivazione. Oltre al sistema nervoso autonomo la respirazione modula anche l'attività cerebrale influenzando processi cognitivi, emotivi e senso-motori (Heck et al., 2017). Gli effetti positivi delle singole tecniche di respirazione sulla performance sembrano essere spiegati proprio da tutti questi cambiamenti fisiologici indotti dalla manipolazione volontaria della respirazione.

Figura 2. Tecniche di regolazione volontaria della respirazione secondo il meccanismo principale di regolazione autonomica (proprietà degli autori)
Dopo aver appreso come eseguire correttamente ogni tecnica, il passo successivo verso l'uso efficace della respirazione modificata nella performance sportiva è una comprensione completa degli effetti specifici che ciascuna tecnica esercita su corpo e mente. La RLC aumenta l'attività del sistema parasimpatico attraverso l'attivazione del nervo vago, promuovendo il rilassamento psicofisiologico. Questo effetto può essere accentuato prolungando la fase espiratoria e quindi beneficiando della naturale diminuzione della frequenza cardiaca che si verifica quando espiriamo. A livello teorico la RLC sembra influenzare il collegamento bidirezionale tra cervello e cuore, in linea con il modello di integrazione neuroviscerale (Neurovisceral Integration Model; Sevoz-Couche & Laborde, 2022; Smith et al., 2017). Attivando specifiche aree cerebrali connesse tra di loro, come il central autonomic network, e aumentando la variabilità della frequenza cardiaca mediata dal nervo vago, un indice di attività parasimpatico, la RLC sembra migliorare l'autoregolazione a livello emotivo, cognitivo e cardiaco. Una efficiente autoregolazione può aiutare gli atleti e le atlete a contrastare i sintomi debilitanti dell'ansia pre-competitiva, come succede nel caso di scarsa attività del parasimpatico, e a contrastare anche la comparsa di emozioni negative. A livello cognitivo la RLC influenza positivamente attenzione, inibizione, memoria di lavoro e flessibilità mentale (es. Laborde et al., 2019, Paul & Garg, 2012).
Agli effetti attivanti della RVC e della IV sono stati attribuiti un aumento dell’attività simpatica e una diminuzione dell'attività parasimpatica. Durante una risposta di “combatti o fuggi” si noterà, ad esempio, un aumento della frequenza cardiaca e della quantità di ossigeno utilizzato dal corpo. Questo cambiamento fisiologico migliora la produzione e l'apporto di energia, migliorando di conseguenza il funzionamento muscolare in particolare nelle fibre muscolari a contrazione rapida. Inoltre, durante la IV, il pH del sangue aumenta causando costrizione dei vasi sanguigni e riducendo la nostra esigenza di respirare. Nonostante le somiglianze, le percezioni soggettive di queste due tecniche possono differire: mentre sentirsi energizzati e all'erta è comune dopo la RVC, l'iperventilazione prolungata è accompagnata da panico e irrequietezza (Balters et al., 2018; Gilbert, 1999), ragioni per cui il termine "iperventilazione" è spesso percepito negativamente. A tale proposito va osservato che nel caso in cui effettua la IV l’individuo esercita un controllo intenzionale sul proprio schema respiratorio, al contrario, nell’ iperventilazione indotta dall’ansia l’individuo non è in grado di controllare tale iperventilazione. Tuttavia popolazioni specifiche, come pazienti affetti/e da disturbi di panico, sperimentano sensazioni significativamente più negative durante la IV rispetto a pazienti sani/e, nonostante presentino risposte fisiologiche simili (Wollburg et al., 2008). Questa scoperta è stata attribuita al fraintendimento relativo ai segnali corporei che sono stati interpretati, erroneamente, come ansia a livello cognitivo e ha suggerito cautela nell'implementare la IV negli atleti e nelle atlete affetti/e da disturbi di panico e ansia.
Curiosamente, la AP induce co-attivazione parasimpatica e simpatica, aumentando l'attività in entrambi i rami. Al contrario di quanto accade durante l'iperventilazione, il pH del sangue diminuisce durante la AP, causando la dilatazione dei vasi sanguigni. Altri cambiamenti nel corpo includono una riduzione della frequenza cardiaca e la redistribuzione del flusso sanguigno per preservare la funzione degli organi.
A causa di questi effetti distinti, ciascuna tecnica deve essere implementata in modo mirato per facilitare, e non ostacolare, le performance sportive. La sezione seguente, utilizzando esempi provenienti dalle discipline olimpiche, presenta il momento più opportuno in cui gli atleti dovrebbero applicare tecniche di respirazione specifiche.
Implementazione delle tecniche di respirazione negli sport (olimpici)
Le possibilità di implementazione pratica delle tecniche introdotte differiscono a seconda delle discipline sportive a causa della varietà di richieste cognitive e motorie che gli atleti devono soddisfare (vedi Laborde et al., 2022). Gli/le sprinter nella gara di 100 metri possono beneficiare maggiormente da un'attivazione rapida, mentre un set più diversificato di tecniche di respirazione dovrebbe essere adattato ai/lle maratoneti/e per affrontare varie fasi della prestazione. Inoltre, la respirazione può essere modificata non solo durante la performance sportiva ma anche prima e dopo l'attività principale.
Grazie all'effetto rilassante generale della RLC questa tecnica è stata utilizzata in una varietà di discipline sportive, così come nella vita di tutti i giorni. I benefici della pratica regolare della RLC sono stati dimostrati nel basket, nella danza, nella corsa, nel nuoto e nel ciclismo. Il potenziale di questa tecnica risiede nella sua pratica regolare, che consente l'adattamento fisiologico. Per incorporare in modo ottimale la RLC nella pratica gli atleti e le atlete possono eseguire questa tecnica prima o dopo le sessioni di allenamento. Inoltre, la RLC può diventare una tecnica essenziale per contrastare l'ansia o lo stress pre-competizione. Gli atleti e le atlete possono anche beneficiare degli effetti rilassanti post-competizione o post-allenamento per recuperare mentalmente e fisicamente. Non è consigliabile eseguire la RLC e introdurla in allenamento o in gara senza averla praticata e assimilata prima poiché, se non viene allenata correttamente, può portare a disagio respiratorio e declino della performance.
L'effetto attivante della RVC la rende una tecnica ottimale da implementare immediatamente prima di una sessione di esercizio breve e intenso in cui agli atleti e alle atlete è richiesta forza massima o in cui devono essere altamente vigili. Ad esempio i lanciatori di peso possono implementare questa tecnica prima che venga richiesta la loro forza massima sul campo. Questa tecnica può essere praticata anche nella vita di tutti i giorni poiché permette di beneficiare dei suoi effetti di attivazione generale e di rafforzamento addominale. Può essere integrata anche in una routine mattutina perché consente di essere concentrati e attivati in maniera ottimale per la successiva pratica sportiva.
L'aumento del pH del sangue ottenuto attraverso la IV rende questa tecnica una strategia ottimale per consentire un rapido recupero tra attività che richiedono sforzo intenso, a scatto. Un corridore che esegue serie di sprint come parte di una sessione di allenamento può, per esempio, eseguire 20-30 secondi di IV durante la fase di recupero per consentire un recupero più rapido per la serie successiva. Nel ciclismo la IV eseguita per 30 secondi prima di ogni serie di sprint può supportare il mantenimento della potenza sostenuta per l'intero esercizio (Sakamoto et al., 2014). A causa dell'aumento del movimento corporeo causato dall'esecuzione di questa tecnica non è consigliabile implementarla durante sport che richiedono equilibrio. È particolarmente importante, al momento di fornire le istruzioni, dare una spiegazione dettagliata degli effetti attesi e presentare positivamente questa tecnica respiratoria, poiché i cambiamenti fisiologici che si verificano durante la IV possono essere erroneamente interpretati come ansia.
La AP induce benefici fisiologici simili a quelli ottenuti quando ci si allena ad alta quota, a causa della restrizione di assunzione dell’ossigeno. Questa tecnica può costituire un'opportunità per risparmiare tempo e costi quando tali adattamenti fisiologici sono vantaggiosi per le performance, ad esempio nel caso dei mezzofondisti. Le apnee di varia durata, inoltre, sono comunemente implementate durante l'allenamento nel nuoto poiché le fasi di AP sono strettamente associate all'esecuzione del movimento. Questa tecnica può essere incorporata in molti programmi di allenamento in varie discipline e i suoi benefici fisiologici sono visibili soprattutto dopo interventi di lunga durata. Ad esempio, l’implementazione dell’AP, per due settimane, durante gli allenamenti di nuoto ha portato gli atleti e le atlete a nuotare più velocemente a stile libero e sott'acqua; questo risultato trova spiegazione nella riduzione della frequenza cardiaca (Mulder et al., 2021). Non è consigliabile seguire la AP durante le gare (in discipline diverse da nuoto/tuffi) poiché la ridotta fornitura di ossigeno ai muscoli può ostacolare la performance.

Figura 3. Caratteristiche delle quattro principali tecniche di regolazione volontaria della respirazione (proprietà degli autori)
Caso in evidenza: un esempio pratico dell’uso delle tecniche di respirazione nel nuoto olimpico e paralimpico
L'uso di una singola tecnica di respirazione, quando implementata in modo appropriato, può risultare vantaggioso per l’atleta a cui in gara è richiesto un alto livello di competitività, tuttavia l'uso mirato di una gamma di tecniche di respirazione può essere ancora più potente poiché l'atleta può adattare in modo flessibile la propria respirazione a seconda delle diverse esigenze della prestazione sportiva e delle necessità individuali. Nel caso menzionato prima, quello della nostra nuotatrice Emma, attingiamo all'esperienza di nuotatori e nuotatrici olimpici e paralimpici riguardo all'uso della respirazione modificata nei contesti di performance (Saint-Martin et al., 2020). I nuotatori e le nuotatrici hanno riferito, nel complesso, di avere utilizzato diverse tecniche di respirazione per migliorare le performance e regolare le emozioni. Risultava evidente la selezione intenzionale della tecnica, per l’implementazione delle condizioni psicofisiche ottimali, in base alle diverse esigenze in diversi momenti: "Durante il riscaldamento ho usato la respirazione lenta controllata, ma proprio prima dell'annuncio ho iniziato a fare respirazioni più veloci" (Saint-Martin et al., 2020, p. 3573). Inoltre l'apnea e la respirazione sincronizzata al movimento sono state utilizzate durante la gara di nuoto per supportare i movimenti ritmici richiesti dall’attività. Nello stile libero, ad esempio, i nuotatori e le nuotatrici possono abbinare l'inspirazione alle rotazioni del corpo e alternare i respiri a sinistra e destra per mantenere l'equilibrio.

Figura 4. Implementazione delle tecniche di respirazione durante il nuoto (proprietà degli autori)
E per quanto riguarda il periodo di recupero? Nessuno dei nuotatori e delle nuotatrici ha riferito di utilizzare la RLC dopo la performance nonostante il suo potenziale come tecnica di recupero. Curiosamente alcuni nuotatori e alcune nuotatrici hanno riferito di non utilizzare le tecniche di respirazione poiché non erano a conoscenza delle modalità per eseguirle efficacemente. Questa scoperta evidenzia l'importanza di fornire raccomandazioni strutturate e facilmente accessibili su come implementare tecniche di respirazione nell’ambito sportivo.
Raccomandazioni per l'uso delle tecniche di respirazione
Per implementare correttamente ed efficacemente la respirazione nello sport serve adattarla alle caratteristiche specifiche della disciplina e dell’atleta. In generale si consiglia di svolgere una sessione di familiarizzazione quando si effettua l'implementazione di queste tecniche, poiché potrebbero portare a sensazioni spiacevoli durante la respirazione e ad effetti negativi se eseguite in modo errato. Tale implementazione dovrebbe essere effettuata sempre prima in allenamento per rispettare la regola "Non fare nulla di nuovo in una competizione" (Riewald & Rodeo, 2015, p. 226). Sono disponibili diverse app per la respirazione che forniscono una guida pratica per eseguire queste tecniche, tuttavia per garantire la corretta esecuzione delle tecniche di respirazione e il monitoraggio degli effetti consigliamo di rivolgersi a uno specialista.
In conclusione la potenza della modifica volontaria della respirazione risiede nella sua implementazione flessibile e tempestiva. Gli atleti e le atlete d'élite possono ottenere un vantaggio in gara considerando una gamma di tecniche di respirazione e abbinando i loro effetti alle specifiche esigenze richieste da allenamento e gara. Oltre a migliorare la performance fisica le tecniche di respirazione descritte hanno un grande potenziale anche come strumenti per ottenere benefici psicologici come maggiore vigilanza, effetti energizzanti, riduzione dell'ansia in pre-performance maladattiva e miglioramento della memoria di lavoro.
Glossario
Central autonomic network (CAN): è una rete di aree cerebrali corticali e sottocorticali interconnesse. E’ coinvolta nella regolazione dei processi di funzionamento degli organi interni e del sistema endocrino, nella modulazione del dolore e nelle risposte motorie complesse (vedi Benarroch, 1993).
Variabilità della frequenza cardiaca mediata dal nervo vago: è la variazione dell’intervallo di tempo che passa tra un battito cardiaco e il successivo, dovuta all’aumento dell’attività del nervo vago, il principale nervo del sistema nervoso parasimpatico (Laborde et al., 2023).
Bibliografia
Balters, S., Murnane, E. L., Landay, J. A., & Paredes, P. E. (2018, May 21). Breath booster!:
Proceedings of the 12th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare. PervasiveHealth ’18: 12th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare, New York NY USA. https://doi.org/10.1145/3240925.3240939
Benarroch, E. E. (1993). The central autonomic network: functional organization, dysfunction, and perspective. Mayo Clinic Proceedings, 68(10), 988-1001.
Eichhorn, L., Erdfelder, F., Kessler, F., Dolscheid-Pommerich, R. C., Zur, B., Hoffmann, U.,
Ellerkmann, R. E., & Meyer, R. (2017). Influence of Apnea-induced Hypoxia on Catecholamine Release and Cardiovascular Dynamics. International Journal of Sports Medicine, 38(2), 85–91. https://doi.org/10.1055/s-0042-107351
Gilbert, C. (1999). Hyperventilation and the body. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2(3), 184-191. https://doi.org/10.1016/s0965-2302(99)80072-1
Heck, D. H., McAfee, S. S., Liu, Y., Babajani-Feremi, A., Rezaie, R., Freeman, W. J., Wheless, J. W., Papanicolaou, A. C., Ruszinko, M., & Kozma, R. (2017). Breathing as a Fundamental Rhythm of Brain Function. Frontiers in Neural Circuits, 10, Article 115. https://doi.org/10.3389/fncir.2016.00115
Laborde, S., Lentes, T., Hosang, T. J., Borges, U., Mosley, E., & Dosseville, F. (2019). Influence of Slow-Paced Breathing on Inhibition After Physical Exertion. Frontiers in Psychology, 10, 1923. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01923
Laborde, S., Mosley, E., & Thayer, J. F. (2017). Heart Rate Variability and Cardiac Vagal Tone in Psychophysiological Research - Recommendations for Experiment Planning, Data Analysis, and Data Reporting. Frontiers in Physiology, 8, 213. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00213
Laborde, S., Zammit, N., Iskra, M., Mosley, E., Borges, U., Allen, M. S., & Javelle, F. (2022). The influence of breathing techniques on physical sport performance: A systematic review and meta-analysis. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1-56. https://doi.org/10.1080/1750984X.2022.2145573
Mulder, E. R., Holmström, P. K., & Schagatay, E. K. (2021). Effects of dynamic apnea training on diving bradycardia and short distance swimming performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 62(8), 1037-1044. https://doi.org/10.23736/s0022-4707.21.12549-6
Paul, M., & Garg, K. (2012). The effect of heart rate variability biofeedback on performance psychology of basketball players. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 37(2), 131–144. https://doi.org/10.1007/s10484-012-9185-2
Riewald, S. A., & Rodeo, S. A. (2015). Science of swimming faster. Human Kinetics.
Saint-Martin, S. V., Turner, M. J., & Ruiz, M. C. (2020). Mental preparation of Olympic and paralympic swimmers: performance-related cognitions and emotions, and the techniques used to manage them. Journal of Physical Education and Sport, 20(6). https://doi.org/10.7752/jpes.2020.06481
Sakamoto, A., Naito, H., & Chow, C. M. (2014). Hyperventilation as a strategy for improved repeated sprint performance. The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(4), 1119-1126. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182a1fe5c
Saraswati, S. (1997). Practical Lessons in Yoga (8th ed.). A divine life society publication.
Sevoz-Couche, C., & Laborde, S. (2022). Heart rate variability and slow-paced breathing: when coherence meets resonance. Neuroscience & Biobehavorial Reviews, 135, 104576. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.104576
Smith, R., Thayer, J. F., Khalsa, S. S., & Lane, R. D. (2017). The hierarchical basis of neurovisceral integration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 75, 274-296. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.02.003
Wollburg, E., Meuret, A. E., Conrad, A., Roth, W. T., & Kim, S. (2008).Psychophysiological reactions to two levels of voluntary hyperventilation in panic disorder. Journal of Anxiety Disorders, 22(5), 886-898. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2007.09.004
 Figura 1. Tecniche di regolazione volontaria della respirazione classificate a seconda della frequenza e della profondità respiratorie (proprietà degli autori)
Figura 1. Tecniche di regolazione volontaria della respirazione classificate a seconda della frequenza e della profondità respiratorie (proprietà degli autori)