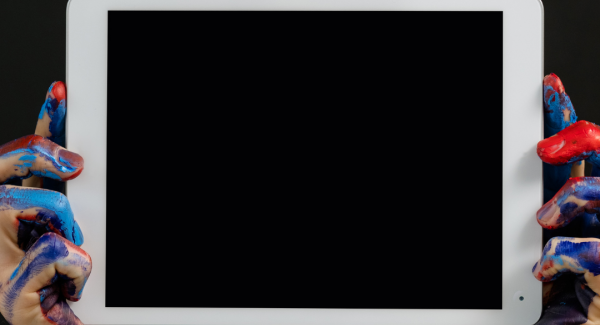“La visione psichedelica è realtà per me” - John Lennon
Gli psichedelici sono una classe di composti, presenti in natura ma anche sintetizzabili in laboratorio, la maggioranza dei quali agisce sul cervello replicando l'azione della serotonina, cioè uno dei messaggeri chimici tramite cui i neuroni comunicano normalmente tre loro (Nichols, 2004). I più noti sono probabilmente l’LSD e i principi attivi dei “funghetti” allucinogeni, del peyote, e del’ayahuasca. Il termine “psichedelici,” che letteralmente significa “rivelatori della mente” (Osmond, 1957), si riferisce ai loro effetti di alterazione della coscienza: sono infatti in grado di modificare la percezione non solo dell’ambiente (rendendola più vivida e dettagliata o addirittura facendo percepire cose non realmente presenti) ma anche del proprio corpo e persino del proprio “sé,” fino ad indurre, a dosi elevate, la sensazione di perdere la propria individualità e divenire tutt’uno con l’universo (Hartogsohn, 2018). Negli anni Sessanta, l’uso di sostanze psichedeliche divenne un’icona della controcultura hippie, venendo utilizzate come strumenti per sfidare le convenzioni, ampliare la percezione e favorire esperienze percepite come “spirituali” (Huxley, 1968; Leary et al., 2017). Altrettanto rilevante è stato l’impatto della psichedelia sulla comunità scientifica dell’epoca; numerosi sono stati infatti gli studi e le osservazioni sulle potenzialità di queste sostanze per il trattamento di varie psicopatologie (Naranjo, 1974; Shulgin & Shulgin, 1991). Tuttavia l’associazione degli psichedelici con la controcultura hippie ha fatto sì che negli anni queste sostanze subissero una sistematica stigmatizzazione e venissero equiparate a livello legale a droghe d’abuso come l’eroina o la cocaina (ad esempio, attraverso il “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope”), nonostante gli psichedelici non causino dipendenza fisica e siano nettamente più sicuri (Carbonaro et al., 2016; Nichols, 2004; Nutt et al., 2007). Il risultato è stata una drastica interruzione della ricerca psichedelica. Nell’ultimo decennio, però, si è assistito a un risorgere della sperimentazione scientifica e della ricerca sulle sostanze psichedeliche (Yaden et al., 2021). Tale fenomeno, denominato Rinascimento Psichedelico, ha risollevato l’interesse verso il potenziale terapeutico degli psichedelici. Ad esempio, è stato riscontrato che la terapia psichedelica sarebbe efficacie per trattare condizioni come la depressione (Carhart-Harris et al., 2017; Griffith et al., 2016), l’ansia (Grob et al., 2011; Griffith et al., 2016) e il disturbo da stress post-traumatico (Sessa, 2017; Sessa et al., 2019). Per spiegare questi effetti sono stati proposti diversi meccanismi (si veda per una rassegna Swanson, 2018). La maggior parte di essi si basa sull’idea, già avanzata nel secolo scorso (Huxley, 1961), secondo la quale la consapevolezza e la capacità di interpretazione degli stimoli esterni viene limitata da processi di selezione psicofisiologici, che escludono una grande quantità di informazioni processate esclusivamente a livello subconscio (Marshall, 2005). La nostra percezione sarebbe quindi limitata a un “mondo costruito dalle nostre percezioni e pensieri quotidiani, biologicamente utili e socialmente condizionati” (Huxley, 1961; p. 214). Le sostanze psichedeliche andrebbero dunque ad allargare le maglie di questo sistema di filtraggio automatico (Huxley, 1961; Marshall, 2005). Una rielaborazione più recente e rigorosa di questa idea è basata sul modello della codifica predittiva (Friston, 2010). Secondo tale modello, la funzione principale del cervello umano sarebbe quella di formulare ipotesi sul mondo circostante basandosi su credenze ed esperienze passate. In altre parole, il cervello umano sarebbe in grado di creare modelli predittivi che vengono costantemente applicati per interpretare le nostre percezioni. A una maggiore capacità predittiva corrisponderebbe infatti una maggiore efficienza nel rispondere all’ambiente, a discapito però della quantità di informazioni sensoriali percepite a livello cosciente; infatti, arriverebbero alla coscienza solo le informazioni in contraddizione con i modelli predittivi (Friston, 2010). Sembra però che le sostanze psichedeliche siano in grado di attenuare l’influenza di tali modelli predittivi (Carhart-Harris & Friston, 2019). Ciò permetterebbe a un numero maggiore di stimoli di raggiungere la coscienza, consentendo dunque un’esperienza del mondo più ricca e, per citare Huxley (1968), aprendo così “le porte della percezione”. Più in generale, gli psichedelici interferirebbero con i meccanismi che mantengono stabili determinati modelli interpretativi della realtà e le connessioni neurali alla base di essi, favorendo in tal modo nuove interpretazioni e nuove connessioni neurali, fino a destabilizzare credenze patologiche sul mondo che si sono consolidate e “iper-stabilizzate” (Carhart-Harris & Friston, 2019). L’azione terapeutica degli psichedelici sarebbe riconducibile soprattutto al disgregamento di una rete di connessioni neurali chiamata Default Mode Network (Carhart-Harris et al., 2012; Carhart-Harris & Friston, 2019; Lebedev et al., 2015). Tale rete risulta molto attiva quando il cervello non si trova impegnato in compiti specifici, e in particolare nei momenti di introspezione (Carhart-Harris & Friston, 2010). È stato ipotizzato che l’iperattivazione del Default Mode Network, caratteristica di persone affette da depressione, rappresenterebbe il correlato fisiologico dei pensieri ossessivi e dell’eccessivo rimuginare (Berman et al., 2011). Disconnettendo tra loro i nodi del Default Mode Network, gli psichedelici avrebbero quindi il potenziale di indebolire tali meccanismi di pensiero dannosi. Tuttavia, l’assunzione di psichedelici può comportare una serie di effetti negativi, che vanno dai cosiddetti bad trips, ossia esperienze psichedeliche terrificanti (Carbonaro et al., 2016; Griffith et al., 2011), alla persistenza delle allucinazioni anche molto tempo dopo l’esperienza (Halpern & Pope, 1999, 2003; Martinotti et al., 2018), fino al pericolo di indurre stati psicotici in persone predisposte (Carbonaro et al., 2016). Questo, unitamente allo status legale di molte sostanze psichedeliche e allo stigma sociale che le circonda, rende problematica la ricerca scientifica e la diffusione di eventuali terapie basate su di esse. Una possibile soluzione alle problematiche sopracitate viene oggi offerta dalle moderne tecnologie digitali, grazie alle cosiddette esperienze tecnodeliche. Con questo termine ci si riferisce ad alterazioni della coscienza indotte attraverso tecnologie di Virtual Reality (VR), e in generale mediante l’utilizzo di strumenti audiovisivi (Arnott, 2020). Tali esperienze, nonostante siano in una certa misura paragonabili agli stati causati dagli psichedelici (Aday et al., 2020; Magni et al., 2023), non prevedono l’assunzione di sostanze, tanto meno illegali o socialmente stigmatizzate, e non dovrebbero avere effetti collaterali a parte l’eventuale malessere (detto “cybersickenss”) tipico di molte esperienze in VR (Aday et al., 2020; Treleaven et al., 2015). Inoltre, a differenza delle sessioni con sostanze psichedeliche, che normalmente durano svariate ore e per le quali sono necessarie settimane di preparazione (Sessa, 2017), le esperienze tecnodeliche hanno una durata arbitraria e richiedono solo una spiegazione tecnica come per qualunque esperienza in VR (Glowacki et al., 2020, 2022).
Esperienze tecnodeliche e prime evidenze sperimentali
Recentemente, diversi gruppi di ricerca in ambito neuroscientifico e psicologico hanno iniziato a esplorare le potenzialità della VR nel produrre alterazione della coscienza. Ad esempio, Suzuki e colleghi (2017) hanno provato a riprodurre le allucinazioni indotte dagli psichedelici attraverso l’uso di visori per la VR. I ricercatori si sono serviti di un’intelligenza artificiale chiamata DeepDream, sviluppata da Google a partire da reti neurali per la classificazione di immagini. Laddove queste ultime analizzano una data immagine comparandola con modelli astratti a vari livelli di elaborazione, DeepDream modifica invece l’immagine di partenza affinché rifletta i modelli che sono codificati a un determinato livello. In altre parole, se nel caso di un normale classificatore di immagini viene selezionata la categoria che si adatta meglio all’immagine, nel caso di DeepDream è l’immagine ad essere adattata ai modelli preesistenti. Il risultato finale avrebbe le caratteristiche di un’allucinazione visiva (figura 1 - Esempio di immagine generata con DeepDream a partire da una foto di due meduse; fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Deep_Dream). È stato proposto che questo processo mimerebbe proprio il meccanismo cerebrale alla base delle allucinazioni secondo la teoria della codifica predittiva (Suzuki et al., 2017). Infatti, secondo alcuni autori, le allucinazioni risulterebbero da un rafforzamento dei modelli predittivi, i quali verrebbero così applicati anche in assenza di stimoli (Corlett et al., 2009; Sterzer et al., 2018). Tuttavia, va sottolineato come altri autori spieghino le allucinazioni attraverso un meccanismo inverso, cioè come un’attenuazione dei modelli predittivi che normalmente filtrano il rumore di fondo dalle cortecce sensoriali (Carhart-Harris & Friston, 2019; Sterzer et al., 2018). Suzuki e colleghi (2017) si sono dunque serviti di DeepDream per modificare uno scenario in VR e ricreare così un’esperienza allucinatoria. Ai partecipanti e alle partecipanti che avevano fatto tale esperienza è stato poi somministrato un questionario per valutare se questa avesse prodotto uno stato di alterazione della coscienza. I punteggi ottenuti erano paragonabili a quelli tipici delle esperienze con sostanze psichedeliche. Tuttavia, quando i ricercatori hanno verificato l’effetto dell’esperienza sulla percezione del tempo, notoriamente alterata durante le esperienze psichedeliche, non hanno riscontrato risultati significativi (Suzuki et al., 2017). Del resto, riprodurre le alterazioni della percezione causate dalle sostanze psichedeliche non equivale necessariamente a creare lo stato alterato di coscienza che le induce (Aday et al., 2020). Glowacki e il suo team (2020, 2022) si sono invece concentrati sull’esperienza di dissoluzione dell’io indotta da elevate dosi di sostanze psichedeliche (Carhart-Harris et al., 2012; Lebedev et al., 2015). Tale esperienza consiste nella sensazione di essere tutt’uno con l’universo e sembra essere anch’essa collegata al disgregamento funzionale del Default Mode Network. I ricercatori e le ricercatrici si sono posti l’obiettivo di ottenere il medesimo effetto attraverso la VR. L’esperienza da loro sviluppata è stata battezzata “Is-ness,”, ossia la parola con cui Aldous Huxley, scrittore e filosofo britannico di metà Novecento, si riferisce alle qualità delle cose di "essere e basta,” che lui racconta di aver esperito sotto l’effetto della mescalina (Huxley, 1968). Durante l’esperienza “Is-ness”, i/le partecipanti si incarnavano in corpi costituiti di una materia evanescente e luminosa. Inoltre, trattandosi di un’esperienza collettiva, gli individui potevano osservare il proprio corpo mescolarsi con quello degli altri partecipanti. I risultati indicano che l’esperienza da loro vissuta è qualitativamente simile alle esperienze psichedeliche classiche, con effetti paragonabili all'assunzione di psilocibina e LSD. Anche per quanto concerne la sensazione di comunione tra i/le partecipanti , i risultati erano statisticamente indistinguibili da quelli riscontrati durante sessioni di gruppo con sostanze psichedeliche (Glowacki et al., 2020, 2022). Una ulteriore prova a favore dell’efficacia delle esperienze tecnodeliche arriva da un altro recente lavoro scientifico (Martial et al., 2023). In particolare, le ricercatrici e i ricercatori si sono focalizzati sugli stati dissociativi tipici dell’assunzione di elevate dosi di Ketamina (Muetzelfeldt et al., 2008). In una prima fase dell’esperienza VR sviluppata dal gruppo di ricerca (Bourdin et al., 2017; Martial et al., 2023), i/le partecipanti si incarnavano in avatar che riproducevano i loro corpi fisici, e i cui movimenti erano coerenti con quelli del proprio corpo fisico. Il senso di appartenenza del corpo virtuale veniva ulteriormente rinforzato da feedback tattili. In una seconda fase dell’esperienza, il punto di vista si sollevava, consentendo così ai partecipanti e alle partecipanti di osservare il corpo virtuale dall’esterno, ma riuscendo ancora a muoverlo e ricevendo i medesimi feedback tattili così da dare l’illusione che fosse comunque ancora il proprio corpo. Le persone coinvolte nello studio hanno riportato di aver avuto effettivamente la percezione di essere fuori dal corpo, seppure tale percezione non sembra essere stata particolarmente intensa (Bourdin et al., 2017; Martial et al., 2023). Inoltre, durante l’esperienza, le ricercatrici e i ricercatori hanno monitorato l’attività cerebrale dei soggetti tramite elettroencefalografia. Le analisi hanno mostrato come l’esperienza extracorporea indotta tramite la VR fosse correlata a un aumento delle onde delta e a una diminuzione delle onde alfa. È interessante notare come questo tipo di variazioni dell’attività cerebrale caratterizzino anche le esperienze provocate da sostanze psichedeliche (Timmermann et al., 2019). Del resto, le onde alfa sembrerebbero mediare proprio l’imposizione dei modelli predittivi sugli stimoli sensoriali, e dunque una loro riduzione corrisponderebbe all’attenuazione di tali modelli (Carhart-Harris & Friston, 2019; Mayer et al., 2015).
Tecnodelia, quali benefici?
Nonostante i risultati incoraggianti, rimane tuttavia da chiarire se le esperienze tecnodeliche possono offrire gli stessi benefici terapeutici attribuiti alle sostanze psichedeliche. A questo proposito, è però degno di nota che le esperienze extracorporee indotte tramite la VR abbiano provocato una riduzione della paura della morte (Bourdin et al., 2017), un risultato che può essere accostato a quello ottenuto in pazienti oncologici terminali nei quali l’assunzione di psilocibina ha portato una diminuzione dell’ansia di fine vita (Grob et al., 2011; Griffith et al., 2016). Un tale effetto può essere dovuto al carattere trascendentale di entrambe le esperienze (Martial et al., 2023; Lebedev et al., 2015). Un altro beneficio attribuito alle sostanze psichedeliche è l’aumento della creatività (Hartogsohn, 2018; Sessa, 2008). Quest’ultima può essere misurata sperimentalmente attraverso la capacità di generare associazioni tra concetti apparentemente sconnessi, nota come pensiero divergente (Guilford, 1967). La ricerca suggerisce che gli psichedelici, destabilizzando gli schemi mentali preesistenti, promuovono un pensiero più fluido e favoriscono accostamenti di idee non convenzionali (Girn, et al., 2020; Kuiper et al., 2016; Spitzer et al., 1996). Partendo da queste evidenze, un recente studio ha indagato la possibilità di favorire il pensiero divergente attraverso esperienze tecnodeliche in VR (Rastelli et al., 2022). Dopo aver esperito uno scenario VR analogo a quello impiegato da Suzuki e colleghi (2017), i/le partecipanti sono stati sottoposti a un classico test del pensiero divergente (“Test degli utilizzi insoliti”; Torrance, 1966) durante cui veniva chiesto loro di pensare a un uso non convenzionale per un dato oggetto quotidiano. Per quanto l’esperienza non abbia incrementato il numero di usi proposti dai partecipanti rispetto all’esperienza di un ambiente non modificato con DeepDream, le connessioni semantiche tra le risposte si sono rivelate maggiormente articolate, suggerendo una modalità di pensiero meno lineare.
Conclusioni
Il dibattito sull’impiego terapeutico e sui vantaggi delle sostanze psichedeliche rappresenta ancora oggi un tema che divide la scienza così come l’opinione pubblica. Questa ambivalenza è del tutto giustificabile, dati gli innegabili effetti negativi che un abuso di queste sostanze può comportare. Tuttavia, ciò non dovrebbe rappresentare un ostacolo alla sperimentazione scientifica e alla ricerca sui benefici degli psichedelici, i quali potrebbero rivelarsi un importante alleato nella cura di particolari patologie psichiatriche. A questo proposito, le esperienze tecnodeliche in VR potrebbero aiutare chi partecipa agli studi clinici a familiarizzare con gli effetti degli psichedelici, rendendo in tal modo più sicura la sperimentazione con queste sostanze (Aday et al., 2020). Per quanto promettenti, le esperienze tecnodeliche sono ancora da considerarsi una tecnologia in fase embrionale. Ad esempio, sarebbe interessante riprodurre le alterazioni sensoriali indotte dagli psichedelici oltre a quelle della vista e dell’udito (per quanto però ad oggi vi siano in generale limitazione tecniche all’implementazione degli altri sensi in VR). La difficoltà maggior, tuttavia, è riuscire a ricreare gli stati alterati di coscienza che causano le alterazioni sensoriali e che sottendono modificazioni della biochimica del cervello indotte normalmente dall’assunzione di sostanze. Infatti, mancano dati di neuroimaging (risonanza magnetica funzionale, elettroencefalografia, ecc.) che chiariscano se vi sia un effetto sul Default Mode Network e se in generale le esperienze tecnodeliche possano in qualche modo mimare l’azione farmacologica delle sostanze psichedeliche. Se si riuscisse ad ottenere ciò attraverso media digitali immersivi come la VR, con la medesima efficacia clinica delle sostanze psichedeliche, si aprirebbe la strada all’uso delle esperienze tecnodeliche come terapia psichiatrica teoricamente priva di effetti collaterali significativi. Inoltre, la progettazione di esperienze tecnodeliche in grado di favorire il pensiero creativo potrebbe rappresentare uno strumento innovativo in grado incrementare le capacità di problem solving in maniera sicura e salutare. È inoltre concepibile che le esperienze tecnodeliche siano in grado di riprodurre altri effetti benefici attribuiti alle sostanze psichedeliche, ad esempio il senso di comunione con gli altri e con la natura, favorendo in tal modo comportamenti altruistici e ambientalisti (Forstmann et al., 2017; Hysek et al., 2014). È quindi importante che la ricerca sull’uso della tecnologia per indurre stati alterati di coscienza possa entrare attivamente nel Rinascimento Psichedelico che ha dato il via alla riscoperta della psichedelia, in maniera sicura e verso una direzione che favorisca il benessere mentale per tutti gli individui, ma senza sottovalutare la possibilità che le esperienze tecnodeliche celino effetti negativi ancora non noti.
Bibliografia
Aday, J. S., Davoli, C. C., & Bloesch, E. K. (2020). Psychedelics and virtual reality: parallels and applications. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 10, 2045125320948356.
Arnott, R. (2020, April 29). The Technodelic Manifesto. Lucid News. https://www.lucid.news/the-technodelic-manifesto/
Berman, M. G., Peltier, S., Nee, D. E., Kross, E., Deldin, P. J., & Jonides, J. (2011). Depression, rumination and the default network. Social cognitive and affective neuroscience, 6(5), 548-555.
Bourdin, P., Barberia, I., Oliva, R., & Slater, M. (2017). A virtual out-of-body experience reduces fear of death. PloS one, 12(1), e0169343.
Carbonaro, T. M., Bradstreet, M. P., Barrett, F. S., MacLean, K. A., Jesse, R., Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2016). Survey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive and negative consequences. Journal of psychopharmacology, 30(12), 1268-1278.
Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2010). The default-mode, ego-functions and free-energy: a neurobiological account of Freudian ideas. Brain, 133(4), 1265-1283.
Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain: toward a unified model of the brain action of psychedelics. Pharmacological reviews, 71(3), 316-344.
Carhart-Harris, R. L., Erritzoe, D., Williams, T., Stone, J. M., Reed, L. J., Colasanti, A., ... & Nutt, D. J. (2012). Neural correlates of the psychedelic state as determined by fMRI studies with psilocybin. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(6), 2138-2143.
Carhart-Harris, R. L., Roseman, L., Bolstridge, M., Demetriou, L., Pannekoek, J. N., Wall, M. B., ... & Nutt, D. J. (2017). Psilocybin for treatment-resistant depression: fMRI-measured brain mechanisms. Scientific reports, 7(1), 1-11.
Corlett, P. R., Frith, C. D., & Fletcher, P. C. (2009). From drugs to deprivation: a Bayesian framework for understanding models of psychosis. Psychopharmacology, 206, 515-530.
Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory?. Nature reviews neuroscience, 11(2), 127-138.
Forstmann, M., & Sagioglou, C. (2017). Lifetime experience with (classic) psychedelics predicts pro-environmental behavior through an increase in nature relatedness. Journal of Psychopharmacology, 31(8), 975-988.
Girn, M., Mills, C., Roseman, L., Carhart-Harris, R. L., & Christoff, K. (2020). Updating the dynamic framework of thought: Creativity and psychedelics. Neuroimage, 213, 116726.
Glowacki, D. R., Williams, R. R., Wonnacott, M. D., Maynard, O. M., Freire, R., Pike, J. E., & Chatziapostolou, M. (2022). Group VR experiences can produce ego attenuation and connectedness comparable to psychedelics. Scientific Reports, 12(1), 8995.
Glowacki, D. R., Wonnacott, M. D., Freire, R., Glowacki, B. R., Gale, E. M., Pike, J. E., ... & Metatla, O. (2020). Isness: using multi-person VR to design peak mystical type experiences comparable to psychedelics. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-14).
Griffiths, R. R., Johnson, M. W., Carducci, M. A., Umbricht, A., Richards, W. A., Richards, B. D., ... & Klinedinst, M. A. (2016). Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. Journal of psychopharmacology, 30(12), 1181-1197.
Griffiths, R. R., Johnson, M. W., Richards, W. A., Richards, B. D., McCann, U., & Jesse, R. (2011). Psilocybin occasioned mystical-type experiences: immediate and persisting dose-related effects. Psychopharmacology, 218, 649-665.
Grob, C. S., Danforth, A. L., Chopra, G. S., Hagerty, M., McKay, C. R., Halberstadt, A. L., & Greer, G. R. (2011). Pilot study of psilocybin treatment for anxiety in patients with advanced-stage cancer. Archives of general psychiatry, 68(1), 71-78.
Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence.
Halpern, J. H., & Pope Jr, H. G. (1999). Do hallucinogens cause residual neuropsychological toxicity?. Drug and alcohol dependence, 53(3), 247-256.
Halpern, J. H., & Pope Jr, H. G. (2003). Hallucinogen persisting perception disorder: what do we know after 50 years?. Drug and alcohol dependence, 69(2), 109-119.
Hartogsohn, I. (2018). The meaning-enhancing properties of psychedelics and their mediator role in psychedelic therapy, spirituality, and creativity. Frontiers in neuroscience, 12, 129.
Huxley, A. (1961). “Exploring The Borderlands of the Mind,” in Moksha: Aldous Huxley’s Classic Writings on Psychedelics and the Visionary Experience, eds M. Horowitz and C. Palmer (Rochester, VT: Park Street Press).
Huxley, A. (1968). The doors of perception. London: Chatto and Windus.
Hysek, C. M., Schmid, Y., Simmler, L. D., Domes, G., Heinrichs, M., Eisenegger, C., ... & Liechti, M. E. (2014). MDMA enhances emotional empathy and prosocial behavior. Social cognitive and affective neuroscience, 9(11), 1645-1652.
Kuypers, K. P. C., Riba, J., De La Fuente Revenga, M., Barker, S., Theunissen, E. L., & Ramaekers, J. G. (2016). Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking. Psychopharmacology, 233, 3395-3403.
Leary, T., Alpert, R., Metzner, R., & Dass, R. (2017). The psychedelic experience: A manual based on the Tibetan book of the dead. Citadel Press.
Lebedev, A. V., Lövdén, M., Rosenthal, G., Feilding, A., Nutt, D. J., & Carhart‐Harris, R. L. (2015). Finding the self by losing the self: Neural correlates of ego‐dissolution under psilocybin. Human brain mapping, 36(8), 3137-3153.
Magni, G., Tuena, C., & Riva, G. (2023). A predictive coding approach to psychedelic virtual-induced hallucinations and creative cognition in aging. Frontiers in Human Neuroscience, 17.
Marshall, P. (2005). “Mind beyond the brain: reducing valves and metaphysics,” in Mystical Encounters with the Natural World, (Oxford: Oxford University Press).
Martial, C., Cassol, H., Slater, M., Bourdin, P., Mensen, A., Oliva, R., ... & Núñez, P. (2023). Electroencephalographic signature of out-of-body experiences induced by virtual reality: A novel methodological approach. Journal of Cognitive Neuroscience, 35(9), 1410-1422.
Martinotti, G., Santacroce, R., Pettorruso, M., Montemitro, C., Spano, M. C., Lorusso, M., ... & Lerner, A. G. (2018). Hallucinogen persisting perception disorder: etiology, clinical features, and therapeutic perspectives. Brain Sciences, 8(3), 47.
Mayer, A., Schwiedrzik, C. M., Wibral, M., Singer, W., & Melloni, L. (2015). Expecting to see a letter: alpha oscillations as carriers of top-down sensory predictions. Cerebral Cortex, 26(7), 3146-3160.
Muetzelfeldt, L., Kamboj, S. K., Rees, H., Taylor, J., Morgan, C. J. A., & Curran, H. V. (2008). Journey through the K-hole: phenomenological aspects of ketamine use. Drug and alcohol dependence, 95(3), 219-229.
Naranjo, C. (1974). The Healing Journey. 1974.
Nichols, D. E. (2004). Hallucinogens. Pharmacology & therapeutics, 101(2), 131-181.
Nutt, D., King, L. A., Saulsbury, W., & Blakemore, C. (2007). Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse. the Lancet, 369(9566), 1047-1053.
Osmond, H. (1957). A review of the clinical effects of psychotomimetic agents. Annals of the New York academy of sciences, 66(3), 418-434.
Rastelli, C., Greco, A., Kenett, Y. N., Finocchiaro, C., & De Pisapia, N. (2022). Simulated visual hallucinations in virtual reality enhance cognitive flexibility. Scientific reports, 12(1), 4027.
Sessa, B. (2008). Is it time to revisit the role of psychedelic drugs in enhancing human creativity?. Journal of psychopharmacology, 22(8), 821-827.
Sessa, B. (2017). MDMA and PTSD treatment:“PTSD: from novel pathophysiology to innovative therapeutics”. Neuroscience letters, 649, 176-180.
Sessa, B., Higbed, L., & Nutt, D. (2019). A review of 3, 4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA)-assisted psychotherapy. Frontiers in psychiatry, 10, 138.
Shulgin, A. T., & Shulgin, A. (1991). PIHKAL: a chemical love story (Vol. 963009605). Berkeley, CA: Transform Press.
Spitzer, M., Thimm, M., Hermle, L., Holzmann, P., Kovar, K. A., Heimann, H., ... & Schneider, F. (1996). Increased activation of indirect semantic associations under psilocybin. Biological psychiatry, 39(12), 1055-1057.
Sterzer, P., Adams, R. A., Fletcher, P., Frith, C., Lawrie, S. M., Muckli, L., ... & Corlett, P. R. (2018). The predictive coding account of psychosis. Biological psychiatry, 84(9), 634-643.
Suzuki, K., Roseboom, W., Schwartzman, D. J., & Seth, A. K. (2017). A deep-dream virtual reality platform for studying altered perceptual phenomenology. Scientific reports, 7(1), 15982.
Swanson, L. R. (2018). Unifying theories of psychedelic drug effects. Frontiers in pharmacology, 9, 344412.
Timmermann, C., Roseman, L., Schartner, M., Milliere, R., Williams, L. T., Erritzoe, D., ... & Carhart-Harris, R. L. (2019). Neural correlates of the DMT experience assessed with multivariate EEG. Scientific reports, 9(1), 16324.
Torrance, E. P. (1966). Torrance tests of creative thinking. Educational and Psychological Measurement.
Treleaven, J., Battershill, J., Cole, D., Fadelli, C., Freestone, S., Lang, K., & Sarig-Bahat, H. (2015). Simulator sickness incidence and susceptibility during neck motion-controlled virtual reality tasks. Virtual Reality, 19, 267-275.
Yaden, D. B., Yaden, M. E., & Griffiths, R. R. (2021). Psychedelics in psychiatry—keeping the renaissance from going off the rails. JAMA psychiatry, 78(5), 469-470.
Glossario
Cybersickness. Senso di nausea e malessere indotto da alcune esperienze VR in persone particolarmente sensibili, analogo al mal d’auto o al mal di mare. Così come per questo questi ultimi, la cybersickness è causata da un’incongruenza tra le informazioni visive e le informazioni muscolari. Ciò si verifica soprattutto quando ci si muove all’interno di un ambiente VR. In tali casi, il movimento del campo visivo, riprodotto dal visore, non è associato ad un movimento dell’apparato locomotore, come avverrebbe normalmente. Di fronte all’impossibilità di risolvere questa incongruenza, il cervello la interpreta come i capogiri o le vergini causati da un’intossicazione, e provoca il vomito nel tentativo di espellere una sostanza tossica inesistente.
Droghe d’abuso. Sostanze sia di origine naturale che di sintesi in grado di indurre dipendenza fisica, e cioè di innescare nel tempo una serie di cambiamenti nella biochimica del cervello tali per cui interrompere l’assunzione della sostanza provoca una sindrome di astinenza. Quest’ultima è spesso caratterizzata da effetti opposti a quelli indotti della sostanza e comunque estremamente spiacevoli. La maggior parte di queste sostanze rientra nella categoria degli psicostimolanti (cocaina, metanfetamine ecc.) e dei sedativi-ipnotici (eroina e altri oppioidi, benzodiazepine, ecc.).
Elettroencefalografia. Tecnica non invasiva che permette di rilevare le oscillazioni dell’attività elettrica cerebrale attraverso una serie di elettrodi posizionati sullo scalpo. Ha un’elevata risoluzione temporale ma una risoluzione spaziale relativamente bassa: consente infatti di osservare l’andamento dell’attività cerebrale nel tempo, con una precisione nell’ordine dei millisecondi, ma non consente di individuare la localizzazione di tale attività in modo preciso.
Ketamina. Sostanza di sintesi normalmente accomunata ad altri psichedelici, ma la cui azione sottende un meccanismo diverso. Infatti, questa sostanza inibisce i recettori del glutammato di tipo NMDA, che hanno normalmente azione modulatoria. Ad alte dosi provoca stati dissociativi, cioè la sensazione che la mente si separi dal proprio corpo. Per questa ragione, è più propriamente da considerarsi un anestetico dissociativo.
LSD. Acronimo di Di-etil-ammide dell’acido lisergico (in tedesco: LysergSäureDiethylamid), cioè una sostanza sintetizzata negli anni ’30 dal chimico svizzero Albert Hoffman. Ha costituito un aspetto fondamentale della controcultura hippie (si pensi alla leggenda secondo cui le iniziali della celebre canzone “Lucy in the Sky with Diamonds” sarebbero un riferimento a questa sostanza), ed è tuttora molto diffusa negli ambienti tekno. Viene normalmente assunta sotto forma di cartoncini quadrati, con caratteristiche stampe colorate, nei quali viene imbevuta. L’azione di questa molecola sul cervello è dovuta all’attivazione dei recettori della serotonina di tipo 2A.
Onde alfa. Oscillazioni dell’attività elettrica del cervello con una frequenza compresa tra 8 e 12 Hz (oscillazioni al secondo), rilevabili attraverso l’elettroencefalografia. Questo tipo di attività caratterizza le aree cerebrali quando non sono impegnate nello svolgimento di un compito specifico, ad esempio la corteccia visiva mentre si hanno gli occhi chiusi o la corteccia motoria mentre si è fermi, e in generale è tipica dei momenti di rilassamento.
Onde delta. Oscillazioni dell’attività elettrica del cervello con una frequenza compresa tra 1 e 4 Hz (oscillazioni al secondo), rilevabili attraverso l’elettroencefalografia. Questo tipo di attività caratterizza il cervello durante il sonno.
Psichedelici. Sostanze sia di origine naturale che di sintesi in grado di provocare alterazioni della percezione, inclusa la percezione di sé. In particolare, l’assunzione di tali sostanze può causare una vasta gamma di effetti, tra cui: percezioni e immaginazione più vivide, allucinazioni, sinestesia, alterazione della percezione del tempo e dello spazio, euforia, aumento dell’empatia (anche verso oggetti inanimati), e senso di unità con il cosmo. La maggior parte degli psichedelici più noti (LSD, funghi allucinogeni, peyote, ayahuasca) agisce attivando i recettori della serotonina di tipo 2A.
Psilocibina. Principio attivo dei cosiddetti funghi allucinogeni, tipicamente appartenenti al genere psilocybe. L’azione di questa molecola sul cervello è dovuta all’attivazione dei recettori della serotonina di tipo 2A.
Virtual Reality. Ambiente simulato, creato digitalmente, che offre un’esperienza immersiva agli utenti. Utilizza tecnologie come visori e sensori per creare l’illusione di essere fisicamente presenti in un ambiente digitale, consentendo anche interazioni realistiche con elementi presenti in esso.