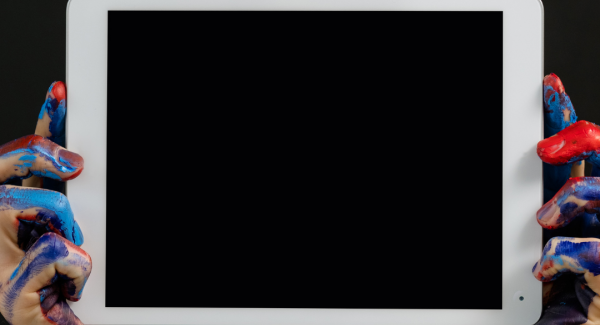Dopo 10 anni, finalmente una donna ha vinto il Festival di Sanremo. Cosi hanno titolato alcuni giornali all’indomani della finale, felicitandosi anche della presenza di ben due artiste sul podio quest’anno. Quante erano però le artiste in gara? Un terzo, non di più. La conduzione è stata affidata a un uomo; come è consuetudine, la direzione artistica anche. Questi dati ben esemplificano la presenza delle donne nel più ampio settore culturale e creativo italiano. Questo settore - che comprende ambiti vari quali musica, cinema, televisione, teatro, danza, arti figurative, oltre a professionalità molto diverse come regia, produzione, creazione artistica, supporto tecnico - vede una partecipazione delle donne generalmente limitata. Il recente rapporto annuale dell’Osservatorio per la parità di genere del Ministero della Cultura (2022) ne offre un quadro piuttosto dettagliato[1]. Iniziamo dal mondo degli audiovisivi (dati 2017-2021). Le registe sono circa il 20%; dato che scende al 9% quando si considerano solo i lungometraggi, produzioni economicamente più impegnative; percentuali simili si osservano per le sceneggiatrici (21%) e per la produzione (27%). In teatro (dati 2017-2020), le donne registe (21,6%) e drammaturghe (20,7%) rappresentano anche esse una minoranza. Se si tiene conto che i direttori di teatro sono quasi tutti uomini (sia nella prosa sia per la danza), ciò che viene visto su un palco o in un film è raramente frutto di decisioni prese da donne. Il divario di genere riguarda solo le posizioni di leadership? Non solo, le artiste ricevono in genere anche meno visibilità. Le attrici nei principali teatri sono circa il 37%. Le mostre dedicate ad artiste all’interno delle istituzioni museali sono state circa il 19% (dati 2017). In una delle più importanti vetrine della musica italiana, il Festival di Sanremo, le artiste non hanno mai superato il 36% negli ultimi 10 anni. Le donne in realtà non sono del tutto assenti, quanto piuttosto concentrate in alcuni ruoli professionali. Ad esempio, nella musica si occupano soprattutto di comunicazione, mentre sono poco presenti nelle occupazioni onstage e backstage (Paraciani, 2023). Nella produzione di audiovisivi, rappresentano la maggioranza delle addette ai costumi e al trucco; più scarsa è la presenza delle donne nel montaggio e negli effetti speciali. Il quadro che ne emerge non è molto diverso da quello di altri settori economici-produttivi. Poche donne ai vertici. Le donne sono presenti soprattutto in professioni che anche fuori dall’ambito culturale e creativo sono a prevalenza femminile, mentre sono sottorappresentate nei ruoli creativi (ad es., drammaturgia, etc.) e legati alla tecnologia (ad es., produzione musicale, ed effetti speciali).
Perché queste disparità?
Le ragioni sono in parte storiche. Anche in passato, occuparsi d’arte e cultura professionalmente era un compito perlopiù maschile. Ma non solo. Ci sono una serie di barriere che tuttora le donne incontrano nell’accedere a questo mondo, nell’acquisire visibilità e posizioni dirigenziali. Facendo riferimento alla ricerca psicosociale, verranno qui discusse tre di queste barriere: gli stereotipi sui generi e le professioni, il talento come prerequisito del successo e l’ostilità ambientale dovuta alle molestie sessuali e le microaggressioni di genere.
Stereotipi sui generi e sulle professioni. In una prospettiva binaria, la comunalità, tratti quali la sensibilità, le capacità comunicative e che più generalmente denotano un interesse per le relazioni, sono considerati femminili e pertanto appannaggio delle donne (Ellemers, 2018). A caratterizzare il maschile, sarebbe invece l’agenticità che coinvolge tratti e capacità orientate all’azione, come leadership, autonomia e determinazione (Ellemers, 2018). Queste dimensioni possono essere utilizzate anche per definire i ruoli professionali (per una più ampia trattazione su comunalità e agenticità, Abele & Wojciszke, 2019). I ruoli dirigenziali o di leadership sono, ad esempio, intesi come agentici piuttosto che comunali (e.g. Schein, 1973). La sovrapposizione tra stereotipo di genere e definizione del ruolo lavorativo spiega perché alcune professioni siano viste come più maschili e pertanto – a volte anche senza rendersene conto – ritenute come più adatte agli uomini che le donne. Questo fenomeno – che consiste nell’associare automaticamente gli uomini e caratteristiche maschili alla leadership e noto come think manager, think male - è stato identificato come una delle barriere per l’accesso delle donne alle posizioni di leadership nelle organizzazioni (ad es., Eagly & Karau, 2002; Heilman, 2012; Ryan, & al., 2011). Si può ipotizzare che giochi un ruolo anche nella scarsa presenza di donne nelle posizioni dirigenziali nel settore culturale (ad es., direttore di teatro) o di leadership (ad es., regia). Nella sua analisi dell’industria musicale in Italia, Micalizzi (2022; per l’industria culturale UK, Hesmondhalgh, & Baker, 2015) suggerisce che gli stereotipi siano responsabili di dinamiche sia di esclusione (le donne non sono adatte a questo lavoro!) sia di esclusività (questo è un lavoro da donne!). La comunicazione nel mondo della musica è un lavoro considerato adatto alle donne in quanto si può fare da casa e poi richiede “precisione e pazienza”, ovvero caratteristiche parte dello stereotipo delle donne (Paraciani, 2023). Il trucco o i costumi, anche essi lavori a forte prevalenza femminile, richiedono abilità tradizionalmente delle donne. Nel mondo della formazione queste due dinamiche – esclusione ed esclusività – possono agire allo stesso tempo, orientando uomini e donne verso professioni diverse. Come quando nelle scuole e compagnie di danza si indirizzano solo gli uomini verso la coreografia, invitando implicitamente le donne a perseguire nella danza. L’interazione tra stereotipi di genere e quelli relativi al ruolo professionale, come suggerito da Micalizzi (2022), definisce anche le condizioni per essere incluse in professionalità a prevalenza maschile. Come donne si è accettate nella misura in cui si assume una prospettiva maschile e ci si distanzia dal femminile (non sono come le altre donne!). Le interviste di Paraciani (2023) a donne lavoratrici nel mondo della musica offrono alcuni esempi di questo distanziamento, quando ad esempio la tour manager afferma di poter fare questo lavoro perché diretta e non facile da sconvolgere oppure la promoter sottolinea che non puoi avere una famiglia e devi “essere in grado di bere come un uomo”. In conclusione, le donne sono escluse da ruoli di leadership e direzionali perché professioni ritenute “agentiche” e “maschili”, recluse a ruoli che richiedono competenze tradizionalmente femminili, a meno che di non adattarsi e provare a dimostrare con il proprio comportamento di essere una “super donna” che altro non è che una donna che sa agire come un uomo (Paraciani, 2023; Cannizzo & Strong, 2020).
Talento come prerequisito del successo. Un ulteriore elemento che può contribuire alla disparità di genere è attribuire il successo e la riuscita professionale non solo al duro lavoro, ma anche al talento o alla genialità, in altri termini a qualche capacità non acquisibile con il solo impegno. Secondo Muradoglu e colleghi (2023), questa credenza pone un ulteriore ostacolo ai membri di gruppi sociali che si ritiene carenti di alcune capacità. Negli ambiti professionali dove il successo è visto il frutto di talento o genialità, si registra di fatto minor parità di genere e diversità etnica. La ricerca si è in particolare focalizzata sui dottorati negli USA, riscontrando una prevalenza maschile e la credenza diffusa che gli uomini siano più adatti per ambiti che si ritiene richiedano un quid speciale, come la filosofia, la matematica, e la composizione musicale (Leslie et al., 2015; Bian et al., 2018). A nostra conoscenza, non è stata ancora condotta un’indagine sistematica sulle implicazioni di questa concezione nel mondo della produzione culturale. Tuttavia non è difficile vederne le implicazioni. Sebbene l’assenza di prove univoche che attestino una maggiore creatività degli uomini rispetto alle donne (ad es., Hora et al, 2022; Taylor et al., 2023), il concetto di creatività risulta associato a tratti agentici e quindi stereotipicamente maschili (ad es., indipendenza; Proudfoot et al., 2015). Inoltre la genialità e il talento sono implicitamente associati più agli uomini che alle donne (Storage et al., 2020). Tutto ciò sarebbe già sufficiente a generare un pregiudizio che svantaggia le donne nelle professioni creative. Se a questo si aggiunge l’idea della creatività come talento da coltivare, piuttosto che come capacità che si può acquisire e migliorare nel tempo, il rischio è di rendere il successo e l’eccellenza nel settore creativo e culturale come qualcosa ancora più difficile da conquistare per le donne.
Ambiente ostile: Molestie sessuali e microaggressioni di genere. Il settore culturale e creativo, con poche eccezioni, è un mondo a prevalenza maschile. Come vedremo in questo paragrafo, in alcuni casi si rivela un mondo maschilista nella più ovvia delle sue accezioni: un contesto di lavoro dove le donne sono esposte a molestie sessuali oppure offese e umiliazioni (ad es., commenti sessisti, oggettivanti), piccole o grandi che siano, in quanto donne (cioè microaggressioni di genere). Il movimento #MeToo-che nel 2017 ha scosso Hollywood- ha svelato al grande pubblico qualcosa che forse agli addetti ai lavori era ben noto: molestie e abusi sessuali erano in molti casi la prassi e non un’eccezione. In Italia, nello stesso periodo, nasce #quellavoltache, iniziativa che invitava a condividere storie di molestie, mettendo così in evidenza la pervasività del problema. Pur non avendo assunto quei caratteri mediatici visti altrove, ad es. negli USA, anche in Italia il #MeToo produce una nuova consapevolezza, dando il via a una serie di iniziative volte, tra le altre cose, a conoscere l’ampiezza e le caratteristiche del fenomeno. Nel 2021 Amleta, associazione che ha come scopo contrastare la disparità e la violenza di genere nel mondo dello spettacolo, lancia la campagna “Apriamo le stanze di Barbablu” per raccogliere dati sul fenomeno delle molestie. In due anni, sono state raccolte 223 segnalazione, da parte prevalentemente di attrici o allieve attrici. Pur trattandosi di dati non rappresentativi, forniscono alcune indicazioni sul fenomeno. La maggior parte delle molestie sono state commesse nei luoghi di lavoro, da parte di uomini in posizione gerarchica (ad es., registi 41.26%). Il provino risulta il momento più critico. Il fenomeno non sembra confinato al mondo della recitazione: Molestie e microaggressioni sembrano caratterizzare anche l’industria musicale. È quanto emerge da una inchiesta di Equaly, una community che si occupa di parità di genere nel music business che offre un quadro del clima che si respira. Da una parte si osserva la messa in discussione delle competenze delle donne impegnate in professioni tecniche e tipicamente maschili (ad es., chiamare “la bambina” una ingegnera del suono con esperienza); dall’altra si dà per scontato che sia per meriti sessuali o di avvenenza che una donna sia entrata in quel mondo (Paraciani, 2023). È un modo per sminuire le competenze, ma sottolinea anche come la molestia e lo scambio sessuale siano considerati parte integrante del sistema. Questi dati evidenziano come il mondo del lavoro culturale e creativo possa risultare un ambiente ostile per le donne. Ci sono inoltre delle caratteristiche del lavoro nel settore culturale e creativo che potrebbero facilitare il perpetuarsi di una cultura della molestia, quali, ad esempio, il precariato e la forte competizione, il ruolo dei network informali nell’accesso e mantenimento del lavoro, la concentrazione di potere nelle mani di relativamente pochi uomini e la centralità del corpo in questo ambito lavorativo (Hennekam & Bennett, 2017). L’importanza del corpo è sottolineata anche da Amleta a conclusione dell’indagine nel mondo della recitazione quando parla della difficoltà nel “determinare il confine tra l’abuso e ciò che è lecito nell’ambito di un lavoro svolto con il corpo, tra creatività e improvvisazione” (Osservatorio parità di genere, 2022, p.30). Da qui un lavoro culturale che possa contribuire a farlo appare particolarmente urgente. Qual è l’impatto di questa ostilità ambientale? Da quanto emerso dal movimento #MeToo, si può ipotizzare che sia una delle ragioni per cui alcune abbandonino questa carriera. Vi sono sicuramente costi psicologici per la persona (ad es., Vargas et al., 2020). Più difficile è valutare l’impatto sulla creatività delle donne. Di certo non facilita l’accesso delle donne a posizioni dirigenziali: un ambiente dove le molestie e le microaggressioni sono diffuse e tollerate ne offre un’immagine svilita e oggettificata.
Cosa fare?
A livello internazionale e nazionale sono state proposte varie misure per favorire una maggiore presenza di donne in posizioni con funzioni di governance e decision-making, per aumentarle la visibilità delle donne artiste e per promuovere la parità di genere nella formazione (si veda, ad es. Conor, 2021; Osservatorio sulla parità di genere, 2022). Alcuni esempi nel contesto italiano sono da ritrovare, ad esempio, nel piano dell’eguaglianza di uguaglianza di genere del Ministero della cultura[2], nelle leggi che prevedono forme di premialità per opere con registe o autrici donne [3]; nell’istituzione di borse di studio in ambiti in cui le donne sono rappresentate, ad es. nella produzione musicale [4].
Queste misure richiedono investimenti economici e sono decisamente utili per superare l’inerzia e lo status-quo. Potrebbero però non bastare, se non accompagnate a un cambiamento culturale. Come in altri ambiti organizzativi, risulta cruciale sensibilizzare chi opera nel settore sugli ostacoli alla parità di genere e su quale potrebbe essere il loro contributo per eliminarli o, quanto meno, per attenuarne gli effetti. In questa logica è importante formare al riconoscimento di molestie sessuali e di altre espressioni di ostilità verso le donne come le microaggressioni di genere, e allo stesso fornire formazioni per diventare testimoni attivi o bystander, vista l’efficacia di tali figure nel contrasto alla violenza di genere (ad es. Coker et al., 2016). Per quanto riguarda gli stereotipi, la formazione potrebbe non limitarsi a informare sulla loro esistenza e implicazioni, per fornire strumenti concettuali per decostruirli e soprattutto per responsabilizzare chi opera nel settore al cambiamento. Come visto nel precedente paragrafo, il settore culturale e creativo subisce gli stereotipi di genere; allo stesso tempo, però, svolge un attivo nel perpetuarli. Dal monitoraggio della programmazione Rai del 2021, risulta, ad es., che donne (e uomini) sono rappresentate in ruoli stereotipici (Osservatorio parità di genere, 2022). Riconoscere di essere in una posizione privilegiata per promuovere narrative diversificate può essere un primo passo per chi opera nel settore per diventare agenti di cambiamento.
Tra le barriere è stata menzionata anche la concezione del talento. Si tratta di una questione complessa da affrontare. Nell’industria culturale e creativa talento e impegno sono ritenute chiave del successo (Taylor & O’Brien, 2017). Tuttavia, questa visione, sostenuta prevalentemente da chi è in posizione di potere, rischia di offuscare e perpetuare le diseguaglianze esistenti nel settore (Brook et al., 2021). Recenti linee guida per promuovere la diversità mettono in guardia dalla narrazione meritocratica soprattutto nei contesti di selezione ("stiamo solo premiando il talento!”) e invitano a riflettere sul concetto di talento per elaborare criteri più inclusivi (Comunian et al., 2023; Conor, 2021). Gli studi in psicologia sociale discussi precedentemente, ne ampliano la prospettiva, proponendo di considerare il talento come una qualità malleabile. È fondamentale attuare misure per contrastare la disparità di genere, valutandone allo stesso tempo l’efficacia per evitare cambiamenti superficiali che di fatto lasciano il sistema sostanzialmente inalterato (ad es. più donne in posizioni leadership, ma senza cambiamenti sul fronte molestie oppure della visibilità). Diventa quindi cruciale monitorare la partecipazione femminile in questo settore attraverso rilevazioni sistematiche su campioni rappresentativi, ma anche approfondire la ricerca psicosociale sui meccanismi che l’ostacolano. L’obiettivo è che il settore culturale e creativo possa finalmente beneficiare di un ampio contributo delle donne.
Glossario
Agenticità e comunalità. I termini agenticità (agency) e comunalità (communion) vengono in genere utilizzati per indicare due dimensioni fondanti la percezione sociale (Abele, & Wojciszke, 2019). Nello specifico tratti, interessi o motivazioni che denotano un orientamento alla relazione vengono ricondotti alla comunalità, quelli che indicano un orientamento all’agenticità.
Disparità di genere. Questo termine viene solitamente utilizzato in senso binario per indicare quando un genere è sotto rappresentato e/o svantaggiato (ad es. nell’accesso) in contesti e ambiti quali quelli della vita pubblica, sociale, economica, politica, o della vita privata e quotidiana.
Microaggressioni di genere. Il termine microaggressioni è stato introdotto da Sue (2010) per indicare le offese quotidiane siano esse verbali, non verbali o ambientali, intenzionali o non intenzionali, che comunicano messaggi ostili, denigratori o negativi alla persona in quanto membro di un gruppo.
Molestie sessuali. Secondo Fitzgerald (1993) le molestie sessuali includono comportamenti di coercizione sessuale (dallo stupro al tentato stupro, ricatto sessuale), attenzioni sessuali non gradite di tipo fisico e verbale, e altre forme di ostilità ambientale come, ad es., commenti sessisti, e oggettivanti.
#MeToo. Movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne. Diffuso in modo virale come hashtag sui social media, soprattutto a partire dal 2017 quando ha ottenuto una notevole popolarità dopo essere stato utilizzato da alcune attrici per denunciare i casi di violenza e molestia sessuale a Hollywood.
Parità di genere. Dall’European Institute of Gender Equality viene definita come un concetto numerico e sostanziale relativo all'equità di genere, spesso calcolato come rapporto di valori donne/uomini per un dato indicatore (ad es. presenza).
Stereotipi, stereotipi di genere e sulle professioni. Con stereotipi si intendono le credenze sugli attributi (ad es. tratti, comportamenti, aspirazioni) che caratterizzano i membri di un gruppo. Quando si parla di genere e professioni, gli stereotipi assumono un carattere anche prescrittivo, oltre che descrittivo; in altri termini più che descrivere come sono (descrizione), ci dicono come dovrebbero o non dovrebbero le persone a seconda del loro genere o del ruolo professionale che ricoprono (prescrizione).
Bigliografia
Abele, A. E., & Wojciszke, B. (Eds.). (2019). Agency and communion in social psychology. Taylor & Francis Group: Routledge
Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2018). Evidence of bias against girls and women in contexts that emphasize intellectual ability. American Psychologist, 73, 1139-1153
Brook, O., O’Brien, D., & Taylor, M. (2021). Inequality talk: How discourses by senior men reinforce exclusions from creative occupations. European Journal of Cultural Studies, 24, 498-513
Cannizzo, F., & Strong, C. (2020). ‘Put some balls on that woman’: Gendered repertoires of inequality in screen composers’ careers. Gender, Work & Organization, 27, 1346-1360
Coker, A. L., Bush, H. M., Fisher, B. S., Swan, S. C., Williams, C. M., Clear, E. R., & DeGue, S. (2016). Multi-college bystander intervention evaluation for violence prevention. American journal of preventive medicine, 50, 295-302
R. Comunian, T. Dent, D. O’Brien, T. Read, and N. Wreyford (2023). Making the Creative Majority: A report for the All-Party Parliamentary Group for Creative Diversity on ‘What Works’ to support diversity and inclusion in creative education and the talent pipeline, with a focus on the 16+ age category. www.kcl.ac.uk/cultural/projects/creative-majority-education
Conor, B. (2021). Gender & creativity: Progress on the precipice. UNESCO Publishing
Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. Psychological Review, 109, 573-598
Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. Annual Review of Psychology, 69, 275-298
Fitzgerald L. F. (1993). Sexual harassment. Violence against women in the workplace. The American Psychologist, 48, 1070-1076
Heilman, M. E. (2012). Gender stereotypes and workplace bias. Research in organizational Behavior, 32, 113-135
Hennekam, S., & Bennett, D. (2017). Sexual harassment in the creative industries: Tolerance, culture and the need for change. Gender, Work & Organization, 24, 417-434
Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2015). Sex, gender and work segregation in the cultural industries. The Sociological Review, 63, 23-36
Hora, S., Badura, K. L., Lemoine, G. J., & Grijalva, E. (2022). A meta-analytic examination of the gender difference in creative performance. The Journal of applied psychology, 107, 1926–1950
Leslie, S. J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines. Science, 347(6219), 262-265.
Micalizzi, A. (2022). L'industria musicale italiana e il gender gap: uno studio qualitativo sulla differenza di genere. Sociologia della Comunicazione, 63, 133-151
Muradoglu, M., Arnold, S. H., Leslie, S.-J., & Cimpian, A. (2023). “What Does It Take to Succeed Here?”: The Belief That Success Requires Brilliance Is an Obstacle to Diversity. Current Directions in Psychological Science, 32, 379-386
Osservatorio per la parità di genere (2022). La questione di genere tra immaginario e realtà. Primo rapporto annuale dell’Osservatorio per la parità di genere del Ministero della Cultura. https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70a...
Paraciani, R. (2023). No Country for Women. Women Working in the Italian Music Industry. Italian Sociological Review, 13, 243-262
Proudfoot, D., Kay, A. C., & Koval, C. Z. (2015). A gender bias in the attribution of creativity: Archival and experimental evidence for the perceived association between masculinity and creative thinking. Psychological science, 26, 1751-1761
Ryan, M. K., Haslam, S. A., Hersby, M. D., & Bongiorno, R. (2011). Think crisis–think female: The glass cliff and contextual variation in the think manager–think male stereotype. Journal of Applied Psychology, 96, 470-484
Schein, V. E. (1973). The relationship between sex role stereotypes and requisite management characteristics. Journal of Applied Psychology, 57, 95-100
Storage, D., Charlesworth, T. E., Banaji, M. R., & Cimpian, A. (2020). Adults and children implicitly associate brilliance with men more than women. Journal of Experimental Social Psychology, 90, 104020
Sue, D. W. (2010). Microaggressions in everyday life: Race, gender, and sexual orientation. John Wiley & Sons
Taylor, M., & O’Brien, D. (2017). ‘Culture is a Meritocracy’: Why Creative Workers’ Attitudes may Reinforce Social Inequality. Sociological Research Online, 22, 27-47
Taylor, C. L., Said-Metwaly, S., Camarda, A., & Barbot, B. (2023). Gender differences and variability in creative ability: A systematic review and meta-analysis of the greater male variability hypothesis in creativity. Journal of Personality and Social Psychology, Advance online publication
Vargas, E. A., Brassel, S. T., Cortina, L. M., Settles, I. H., Johnson, T. R., & Jagsi, R. (2020). # MedToo: a large-scale examination of the incidence and impact of sexual harassment of physicians and other faculty at an academic medical center. Journal of Women's Health, 29, 13-20
[1] Se non diversamente specificato i dati fanno riferimento al rapporto dell’osservatorio parità di genere e altra documentazione disponibile al sito https://www.beniculturali.it/osservatorio-per-la-parita-di-genere. Per una panoramica del fenomeno a livello di EU, si veda European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, (2022).Gender gaps in the cultural and creative sectors, Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2766/322133
[2]https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/388a5474724a15af0ace7a...
[3] https://cinema.cultura.gov.it/per-gli-utenti/approfondimenti-tematici/fo...
[4] https://www.sae.edu/ita/womeninmusic/