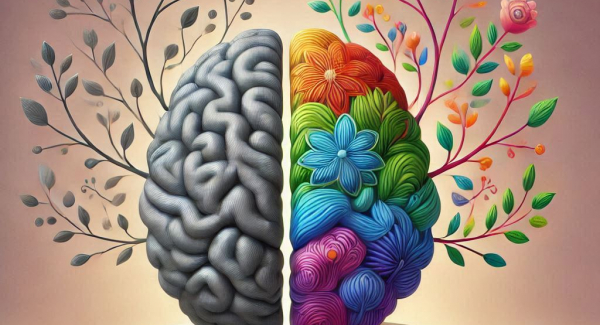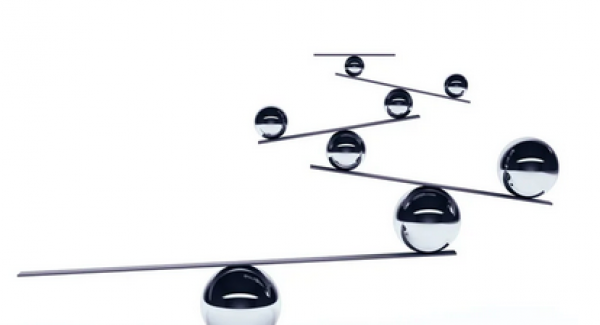Che lavoro fai? Faccio ricerca, all’università. Wow!
Alcuni lavori, soprattutto quelli autonomi, creativi e intellettuali, sono percepiti come lavori di alto status, ma questo prestigio sociale ha un costo in termini di tempo, con un impatto significativo sul benessere (Nicholls et al., 2022). In questo articolo portiamo come esempio l’accademia, mettendo in luce le sfide da affrontare per perseguire un buon equilibrio vita-lavoro e suggeriamo 10 possibili strategie basate su ricerche recenti. L’equilibrio vita-lavoro si realizza quando le persone percepiscono la propria capacità di gestire in modo armonico il lavoro e la vita personale, garantendo soddisfazione in entrambi gli aspetti, mantenendo la propria salute e benessere (Casper et al., 2018). Può forse sorprendere che l’equilibrio tra vita privata e lavoro sia un tema problematico per ambienti di lavoro caratterizzati da grande flessibilità, in cui la performance è valutata sul lungo termine e non sui compiti quotidiani e dove le persone lavorano in modo autonomo e con grande passione. Ma proprio queste stesse caratteristiche rappresentano dei fattori di rischio. Infatti, la ricerca ci mostra che la passione sul lavoro (in termini tecnici, engagement) è associata ad una incapacità di dire di no, di limitare le proprie azioni lavorative ai compiti strettamente legati al ruolo centrale, promuovendo invece attività extra-ruolo e orari di lavoro prolungati. Insomma, se ami molto il tuo lavoro, e lo puoi fare dove e quando vuoi, il rischio di lavorare troppo (se non sempre) è davvero alto! Innanzitutto, lavorare in questo tipo di ambiti richiede eccellenza. Questo termine, tanto generale quanto spesso vuoto, diventa in molti casi un modo per giustificare politiche governative neoliberiste, che spingono verso il perfezionismo e la corsa al riconoscimento (Rosa, 2022). In accademia, ad esempio, gli standard per l'eccellenza fungono da metro di valutazione del proprio progresso nelle varie fasi della carriera. Tuttavia, queste smanie di perfezione e successo spesso portano a lavorare molte ore, alla sera e durante i fine settimana. A questo elemento si aggiungono l’eterogeneità e molteplicità dei compiti, quali la pubblicazione in riviste prestigiose, le partecipazioni a convegni, la produzione di progetti di ricerca di alto livello, l’insegnamento, la costruzione di collaborazioni internazionali, la ricerca di finanziamenti e la divulgazione scientifica al pubblico. Senza contare i compiti istituzionali, fatti per lo più di burocrazia. Le persone nel contesto accademico sacrificano il loro tempo libero, spesso in isolamento, anche per compiti che potrebbero non avere un impatto significativo o che non percepiscono come tali (Nicholls et al., 2022). Questo viene ulteriormente enfatizzato dal fatto che è sempre più presente la credenza che il consumo di tempo (in alternativa agli introiti economici) sia diventato un indicatore di status (Bellezza et al., 2017). Come descrive il filosofo Pascal Chabot (2013, p. 59) “La parola d’ordine, ormai, è quella di adattarsi ai calendari, ai ritardi, agli orari, alle riunioni. L’ora è ovunque, il tempo non è da nessuna parte […]. Il tempo come soglia di morte, il minuto fatale ed angosciante, la scadenza oltre la quale ci trasformiamo in perdenti”. Ma venendo al dunque, quali sono le ripercussioni di questo modo di lavorare? Confrontando la qualità della vita lavorativa di persone che lavorano in accademia e non, Fontinha e colleghi (2019) hanno riscontrato una minor qualità nella popolazione accademica, aggravata dal maggior numero di ore extra lavorative, potenzialmente a causa della natura ipercompetitiva dell'accademia. Questa cultura è particolarmente dannosa per i/le giovani ricercatori/ricercatrici che, vincolati da contratti a breve termine, sono costretti/e ad abbracciare orari di lavoro insostenibili per la paura della stagnazione professionale. I/le dottorandi/e sono sei volte più inclini a sviluppare ansia e depressione rispetto alla popolazione generale (Evans e al. 2018, vedi anche Satinsky et al. 2021) e questa pressione può diventare così insostenibile da portarli al burnout (Woolston, 2020). Uno studio condotto da Cannizzo e colleghi (2019) ha dimostrato che il mancato beneficio delle politiche formali di equilibrio vita-lavoro da parte dei/delle giovani ricercatori/ricercatrici è parzialmente spiegata dalle culture organizzative centrate sul lavoro che promuovono l’idea che riposarsi sia immorale. Quante volte rispondiamo "sono stanco/a" quando ci chiedono come stiamo? Quante volte siamo tornati/e dalle ferie solo per raccontare come abbiamo continuato a lavorare? Le narrazioni scambiate nei corridoi contribuiscono a comportamenti dannosi che erodono l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Confronto sociale e competizione, elementi che sono favoriti in particolari contesti lavorativi, come quello accademico, si sono dimostrati promotori del sacrificio di aspetti importanti della propria vita, spingendo lavoratrici e lavoratori a dedicare più tempo ed energia al lavoro, nella ricerca continua di uno status sociale più elevato (Filippi et al., 2023a). Per quanto riguarda le differenze individuali nell'equilibrio tra lavoro e vita nell'accademia, la ricerca suggerisce che certi tratti di personalità svolgono un ruolo cruciale. Secondo il modello dei Big Five (un modello teorico che raggruppa i tratti di personalità in cinque grandi gruppi: estroversione, coscienziosità, gradevolezza, apertura all’esperienza e stabilità emotiva), i tratti di gradevolezza, coscienziosità e apertura all'esperienza sono associate a un maggiore equilibrio tra lavoro e vita (Akanni & Oduaran, 2017). Anche il genere gioca un ruolo cruciale in questo contesto, anche se i risultati sono ambigui. Alcuni studi evidenziano come le donne vivano un maggior conflitto tra lavoro e vita a causa dell’aspettativa legata ai ruoli di genere tradizionali, che le vede come coloro che si devono occupare dei compiti di cura (Magadley, 2021; Rafnsdóttir e Heijstra, 2013). Per donne la flessibilità lavorativa è una sfida, mentre per gli uomini è un’opportunità (Carreri, 2020). Questa asimmetria è diventata molto evidente durante la recente pandemia da COVID-19, quando il lavoro da remoto ha ulteriormente sfumato i confini tra lavoro e vita privata, con un conseguente calo della produttività delle donne, mentre quella degli uomini è aumentata (Myers et al., 2020). La ricerca di equilibrio tra lavoro e vita nell'accademia concorre dunque ad esasperare l'ineguaglianza di genere già insita nell'accademia, tradizionalmente vista come un dominio maschile (Rosa, 2022). Sia che gli ostacoli siano esterni, come l'ipercompetitività per i finanziamenti per la ricerca e la precarietà, o interni, come cercare la perfezione o credere di dover fare di più, il risultato rimane lo stesso: spingersi al limite ha un impatto negativo sul benessere (Martin & Stanfill, 2023). Quindi, cosa si può fare per migliorare l’equilibrio vita-lavoro in questi ambiti? Ecco dieci suggerimenti per armonizzare lavoro accademico e vita privata (ma che possono essere utili per molti altri lavori dalle caratteristiche simili), tratti dalle ricerche recenti su questo argomento (vedi ad esempio Townsend, 2020 o Erren et al., 2021 per 10 raccomandazioni di 10 Premi Nobel):
In conclusione, raggiungere l'equilibrio tra lavoro e vita in ambienti flessibili, creativi e intellettuali, come accademia, è una sfida complessa che richiede sforzi individuali e un cambiamento culturale all'interno delle organizzazioni. L'adozione di queste strategie può migliorare la qualità della vita delle persone. "Lavorare meno per lavorare meglio" potrebbe essere il motto per raggiungere un equilibrio più sano tra lavoro e vita e promuovere ambienti lavorativi più sostenibili.
Bibliografia
Akanni, A. A., & Oduaran, C. A. (2017). Work-life balance among academics: do gender and personality traits really matter?. Gender and Behaviour, 15(4), 10143-10154. https://hdl.handle.net/10520/EJC-c1e853b3f
Balconi, M., Crivelli, D., & Vanutelli, M. E. (2017). Why to cooperate is better than to compete: brain and personality components. BMC neuroscience, 18, 1-15. https://doi.org/10.1186/s12868-017-0386-8
Beigi, M., Shirmohammadi, M., & Stewart, J. (2018). Flexible work arrangements and work–family conflict: A metasynthesis of qualitative studies among academics. Human Resource Development Review, 17(3), 314-336. https://doi.org/10.1177/1534484318787628
Bellezza, Paharia, & Keinan (2017). Conspicuous Consumption of Time: When Busyness and Lack of Leisure Time Become a Status Symbol. Journal of Consumer Research. DOI: https://doi.org/.1093/jcr/ucw076.
Cannizzo, F., Mauri, C., & Osbaldiston, N. (2019). Moral barriers between work/life balance policy and practice in academia. Journal of Cultural Economy, 12(4), 251-264. https://doi.org/10.1080/17530350.2019.1605400
Casper, W. J., Vaziri, H., Wayne, J. H., DeHauw, S., & Greenhaus, J. (2018). The jingle-jangle of work–nonwork balance: A comprehensive and meta-analytic review of its meaning and measurement. Journal of Applied Psychology, 103(2), 182–214. https://doi.org/10.1037/apl0000259
Chabot, P. (2013). Global Burnout. Presses Universitaires de France.
Chung, H. (2022). A Social Policy case for a four-day week. Journal of Social Policy, 51(3), 551-566. 10.1017/S0047279422000186
Cropanzano, R., & Wright, T. A. (2001). When a" happy" worker is really a" productive" worker: A review and further refinement of the happy-productive worker thesis. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 53(3), 182. https://doi.org/10.1037/1061-4087.53.3.182
Erren, T. C., Mohren, J., & Shaw, D. M. (2021). Towards a good work-life balance: 10 recommendations from 10 Nobel Laureates (1996-2013). Neuroendocrinology Letters, 42(3), 135-140.
Evans, T., Bira, L., Gastelum, J. et al. Evidence for a mental health crisis in graduate education. Nat Biotechnol 36, 282–284 (2018). https://doi.org/10.1038/nbt.4089
Filippi, S., Peters, K., & Suitner, C. (2023b). Power to the people: A social identity perspective on organizational decentralization and employee well‐being. Journal of Community & Applied Social Psychology. https://doi.org/10.1002/casp.2725
Filippi, S., Salvador Casara, B. G., Pirrone, D., Yerkes, M., & Suitner, C. (2023a). Economic inequality increases the number of hours worked and decreases work–life balance perceptions: longitudinal and experimental evidence. Royal Society Open Science, 10(10), 230187. https://doi.org/10.1098/rsos.230187
Fontinha, R., Easton, S., & Van Laar, D. (2019). Overtime and quality of working life in academics and nonacademics: The role of perceived work-life balance. International Journal of Stress Management, 26(2), 173–183. https://doi.org/10.1037/str0000067
Kets de Vries, M. F. (2014). Doing nothing and nothing to do: The hidden value of empty time and boredom.
Kinman, G., & Johnson, S. (2019). Special section on well-being in academic employees. International Journal of Stress Management, 26(2), 159. https://doi.org/10.1037/str0000131
Kinman, G., & Jones, F. (2008). A life beyond work? Job demands, work-life balance, and wellbeing in UK academics. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 17(1-2), 41-60. https://doi.org/10.1080/10911350802165478
Magadley, W. (2021). Moonlighting in academia: a study of gender differences in work-family conflict among academics. Community, Work & Family, 24(3), 237-256. https://doi.org/10.1080/13668803.2019.1678458
Martin, M. Y., & Stanfill, A. G. (2023). On the road to achieving work–life balance in academia. Clinical and Translational Science, 16(4), 553-556. https://doi.org/10.1111/cts.13485
Myers, K.R., Tham, W.Y., Yin, Y. et al. Unequal effects of the COVID-19 pandemic on scientists. Nat Hum Behav 4, 880–883 (2020). https://doi.org/10.1038/s41562-020-0921-y
Nicholls, H., Nicholls, M., Tekin, S., Lamb, D., & Billings, J. (2022). The impact of working in academia on researchers’ mental health and well-being: A systematic review and qualitative meta-synthesis. PloS one, 17(5), e0268890. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268890
Park, S., Kook, H., Seok, H., Lee, J. H., Lim, D., Cho, D. H., & Oh, S. K. (2020). The negative impact of long working hours on mental health in young Korean workers. PloS one, 15(8), e0236931. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236931
Rafnsdóttir, G. L., & Heijstra, T. M. (2013). Balancing work–family life in academia: The power of time. Gender, Work & Organization, 20(3), 283-296. https://doi.org/10.1111/j.1468-0432.2011.00571.x
Rosa, R. (2022). The trouble with ‘work–life balance’in neoliberal academia: A systematic and critical review. Journal of Gender Studies, 31(1), 55-73. https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1933926
Sallee, M. W., & Lewis, D. V. (2022). Hyper-separation as a tool for work/life balance: Commuting in academia. In Work-Life Balance in Higher Education (pp. 89-110). Routledge.
Satinsky, E. N., Kimura, T., Kiang, M. V., Abebe, R., Cunningham, S., Lee, H., ... & Tsai, A. C. (2021). Systematic review and meta-analysis of depression, anxiety, and suicidal ideation among Ph. D. students. Scientific Reports, 11(1), 14370.
Sverdlik, A., Hall, N. C., McAlpine, L., & Hubbard, K. (2018). The PhD experience: A review of the factors influencing doctoral students’ completion, achievement, and well-being. International Journal of Doctoral Studies, 13, 361-388. https://doi.org/10.28945/4113
The mental health of PhD researchers demands urgent attention. Nature, 575(7782), 257-258.
Townsend, S. D. (2020). Strategies and tactics for achieving work–life integration as a junior faculty member. Chemistry–A European Journal, 26(17), 3658-3660. https://doi.org/10.1002/chem.202000967
Wood, J., Oh, J., Park, J., & Kim, W. (2020). The relationship between work engagement and work–life balance in organizations: A review of the empirical research. Human Resource Development Review, 19(3), 240-262. https://doi.org/10.1177/1534484320917560
Woolston, C. (2020). Postdoc survey reveals disenchantment with working life. Nature, 587(7834), 505-509