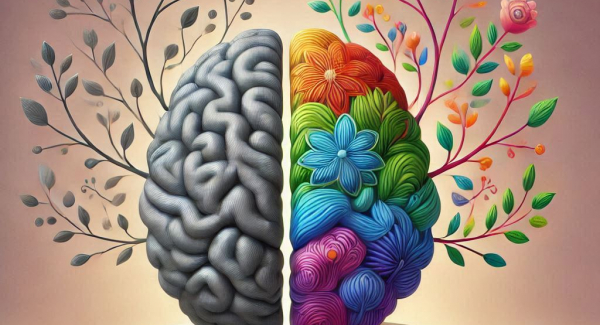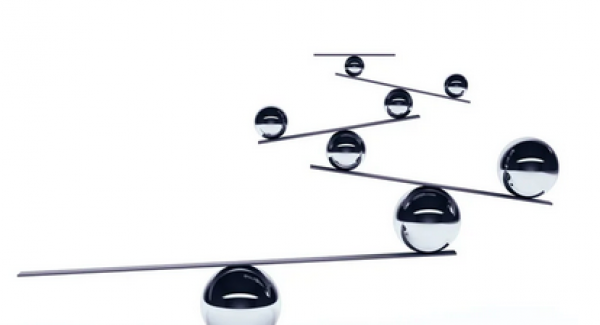Viviamo in un'era in cui il confine tra il mondo fisico e quello digitale si fa sempre più sfumato. Ogni giorno milioni di persone si connettono, comunicano, studiano e lavorano in uno spazio che non ha muri né confini geografici: il mondo digitale. Questo nuovo panorama sociale e culturale ha riscritto le regole delle interazioni umane, portando con sé grandi opportunità ma anche numerose sfide, soprattutto per i più giovani. Tra queste, l'uso costante di strumenti digitali eleva il rischio di comportamenti dannosi per il benessere psicologico. Il cyberbullismo, ad esempio, è direttamente correlato a gravi conseguenze come sintomi di ansia e depressione (Hemphill et al., 2015), incremento dei casi di abbandono scolastico (Coelho et al., 2022) e aumentati rischi di tentativi di suicidio (Geoffroy et al., 2016), rappresentando una vera e propria emergenza sociale soprattutto nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni (Rapporto di Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022). Negli ultimi due decenni, il concetto di cyberbullismo ha acquisito un'importanza sempre crescente, a partire dalle prime ricerche del 2000 che hanno posto le fondamenta per il suo studio. La prima definizione del fenomeno descrive il cyberbullismo come «un atto aggressivo, intenzionale, realizzato da un gruppo o da un individuo attraverso forme di comunicazione elettronica, perpetrato ripetutamente nel tempo contro una vittima che non può difendersi facilmente» (Smith et al., 2008, p. 376, traduzione personale). Questa definizione evidenzia le caratteristiche fondamentali del bullismo tradizionale, quali la ripetizione nel tempo, lo squilibrio di potere e l'intenzionalità, accanto all'uso delle nuove tecnologie come strumenti per la perpetrazione di tali aggressioni. Da quel momento, il fenomeno ha attratto un'attenzione crescente a livello globale, dando vita a un dibattito sempre più vivace, come dimostrano le 24 definizioni successive proposte (si veda la rassegna di Peter e Petermann, 2018). Numerosi autori, infatti, si sono interrogati (e ancora si interrogano) sulla continuità e discontinuità tra i due fenomeni (Scheithauer et al., 2021; si veda anche Guarini e Brighi, 2022). Da una parte molte ricerche sottolineano come il cyberbullismo rappresenti una variante del bullismo tradizionale adattata all'ambiente online (Berne et al., 2019; Campbell e Bauman, 2018). Altri autori, invece, ritengono che il fenomeno debba essere, almeno parzialmente, considerato come distinto dal bullismo tradizionale a causa della difficoltà nell'applicare gli elementi chiave del bullismo (ripetizione, squilibrio di potere ed intenzionalità) all’ambiente digitale (Corcoran et al., 2015; Kofoed e Staksrud, 2019) e alle sue caratteristiche peculiari. La prima caratteristica “unica” è infatti la mancanza di confini spazio-temporali (Tokunaga, 2010) per cui la vittima può essere bersagliata in qualsiasi momento, rendendola costantemente esposta agli attacchi. Un secondo punto importante è la possibilità del cyberbullo di celare la propria identità, facilitando così aggressioni anonime verso la vittima (Barlett et al., 2016). Un altro fattore cruciale è la mancanza di feedback visivi immediati che tendono ad aumentare il disimpegno morale, facilitando un distacco emotivo maggiore da parte dell'aggressore (Ansary, 2020). Inoltre, il settore delle tecnologie è in continua evoluzione, il che genera nuovi modi di interagire. Questo rapido sviluppo si riflette anche nei cambiamenti delle modalità di manifestazione del cyberbullismo, complicando l'applicazione di criteri operativi che, fino a pochi anni fa, potevano essere adeguati (Menin et al., 2021). In conclusione, il cyberbullismo si manifesta attraverso atti di aggressione compiuti tramite strumenti digitali come app di messaggistica, social network, chat room, forum e giochi online. Gli esempi di questo fenomeno sono molteplici e variabili: un ragazzo può inviare insulti e minacce via messaggio privato a un compagno, mentre in altri casi si può assistere alla modifica e alla diffusione di foto online a danno di un'altra persona. Un'altra forma comune di cyberbullismo è la creazione di profili falsi per impersonare un compagno o una compagna, utilizzando contenuti imbarazzanti per umiliarlo/a. Ancora, l'esclusione deliberata di un compagno dai gruppi online durante i giochi è un altro tipico comportamento di cyberbullismo. Questi pochi esempi mostrano chiaramente le diverse sfaccettature attraverso cui il cyberbullismo si manifesta, amplificati dalle tecnologie digitali. Quindi, sebbene presenti analogie con il bullismo tradizionale, è fondamentale utilizzare "nuove lenti" per comprendere, prevenire e contrastare efficacemente questa forma di aggressione.
Gli Aspetti Sociali
Il cyberbullismo, al pari del bullismo tradizionale, è un fenomeno complesso che si radica nei contesti sociali in cui si manifesta, richiedendo, per essere pienamente compreso, un'analisi del contesto più ampio (Baldry et al., 2019). Tradizionalmente nel bullismo sono stati identificati ruoli diversi all'interno del gruppo, come quelli degli assistenti e dei rinforzi — questi ultimi supportano o incoraggiano i bulli, spesso fondendosi nel ruolo unico del "pro-bullo" (Gini et al., 2021) , i difensori, che aiutano le vittime, e gli spettatori passivi che osservano gli eventi senza intervenire (Salmivalli et al., 1996). Questi ruoli, sebbene originari del bullismo tradizionale, sono stati osservati anche nel cyberbullismo (Menesini e Nocentini, 2009). Tuttavia, nel cyberbullismo, non solo i coetanei ma anche adulti o individui non direttamente collegati alla vittima o all'aggressore possono partecipare, estendendo il contesto sociale del fenomeno. Un "pro-bullo" nel cyberbullismo può, ad esempio, diffondere contenuti dannosi, esprimere approvazione tramite "mi piace" o inoltrare messaggi offensivi, contribuendo così a rinforzare e amplificare la portata dell'aggressione a un pubblico molto più ampio. Al contrario, i difensori possono agire segnalando l'incidente agli adulti o confortando la vittima direttamente (Pozzoli e Gini, 2020). La presenza di spettatori passivi può inibire le azioni difensive, poiché tendono a conformarsi alle reazioni della maggioranza, interpretando l'inattività come un'accettazione tacita dell'atto aggressivo, il che può portare ad imbarazzo sociale per chi decide di intervenire (Bastiaensens et al., 2015). Dato che la maggioranza degli spettatori di episodi di cyberbullismo è "silenziosa" (il 75% secondo Antoniadou, Kokkinos e Fanti, 2019), è fondamentale sensibilizzarli a diventare non più passivi ma attivi nel difendere la vittima; questo cambio di atteggiamento può trasformarli in agenti di cambiamento, riconoscendo il cyberbullismo come un fenomeno sociale e di gruppo, e spingendoli a promuovere una responsabilità collettiva per modificare le norme morali che permettono tali comportamenti aggressivi, sia online che a scuola (Machackova, 2020).
Fattori di Rischio e di Protezione
Quando si parla di fattori di rischio e di protezione é importante essere consapevoli che questi operano su più livelli: individuali, familiari, scolastici e comunitari (Baldry et al., 2015). Questi diversi strati interagiscono costantemente, influenzando la possibilità degli individui a diventare vittime o aggressori, nonché la loro capacità di rispondere efficacemente a tali minacce. Tra i fattori di rischio significativi nel coinvolgimento nel cyberbullismo, un aspetto particolarmente rilevante è l'essere già coinvolti in episodi di bullismo tradizionale (Campbell e Bauman, 2018; Olweus e Limber, 2018). A livello individuale un'altra dimensione di rischio riguarda le competenze sociali e emotive delle persone. I bambini e gli adolescenti che faticano a stabilire relazioni positive con i coetanei o che mostrano bassa empatia e scarsa autoregolazione emotiva sono spesso più vulnerabili al coinvolgimento nel cyberbullismo, sia nel ruolo di vittima, dovuto alla difficoltà nel cercare supporto e fronteggiare in maniera adattiva la situazione (Pouwels e Garandeau, 2021), sia in quello di aggressore, a causa della difficoltà nell’ empatizzare emotivamente con le vittime (Zych et al., 2019). Un terzo importantissimo fattore di rischio è l'uso frequente dei social media e di internet. I giovani che trascorrono molto tempo online possono essere più esposti a comportamenti negativi e avere maggiori opportunità di diventare sia vittime sia aggressori (Craig et al., 2020) soprattutto in mancanza di supervisione da parte degli adulti (Baldry et al., 2019). Infatti, senza una guida adeguata i ragazzi possono non riconoscere i segnali di pericolo o possono sentirsi più liberi di agire in modo inappropriato (Chen et al., 2018). Allo stesso modo un ambiente familiare conflittuale o disattento può non solo non fornire il supporto necessario per prevenire il coinvolgimento nel cyberbullismo, ma può anche involontariamente incoraggiarlo attraverso modelli di comportamento negativo (Chen et al., 2018). La scuola, come la famiglia, svolge un ruolo cruciale nel contesto del cyberbullismo. Le ricerche indicano che gli istituti scolastici privi di un ambiente positivo e di politiche efficaci contro il bullismo e il cyberbullismo tendono a osservare tassi più elevati di questi comportamenti nocivi (O’Brien, 2021). Nel nostro recente studio (Menabò et al., 2023), abbiamo analizzato come il cyberbullismo può danneggiare significativamente le relazioni degli studenti con i loro coetanei e con gli insegnanti, oltre a compromettere il loro senso di appartenenza alla scuola e il benessere generale. Abbiamo scoperto che il cyberbullismo riduce la percezione di supporto da parte degli insegnanti, porta le vittime a percepirsi isolate dai loro compagni e diminuisce il loro senso di connessione con l'ambiente scolastico, portando a conseguenze negative sul loro benessere. Questi risultati suggeriscono che le scuole non possono limitarsi a contrastare il bullismo con misure punitive, ma devono lavorare proattivamente per costruire un ambiente inclusivo, dove il sostegno emotivo e sociale degli insegnanti e dei pari sia rafforzato. I nostri dati, inoltre, sottolineano l’importanza di implementare interventi mirati a potenziare le reti sociali tra gli studenti, come programmi di peer support o tutoraggio, per mitigare gli effetti negativi del cyberbullismo. Investire in queste relazioni significa migliorare non solo il benessere delle vittime, ma anche la capacità complessiva della scuola di rispondere efficacemente ai fenomeni di cyberbullismo.
Per quanto riguarda i fattori di protezione, questi possono mitigare il rischio di coinvolgimento nel cyberbullismo. Tra i fattori individuali rientra, ad esempio, un buon livello di competenze sociali ed emotive (Schultze-Krumbholz et al., 2018) che permettono di conoscere e prendere consapevolezza delle proprie emozioni e di quelle altrui, di prendere decisioni consapevoli e mantenere legami interpersonali desiderabili. Un forte supporto sociale, sia all'interno della famiglia che tra i pari, è cruciale. I giovani che sentono di avere amicizie solide e sincere sono meno inclini a diventare vittime e più capaci di resistere alla pressione di partecipare a comportamenti di cyberbullismo (Foody et al., 2019). Inoltre, l'educazione e la consapevolezza riguardo al cyberbullismo possono fungere da fattore di protezione, insegnando ai giovani le conseguenze del loro comportamento e fornendo loro strategie per gestire situazioni potenzialmente nocive. Sono importanti anche la formazione di competenze digitali e la promozione di una cittadinanza digitale responsabile: insegnare ai giovani come comportarsi eticamente online e come proteggere sè stessi e gli altri da comportamenti dannosi può ridurre significativamente i rischi associati al cyberbullismo (Hutson et al., 2019).
Diffusione e Normativa Europea e Italiana
Il cyberbullismo rappresenta un fenomeno molto diffuso che coinvolge un elevato numero di studenti a livello internazionale e nazionale. Secondo l'UNICEF (2019), un terzo degli studenti ha subito cyberbullismo, con variazioni significative tra i diversi paesi a causa di diverse definizioni e metodi di rilevazione (Fondo internazionale di emergenza per l’infanzia delle Nazioni Unite - UNICEF, 2019) con studi recenti che indicano una prevalenza tra il 6% e il 46% per gli aggressori e tra il 14% e il 57% per le vittime (Zhu et al., 2021). In Italia si rileva che la percentuale di adolescenti vittime di cyberbullismo diminuisce con l’età, con percentuali più elevate nella scuola secondaria di primo grado (17% tra i maschi e 21% tra le femmine) rispetto alla scuola secondaria di secondo grado (9% per i maschi e 11% per le femmine; Rapporto di Sorveglianza Health Behaviour in School-aged Children - HBSC Italia 2022). Percentuali simili emergono in altri studi condotti con adolescenti nelle scuole italiane (Sorrentino et al., 2019). Di fronte a questo panorama preoccupante, dove la pervasività del cyberbullismo continua a rappresentare una realtà significativa, si rende necessaria una risposta normativa incisiva e coordinata. Attualmente, nonostante l'Unione Europea non disponga di leggi specifiche per combattere il bullismo e il cyberbullismo, questi fenomeni sono saldamente inseriti nelle politiche europee per i diritti umani, in particolare quelli dei minori. Tali politiche aderiscono alle normative della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della “Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea”, che in 54 articoli sancisce i diritti umani essenziali. Nel marzo 2021 è stata introdotta la "Strategia europea dei diritti delle persone di minore età" (2021-2024), in parallelo alla "Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dei minori" (2022-2027), entrambe finalizzate a combattere tutte le forme di violenza contro i minori, sia online che offline. La Commissione Europea ha anche recentemente rinnovato la "Strategia Europea per un Internet migliore per i ragazzi" nel maggio 2022, per rafforzare l'alfabetizzazione mediatica e la consapevolezza sui rischi di Internet e social media tra i minori. In Italia, la lotta contro il bullismo e il cyberbullismo ha assunto un carattere sistematico e strutturato, soprattutto a partire dal 2015, con l'adozione delle "Linee di Orientamento per Azioni di Prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo". Questo documento ha segnato un punto di svolta nell'approccio nazionale verso questi fenomeni, ponendo le basi per un intervento coordinato e mirato nelle istituzioni educative. Le "Linee di orientamento" sono state rafforzate ulteriormente dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, nota come "La Buona Scuola". Questa legge ha introdotto significative innovazioni nel sistema educativo, con particolare attenzione al benessere degli studenti e alla prevenzione del bullismo. Un altro pilastro fondamentale nella strategia di prevenzione è rappresentato dalla Legge 71 del 29 maggio 2017, intitolata "Disposizioni a Tutela dei Minori per la Prevenzione ed il Contrasto del Fenomeno del Cyberbullismo". Questa legge definisce il cyberbullismo e, tra le sue disposizioni, chiede alle scuole l'adozione di piani e progetti di prevenzione specificamente pensati per il cyberbullismo. La legge introduce inoltre misure protettive per i minori, tra cui la possibilità per i giovani dai 14 anni in su di richiedere la rimozione di contenuti lesivi online, con l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali in caso di mancata rimozione entro 48 ore. Nel 2021, le linee guida sono state aggiornate per riflettere le nuove sfide e le evoluzioni nel contesto sociale e tecnologico. L'aggiornamento ha enfatizzato l'importanza di corsi e-learning sulla piattaforma ELISA (uno strumento online sviluppato per supportare gli insegnanti nella prevenzione e gestione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole italiane) e la creazione di team specializzati per l'emergenza e il contrasto al bullismo nelle scuole. Infine, il lancio del progetto "Safer Internet Centre", supportato da "Digital Europe", mira a promuovere una navigazione consapevole e sicura su internet, educando i giovani all'uso responsabile delle tecnologie digitali. Questo quadro legislativo e operativo mostra l'impegno e gli sforzi del nostro paese nella lotta contro il cyberbullismo, attraverso un approccio che integra educazione, prevenzione, e tutela legale, mirando a creare un ambiente sicuro e supportivo per tutti i giovani.
Conclusioni
In questo breve articolo, abbiamo esplorato la complessità del cyberbullismo, un fenomeno ampiamente discusso ma ancora non pienamente compreso. Abbiamo analizzato la sua definizione, esaminato i fattori di rischio e le possibili protezioni che abbracciano caratteristiche individuali, familiari, scolastiche e sociali, nonché gli aspetti legislativi correlati. Questa panoramica, pur non essendo esaustiva, intende offrire un punto di partenza per approfondire la conoscenza di questo fenomeno critico.
Con l'avvento di generazioni sempre più immerse in ambienti digitali, è essenziale riflettere seriamente sui potenziali rischi che tali contesti possono rappresentare per il benessere psicologico dei giovani. È fondamentale, quindi, promuovere pratiche che potenzino l'empatia e le competenze relazionali nei giovani, così come è vitale rafforzare le abilità degli educatori, affinché possano orientare verso un uso consapevole dei media digitali e educare alla prosocialità, una strategia preventiva contro il cyberbullismo.
Oltre a queste strategie preventive, è importante anche sviluppare meccanismi di risposta e intervento efficaci che includano programmi di supporto psicologico per le vittime e percorsi educativi per gli aggressori, volti a modificare comportamenti nocivi e a rafforzare il rispetto reciproco. La collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e organizzazioni del terzo settore può giocare un ruolo chiave nell'elaborare e implementare queste iniziative, creando una rete di sicurezza più robusta attorno ai giovani e assicurando un futuro digitale più sicuro e inclusivo per tutti.
Glossario
Competenze socio-emotive. Insieme di abilità che consentono agli individui di comprendere, gestire e utilizzare le proprie emozioni, nonché di interagire in modo efficace con gli altri. Queste competenze includono la consapevolezza emotiva, l'autoregolazione, l'empatia, la comunicazione interpersonale e la capacità di lavorare in gruppo. Sviluppare competenze socio-emotive è fondamentale per promuovere relazioni positive, risolvere conflitti e affrontare situazioni sociali in modo costruttivo.
Disimpegno morale. Meccanismo psicologico che consente agli individui di giustificare o razionalizzare comportamenti eticamente o moralmente discutibili, evitando il senso di colpa o responsabilità. Questo processo avviene attraverso diverse strategie, come la minimizzazione del danno, la deumanizzazione della vittima o il trasferimento della responsabilità ad altri. Un esempio comune accade nel cyberbullismo, in quanto l'aggressore potrebbe giustificare il proprio comportamento dicendo che la vittima "se lo merita" o che "tutti lo fanno", riducendo così il peso morale delle proprie azioni.
Fattori di rischio e di protezione. Condizioni o caratteristiche che aumentano la probabilità che una persona sviluppi un problema o si trovi in una situazione sfavorevole, come il coinvolgimento in comportamenti devianti, la violenza o il bullismo. I fattori di protezione, al contrario, sono quegli elementi che riducono la probabilità che una persona sviluppi tali problemi, promuovendo invece il suo benessere e la sua resilienza.
Bibliografia
Ansary, N. S. (2020). Cyberbullying: Concepts, theories, and correlates informing evidence-based best practices for prevention. Aggression and Violent Behavior, 50, 101343. https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.101343
Antoniadou, N., Kokkinos, C. M., & Fanti, K. A. (2019). Traditional and Cyber Bullying/Victimization Among Adolescents: Examining Their Psychosocial Profile Through Latent Profile Analysis. International Journal of Bullying Prevention, 1(2), 85–98. https://doi.org/10.1007/s42380-019-00010-0
Baldry, A. C., Farrington, D. P., & Sorrentino, A. (2015). “Am I at risk of cyberbullying”? A narrative review and conceptual framework for research on risk of cyberbullying and cybervictimization: The risk and needs assessment approach. Aggression and Violent Behavior, 23, 36–51. https://doi.org/10.1016/j.avb.2015.05.014
Baldry, A. C., Sorrentino, A., & Farrington, D. P. (2019). Cyberbullying and cybervictimization versus parental supervision, monitoring and control of adolescents' online activities. Children and Youth Services Review, 96, 302-307. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.058
Bastiaensens, S., Vandebosch, H., Poels, K., Van Cleemput, K., DeSmet, A., De Bourdeaudhuij, I. (2015). ‘Can I afford to help?’ How affordances of communication modalities guide bystanders’ helping intentions towards harassment on social network sites. Behaviour & Information Technology, 34(4), 425–435. https://doi.org/10.1080/0144929X.2014.983979
Berne, S., Frisén, A., & Berne, J. (2019). Cyberbullying in Childhood and Adolescence: Assessment, Negative Consequences and Prevention Strategies. In J. Lunneblad (Ed.), Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth (Vol. 2, pp. 141–152). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3- 030-18605-0_10
Campbell, M., & Bauman, S. (2018). Cyberbullying: Definition, consequences, prevalence. In Reducing Cyberbullying in Schools (pp. 3–16). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811423-0.00001-8
Chen, Q., Lo, C. K., Zhu, Y., Cheung, A., Chan, K. L., & Ip, P. (2018). Family poly-victimization and cyberbullying among adolescents in a Chinese school sample. Child abuse & neglect, 77, 180-187. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.01.015
Coelho, V. A., Marchante, M., & Romao, A. M. (2022). Adolescents’ trajectories of social anxiety and social withdrawal: Are they influenced by traditional bullying and cyberbullying roles?. Contemporary Educational Psychology, 69, 102053. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2022.102053
Corcoran, L., Guckin, C., & Prentice, G. (2015). Cyberbullying or Cyber Aggression?: A Review of Existing Definitions of Cyber-Based Peer-to-Peer Aggression. Societies, 5(2), 245–255. https://doi.org/10.3390/soc5020245
Craig, W., Boniel-Nissim, M., King, N., Walsh, S. D., Boer, M., Donnelly, P. D., Harel-Fisch, Y., Malinowska-Cieślik, M., Gaspar De Matos, M., Cosma, A., Van Den Eijnden, R., Vieno, A., Elgar, F. J., Molcho, M., Bjereld, Y., Pickett, W. (2020). Social Media Use and Cyber-Bullying: A Cross-National Analysis of Young People in 42 Countries. Journal of Adolescent Health, 66(6), S100–S108. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.006
Foody, M., McGuire, L., Kuldas, S., & O’Higgins Norman, J. (2019). Friendship quality and gender differences in association with cyberbullying involvement and psychological well-being. Frontiers in psychology, 10, 460972.
Geoffroy, M. C., Boivin, M., Arseneault, L., Turecki, G., Vitaro, F., Brendgen, M., ... & Côté, S. M. (2016). Associations between peer victimization and suicidal ideation and suicide attempt during adolescence: results from a prospective population-based birth cohort. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(2), 99-105. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2015.11.010
Gini, G., Pozzoli, T., Jenkins, L., & Demaray, M. (2021). Participant Roles in Bullying. In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Bullying (1st ed., pp. 76–95). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118482650.ch5
Guarini, A., & Brighi, A. (2021). Cyberbullismo a scuola: Percorso di prevenzione per muoversi consapevolmente in rete. Scuola secondaria di primo grado. Erikson.
Hemphill, S. A., Tollit, M., Kotevski, A., & Heerde, J. A. (2015). Predictors of Traditional and Cyber-Bullying Victimization: A Longitudinal Study of Australian Secondary School Students. Journal of Interpersonal Violence, 30(15), 2567–2590. https://doi.org/10.1177/0886260514553636
Hutson, E., Kelly, S., & Militello, L. K. (2018). Systematic review of cyberbullying interventions for youth and parents with implications for evidence‐based practice. Worldviews on evidence‐based Nursing, 15(1), 72-79. https://doi.org/10.1111/wvn.12257
Kofoed, J., & Staksrud, E. (2019). ‘We always torment different people, so by definition, we are no bullies’: The problem of definitions in cyberbullying research. New Media & Society, 21(4), 1006–1020. https://doi.org/10.1177/1461444818810026
Machackova, H. (2020). Bystander reactions to cyberbullying and cyberaggression: Individual, contextual, and social factors. Current Opinion in Psychology, 36, 130–134. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.06.003
Menabò, L., Skrzypiec, G., Slee, P., & Guarini, A. (2023). Victimization and cybervictimization: The role of school factors. Journal of Adolescence, 96(3), 598-611. https://doi.org/10.1002/jad.12284
Menesini, E., & Nocentini, A. (2009). Cyberbullying Definition and Measurement: Some Critical Considerations. Zeitschrift Für Psychologie / Journal of Psychology, 217(4), 230–232. https://doi.org/10.1027/0044-3409.217.4.230
Menin, D., Guarini, A., Mameli, C., Skrzypiec, G., & Brighi, A. (2021). Was that (cyber)bullying? Investigating the operational definitions of bullying and cyberbullying from adolescents’ perspective. International Journal of Clinical and Health Psychology, 21(2), 100221. https://doi.org/10.1016/j.ijchp.2021.100221
O’ Brien, N. (2021). School Factors with a Focus on Boarding Schools. In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Bullying (1st ed., pp. 76–95). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118482650.ch5
Olweus, D., & Limber, S. P. (2018). Some problems with cyberbullying research. Current Opinion in Psychology, 19, 139–143. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.04.012
Peter, I. K., & Petermann, F. (2018). Cyberbullying: A concept analysis of defining attributes and additional influencing factors. Computers in human behavior, 86, 350-366. https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.05.013
Pouwels, J. L., & Garandeau, C. F. (2021). The role of the peer group and classroom factors in bullying behavior. In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of bullying: A comprehensive and international review of research and intervention (pp. 450–466). Wiley Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781118482650.ch25
Pozzoli, T., & Gini, G. (2020). Behavior during cyberbullying episodes: Initial validation of a new self‐report scale. Scandinavian Journal of Psychology, 61(1), 22–29. https://doi.org/10.1111/sjop.12517
Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1998). Bullying as a group process: Participant roles and their relations to social status within the group. Aggressive Behavior, 22(1), 1–15. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:13.0.CO;2-T
Scheithauer, H., Schultze‐Krumbholz, A., Pfetsch, J., Hess, M. (2021). Types of Cyberbullying. In P. K. Smith & J. O. Norman (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Bullying (1st ed., pp. 120–138). Wiley. https://doi.org/10.1002/9781118482650.ch7
Schultze-Krumbholz, A., Hess, M., Pfetsch, J., & Scheithauer, H. (2018). Who is involved in cyberbullying? Latent class analysis of cyberbullying roles and their associations with aggression, self-esteem, and empathy. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 12(4). https://doi.org/10.5817/CP2018-4-2