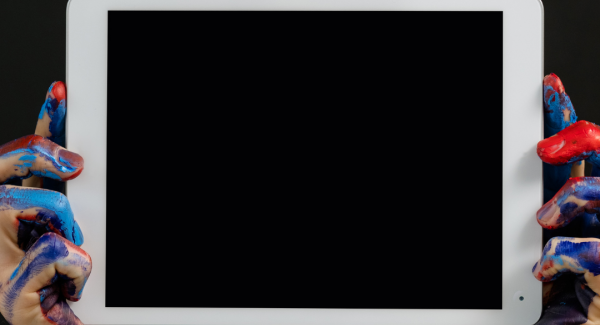Se con il termine Antropocene si intende la nuova era geologica fortemente condizionata dall’attività umana (Crutzen, 2005), con il termine Era digitale o Era dell’informazione (Helvey, 1971) si intende l’attuale fase storica influenzata dalla produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e strumenti di comunicazione come, ad esempio, i telefoni cellulari che, ad oggi, sono posseduti e utilizzati dal 68% della popolazione mondiale (We are social, 2023). I cambiamenti apportati dalla rivoluzione digitale hanno modificato non solo il mondo dell’informazione, i bisogni dei/lle consumatori/trici e le abitudini delle persone, ma anche aggiornato il vocabolario delle definizioni generazionali in base al periodo tecnologico in cui gli individui nascono e vivono. A questo proposito, nel 2001 Prensky ha coniato l’espressione “nativi digitali” riferendosi a coloro che sono nati e cresciuti a stretto contatto con le nuove tecnologie tanto da considerarle un elemento naturale e familiare del loro vissuto. Ma quante generazioni di nativi digitali sono state classificate fino a oggi? La “Generazione Z”, cioè i nati tra la metà degli anni 90 e i primi anni 2010 e la “Generazione Alpha” cioè le persone nate tra il 2010 e il 2024. È bene sottolineare che a partire dal 2007, cioè con l’avvento sul mercato dell’iphone, la diffusione e l’uso dei device “touch” sono diventati predominanti tanto da portare a identificare i nati a partire dal 2007 come la “Generazione Touch” detta anche “Screen generation”. Ciò che contraddistingue queste generazioni dalle precedenti, è l’ambiente di tecnologia avanzata con cui le persone che ne fanno parte interagiscono fin dai primi anni di vita. Questo ha fatto sì che le capacità d’uso dei digital device (si veda glossario) si è potenziata persino nei bambini e nelle bambine di età prescolare, principalmente perché sono i loro stessi genitori a usarli quando sono presenti e a farglieli utilizzare. Non di rado, infatti, i digital device sono usati dai genitori per occupare il tempo dei/lle figli/e trasformandoli così in vere e proprie babysitter del nuovo millennio (Viola & Lucantoni, 2022) che, come rilevato dalla Società Italiana di Pediatria (SIP, 2018), sono funzionali a calmare e distrare i bambini e le bambine come fossero dei “ciucci emotivi”. Tale tendenza d’uso emerge anche da una ricerca condotta da Genta (2021), nella quale il 30% dei genitori intervistati dichiara di utilizzare gli strumenti digitali con questo scopo, nonostante questo possa portare i/le più piccoli/e a isolarsi dalla realtà e a instaurare un attaccamento emotivo con il dispositivo. La frequenza di utilizzo da parte dei bambini e delle bambine dipende anche dal fatto che la loro fruizione è operazionalmente semplice. Infatti, per interagire ad esempio con i touchscreen non è richiesta nessuna competenza di base e nessun apprendimento pregresso (Kopecký & Hejsek, 2015), l’unica esperienza richiesta è quella del toccare. I/le bambini/e toccano e saggiano istintivamente gli schermi pensando che gli oggetti esposti facciano parte della realtà (Dini & Ferlino, 2016). Ma quanti bambini e bambine possiedono un cellulare o digital device? In Italia, l’80% dei bambini e delle bambine dai 3 ai 5 anni sa interagire con lo smartphone dei propri genitori (Genta, 2021) e l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 ha fatto registrare un aumento d’uso personale dei cellulari. Prima della pandemia avevano un cellulare il 9,2% dei bambini e delle bambine da 1 a 5 anni, ora lo possiede il 14,5% (Picca et al., 2021). Sempre secondo Picca et al. (2021) il 58,4% dei bambini e delle bambine (tra i 6 e i 10 anni) possiede un device, percentuale più alta (23,5%) rispetto al periodo del primo lockdown (Marzo-Maggio 2020). A partire dal mese di Marzo 2020, per fronteggiare la pandemia da COVID-19, in Italia, come in altri Paesi coinvolti, sono state messe in atto delle misure restrittive e di contenimento, che hanno avuto ripercussioni importanti sulla vita dei singoli individui e sulla collettività (Renzi & Saioni, 2021). Durante il periodo del primo lockdown, infatti, si è riscontrato un aumento dell’utilizzo della tecnologia, dei social network e dei giochi online da parte dei bambini e delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze (Idoiaga et al., 2020; Telefono Azzurro e Doxa, 2020). Inoltre, da una ricerca condotta in Italia dall’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISTC-CNR), nel periodo aprile-maggio 2020 in un campione di bambini e bambine di 8-14 anni sono emerse delle differenze di genere rispetto all’uso dei digital device: le femmine hanno realizzato più videochiamate agli amici/alle amiche (73% contro 58%) e hanno trascorso più tempo sui social (38,1% contro 17,9) rispetto ai maschi, questi ultimi, invece, hanno giocato di più ai videogiochi rispetto alle femmine (76,6% contro 52,8%) (Renzi & Saioni, 2021). Per quanto concerne il tempo di utilizzo, in un’indagine statunitense condotta dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2018), è stato rilevato che i bambini e le bambine tra gli 8 e i 10 anni passano una media di 6 ore settimanali sugli schermi, che diventano 9 nella fascia 11-14 anni (senza considerare l’uso che ne fanno anche a scuola). In aggiunta, secondo quanto riportato da un altro studio statunitense di Rideout e Robb (2020), nel 98% delle case in cui vive un bambino (0-8 anni) è presente un digital device - percentuale aumentata rispetto al 2013 (75%) -, il 73% di/lle bambini/e (0-8 anni) guarda uno schermo fin dai primi anni di vita e il 48% possiede personalmente un digital device (dato che era al 12% nel 2013). Spostandoci nel Regno Unito, da alcuni dati contenuti nel report di Office of Communications (Ofcom, 2022), è stato messo in evidenza che il 39% dei bambini e delle bambine tra i 3 e i 4 anni usa il telefono cellulare e il 78% il tablet - percentuale che aumenta tra i 5 e i 7 anni (83%), mentre a possedere uno smartphone personale è il 61% di loro. Come sottolinea Carr (2010), il dilemma che stiamo vivendo è che le tecnologie diventano estensioni di noi stessi, mentre noi stiamo diventando estensioni delle nostre tecnologie. Per questo è di fondamentale importanza focalizzarsi sull’impatto che i digital device hanno sull’infanzia e sull’adolescenza così da attuare strategie che limitino i danni derivati dal trasformare le reali esperienze di crescita esclusivamente in esperienze virtuali, che si vivono davanti a uno schermo (Riva, 2019).
I possibili effetti negativi e positivi delle tecnologie sullo sviluppo dei bambini e delle bambine
Dopo avere visto quanto sia ampiamento diffuso l’utilizzo delle tecnologie da parte dei bambini e delle bambine, risulta ora utile soffermarsi su quale sia il loro impatto sullo sviluppo infantile e sulle relazioni personali e familiari. Per fare questo è utile riferirsi al documento della SIP (2018), che evidenzia, nei bambini e nelle bambine in età prescolare, gli effetti dell’esposizione precoce agli schermi sull’apprendimento, sullo sviluppo neurocognitivo, sul benessere in generale ma anche sulla vista, sull’udito e sulle funzioni metaboliche e circolatorie (Bozzola et al., 2018). In letteratura, il termine “schermi” include oggetti molto diversi tra loro, tra cui smartphone, tablet, computer e televisione (Grollo et al., 2023). Quest’ultima rappresenta sicuramente uno strumento più obsoleto rispetto ai moderni dispositivi tecnologici ma il suo uso è diffuso da più tempo e è ancora ampiamente utilizzata da adulti e bambini/e, come rileva una recente indagine condotta dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, 2022): nel 2020, infatti, i bambini e le bambine di 3-5 anni che guardano abitualmente la televisione sono il 95,2%, contro l’88,7% del 2000. Sulla base dello studio condotto alla SIP (2018) si possono individuare i seguenti effetti dell’uso del digital device nei bambini e nelle bambine.
Apprendimento
L’uso dei touchscreen può influenzare l’apprendimento in generale, diminuendo le capacità di attenzione e le performance cognitive dei/lle più piccoli/e (Desmurget, 2020). Diversamente, l’apprendimento linguistico può essere facilitato dalla visione di video (Ebbeck et al., 2016) e dall’uso di applicazioni educative, ma solo in presenza del genitore (Chiong & Shuler, 2010; Linebarger, 2014).
Sviluppo neuronale
Secondo Schmidt et al., (2008), lo sviluppo neuronale del/lla bambino/a può essere influenzato anche dalla televisione in sottofondo perché impatta sulla qualità della relazione genitore-figlio/a, sui livelli di attenzione e sulla qualità delle relazioni sociali (Pagani et al., 2010). Data l’elevata plasticità del cervello dei bambini e delle bambine (Oliverio, 2017) questo può subire dei cambiamenti in risposta alle esperienze esterne e possono insorgere anche cambiamenti transitori di umore o eccitazione (Bavelier er al., 2010).
Benessere
In relazione al benessere generale, l’uso dei device per più di 2 ore al giorno può influire negativamente sulla salute fisica e associarsi sia a un aumento del peso corporeo, in quanto favorisce la sedentarietà (Desmurget, 2020) sia a problemi comportamentali, che possono sfociare in depressione o comportamenti aggressivi (Toumbourou et al., 2011). È stata trovata, inoltre, una correlazione tra utilizzo del tablet e sintomi di cefalea e dolore muscolare (soprattutto a collo e spalle), dovuto alla postura inappropriata (Chiang & Liu, 2016).
Sonno
La qualità del sonno e il ritmo circadiano possono essere compromessi da alcuni fattori come i contenuti stimolanti e le radiazioni elettromagnetiche emesse dall’esposizione alla luce dello schermo (Cain, & Gradisar, 2010). L’uso contemporaneo di più strumenti per più di 2 ore al giorno può causare difficoltà e ritardi nell’addormentamento (Hysing et al., 2015; Desmurget, 2020). In più, anche avere la tv in camera altera la qualità del sonno soprattutto per i bambini e le bambine di età compresa tra 1 e i 4 anni perché manifestano paura del buio, incubi e dialoghi notturni (Brockmann et al., 2016).
Vista e Udito
Un uso prolungato di tablet e smartphone può causare secchezza oculare e se tenuti a distanza ravvicinata anche affaticamento, abbagliamento e irritazione (Moon et al., 2016). Inoltre, può causare anche “l’esotropia acquisita concomitante”, cioè una forma di strabismo che si verifica quando appare una forma di diplopia (si veda glossario) che coinvolge dapprima solo la visione lontana e poi anche quella ravvicinata (Lee et al., 2016). L’esposizione a intensi livelli di rumore emessi dai digital device può alterare la percezione dei suoni, con possibili interferenze sullo sviluppo del linguaggio, della comunicazione e dell’interazione con gli altri bambini e bambine (Tyler, 2015).
Interazione genitore – bambino/a
Fino ad ora ci siamo concentrati sugli effetti dell’uso della tecnologia sullo sviluppo psico-fisico dei bambini e delle bambine, ma è interessante focalizzare l’attenzione anche sulle relazioni personali e familiari. Un recente studio (Myruski et al., 2018), focalizzato sulle interruzioni di gioco nella relazione madre e bambino/a (età compresa tra i 7 e i 23 mesi), ha evidenziato come l’uso del cellulare, da parte della madre, riduce la qualità della comunicazione e ha un forte impatto sulla regolazione emotiva dei bambini e delle bambine e sulla qualità della loro comunicazione espressiva-emotiva. Questo comportamento incide, di conseguenza, anche sullo sviluppo cognitivo, emotivo e linguistico (Morris et al., 2022) e ostacola la sicurezza del/la bambino/a e il suo benessere psicofisico in generale (Grollo et al., 2023). Inoltre, l’uso dei device digitali può ridurre le interazioni verbali e non verbali tra gli adulti e i bambini e le bambine e può causare conflitti, reazioni oppositive e comportamenti non emozionali (Schmidt et al., 2008; Wagner et al., 2016). La disamina sugli effetti di un uso errato delle tecnologie ha mostrato i potenziali rischi, però è utile dire che un uso appropriato, soprattutto in presenza del genitore, può limitare i danni e contribuire allo sviluppo di alcune competenze, come il problem solving (Chiong & Shuler, 2010). Tuttavia, al di sotto dei due anni le interazioni con i genitori e con il mondo circostante restano i fattori fondamentali per un sano sviluppo psicofisico del bambino (Reid Chassiakos et al., 2016).
Il ruolo del genitore nell’uso consapevole e attivo dei digital device
La famiglia è il primo ambiente di crescita nel quale si instaura la relazione educativa, affettiva e comunicativa tra l’adulto/a e i/le bambini/e. Il contesto familiare è quello prevalente, specialmente nei primi 1000 giorni di vita. Oggi, la presenza della tecnologia sta ponendo nuove sfide alle relazioni familiari e, spesso, rischia di sostituire le figure genitoriali (Genta, 2021). Per questo, già a partire dal 2013, l’Accademia Americana di Pediatria ha fornito le prime raccomandazioni per un uso consapevole e ponderato dei device. Queste raccomandazioni sono state successivamente condivise anche dalla SIP (2018) e ampliate dalla World Health Organization (WHO, 2019) che, contestualmente, ha offerto anche strategie di promozione dell’attività fisica per contrastare un ulteriore effetto degli strumenti digitali, noto come sedentary screen time. In sostanza, per i bambini e le bambine al di sotto dei 2 anni è vivamente sconsigliato l’uso dei touchscreen, specialmente durante i pasti, un’ora prima di andare a dormire e/o per calmarli. tra i 2 e i 5 anni il limite dell’esposizione è di massimo un’ora al giorno e massimo di due tra i 5 e gli 8 anni. In merito alla durata dell’esposizione, sono interessanti l’approccio graduale di Tisseron (2016) con la regola 3-6-9-12, anche noto come dieta digitale, e il metodo proposto da Shapiro (2019). Secondo Tisseron, così come si rispettano le tappe di sviluppo dei/lle bambini/e in relazione alla propria crescita o, ad esempio, all’entrata nel mondo della scuola (a 3 anni la scuola dell'infanzia; a 6 anni la primaria; a 9 anni l'apprendimento completo della lettura-scrittura; a 11-12 anni la scuola secondaria) o, ancora, alle regole alimentari (con l’introduzione di cibi adeguati in base all’età), così il genitore dovrebbe impostare le direttive per avvicinare progressivamente i/le bambini/e alle tecnologie. Nello specifico, l’autore suggerisce questo approccio: prima dei 3 anni bisogna evitare i dispositivi tecnologici specialmente per il gioco, prima dei 6 non dare nessun tablet personale al bambino. Ancora, lo studioso consiglia internet dopo i 9 anni e i social network dopo i 12. Anche il metodo ideato da Shapiro (2019) può essere un buon alleato per guidare il genitore. In sostanza, l’autore afferma che lo strumento digitale deve diventare per il genitore e i/le bambini/e un mezzo di socializzazione familiare che, specialmente per i più piccoli, non deve essere usato durante i pasti. I/le bambini/e devono essere messi/e nella condizione di conoscere i dispositivi tecnologici che usano passando prima, però, per esperienze “tradizionali” come, ad esempio, quella del gioco, perché in questo modo è possibile sviluppare un reale approccio empatico. Se queste indicazioni vengono seguite correttamente riducono i rischi di assuefazione da parte dei/lle più piccoli/e (Johnson, 2020) e prevengono quelli della dipendenza digitale che potrebbero presentarsi in età adolescenziale. Una fruizione sicura e controllata viene garantita dalla presenza del genitore che condividendo il tempo con il/la bambino/a può stimolare il dialogo e una costruzione narrativa dell’esperienza. Il tempo che il/la bambino/a spende sugli schermi è spesso sottratto all’esplorazione del gioco semplice (Serra, 2012) e simbolico. Il gioco simbolico è un'attività fondamentale per lo sviluppo cerebrale dei/lle bambini/e perché il loro cervello è predisposto naturalmente al gioco (Harding, 2023) e quello virtuale potrebbe compromettere questa competenza simbolica, che compare a partire dai 2 anni, quando dimostrano la capacità di richiamare alla mente qualcosa che sta per qualcos’altro (Bonino, 2018). Questa capacità si favorisce se i/le più piccoli/e possono maneggiare, ad esempio, libri di carta, perché questo aiuta loro a trasferire le informazioni del testo ai contesti reali, comprendendo così la doppia natura delle immagini (DeLoache, 1989). Oltre a quanto sopra messo in evidenza, i genitori devono essere consapevoli che un uso eccessivo e incontrollato della tecnologia disorienta i/le bambini/e sul piano della realtà-virtualità e potrebbe esporli/e al pericolo virtuale, come il cyberbullismo. Infatti, secondo i dati del report Moige (2023) il 31% di minori è vittima di almeno un episodio nella vita. Secondo l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, 2021), la navigazione online, espone i bambini e le bambine a quattro macrocategorie di rischio: contenuto, cioè i casi in cui il/la bambino/a si espone a contenuti disponibili anche a tutti gli altri utenti della Rete senza limiti d’età; condotta, cioè quando i bambini e le bambine sono protagonisti in uno scambio tra pari e tengono un comportamento non idoneo; contatto, cioè quando un/una bambino/a possono essere vittime di una situazione dannosa in Rete, e infine consumatori/trici, cioè quello che potrebbe celarsi dietro le app per acquisti. All’interno della categoria rischi di contenuto rientrano l’incitamento all’odio (a esempio immagini, parole, che possono prendere di mira un certo tipo di religione, genere, etc..) quelli nocivi (truffe online, pubblicità pornografiche), quelli illegali (violazione delle leggi e norme sociali) e quelli di disinformazione (fake news). I comportamenti che mettono a rischio la condotta dei/lle bambini/e sono invece i comportamenti di odio, i comportamenti dannosi, illeciti e problematici come a esempio scambio di messaggi o immagini sessuali. Invece, le situazioni di contatto in rete che mettono a rischio fanno riferimento a comportamenti come il cyberbullismo (bullismo attuato tramite l’uso di dispositivi digitali), il sexting (invio di messaggi/immagini sessuali) e la sextortion (estorsione sessuale). In ultimo, i rischi riguardanti la privacy, la salute e il benessere rientrano in quella categoria che è stata precedentemente definita ‘rischio per i/le consumatori/trici. Sebbene l’ambiente e alcuni device digitali vengano spesso considerati dai genitori come sicuri, in realtà sono contesti e strumenti pericolosi non sempre sicuri e funzionali, in quanto oltre alle opportunità che offrono, come abbiamo visto, espongono i/le bambini/e ad alcuni rischi e non permettono di sperimentare sé stesso nel mondo come essere sociale, limitando le interazioni dirette con il luoghi in cui vivono, anche se questa decisione è vissuta dal genitore come un dilemma (Rosin, 2013).
Il gioco spontaneo e la socializzazione precoce: una possibile soluzione
I bambini e le bambine di oggi vivono un profondo paradosso: da una parte, vengono sempre più frequentemente lasciati autonomi nell’uso delle tecnologie digitali, dall’altra, la loro autonomia di vivere esperienze di gioco e di muoversi da soli/e nell’ambiente circostante tende invece sempre più a ridursi. Possono accedere a una quantità quasi illimitata di contenuti e informazioni pubblicate online, ma l’esperienza di uscire di casa per incontrare gli amici e le amiche e giocare con loro si è molto limitata nel corso degli anni. Indubbiamente le nuove opportunità aperte dal contesto online e dagli strumenti digitali hanno creato nuove e stimolanti occasioni di crescita rispetto a quelle del passato, i bambini sanno manipolare facilmente i dispositivi tecnologici, ma, al contempo, i/le più piccoli/e risultano essere più soli e iperprotetti/e (Tonucci, 2015). Difficilmente possono vivere l’esperienza del rischio nel gioco, che secondo molti autori è fondamentale per godere della realizzazione di un desiderio e acquisire capacità di giudizio e autonomia (e.g., Bertolino, 2022; Dolto, 1987; Farne, 2014). A nostro parere, dunque, risulta necessario continuare a far si che i bambini e le bambine possano sperimentarsi costantemente anche nel contesto offline, muovendosi autonomamente all’interno del proprio quartiere per recuperare la relazione con esso, sviluppare un senso di appartenenza e di comunità, e vivere esperienze di gioco libero con i coetanei e le coetanee. Come abbiamo visto, privare parzialmente o totalmente i bambini e le bambine di questa possibilità li può esporre a dei rischi evolutivi che riguardano la non acquisizione di regole relazionali e strumenti cognitivi che permettono loro di gestire efficacemente le relazioni con i/le loro pari, di affrontare le situazioni reali anche complesse individuando strategie vantaggiose e di avere fiducia nelle proprie competenze (Notte & Renzi, 2022). Senza voler demonizzare l’uso delle tecnologie, riteniamo che un sano equilibrio tra esperienze online e offline sia fondamentale; favorire contatti con le persone e il mondo solo attraverso il filtro di uno schermo non garantisce ai bambini e alle bambine di sfruttare a trecentosessanta gradi le opportunità che la vita può offrire loro, esattamente come una socializzazione precoce vissuta solo ed esclusivamente davanti a uno schermo e mai (o quasi mai) fuori casa. Perseguire questo obiettivo potrebbe essere la nuova sfida che i genitori, gli educatori e gli adulti in generale, sono chiamati a affrontare.
Glossario
Ambiente digitale. Contesto virtuale nel quale i minorenni operano attraverso computer, Internet, cellulari, tablet, videogiochi e social media (linee guida del Consiglio d’Europa “Conosci i tuoi diritti nell’ambiente digitale”).
Digital device. In informatica si intende un dispositivo elettronico ad alta tecnologia e di piccole dimensioni come smartphone, tablet e PC, che permette di fare operazioni informatiche attraverso il collegamento a una rete internet.
Diplopia. Sintomo visivo che si manifesta con la percezione simultanea di due immagini relative ad un unico oggetto.
Nativi digitali. Definizione coniata nel 2001 da Marc Prensky che si riferisce alle generazioni che vivono a stretto contatto con la diffusione delle nuove tecnologie informatiche senza implicare innate competenze informatiche.
Sviluppo psicofisico. Crescita a tappe di progressiva acquisizione di competenze psicomotorie, emozionali e cognitive, che risentono anche dell’influenza dell’ambiente circostante.
Bibliografia
Barr, R. (2013). Memory Constraints on Infant Learning From Picture Books, Television, and Touchscreens. Child Development Perspectives, 7(4), 205-210.
Bavelier, D., Green, C. S., & Dye, M. W. (2010). Children, wired: For better and for worse. Neuron, 67(5), 692-701.
Bertolino, F. (2022). Salvare Robinson. La dimensione pedagogica del rischio nelle esperienze all'aperto. Edizioni Junior-Bambini.
Bonino, S. (2018). Fare finta: molto più di un gioco. Psicologia contemporanea: https://www.psicologiacontemporanea.it/blog/fare-finta-molto-piu-di-un-gioco/
Bozzola, E., Spina, G., Ruggiero, M., Memo, L., Agostiniani, R., Bozzola, M., & Villani, A. (2018). Media devices in pre-school children: the recommendations of the Italian pediatric society. Italian journal of pediatrics, 44(1), 1-5.
Brockmann, P. E., Diaz, B., Damiani, F., Villarroel, L., Núñez, F., & Bruni, O. (2016). Impact of television on the quality of sleep in preschool children. Sleep medicine, 20, 140-144.
Cain, N., & Gradisar, M. (2010). Electronic media use and sleep in school-aged children and adolescents: A review. Sleep medicine, 11(8), 735-742.
Carr, N. (2010). Internet ci rende stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello. Raffaello Cortina Editore.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2018). Screen Time vs. Lean Time Infographic. https://www.cdc.gov/nccdphp/dnpao/multimedia/infographics/getmoving.html
Chiang, H. Y. A., & Liu, C. H. (2016). Exploration of the associations of touch-screen tablet computer usage and musculoskeletal discomfort. Work, 53(4), 917-925.
Chiong, C., & Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that. In Investigations of young children’s usage and learning with mobile devices and apps. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop, 13-20.
Crutzen, P. J. (2005). Benvenuti nell’Antropocene!. Arnoldo Mondadori Editore SpA.
DeLoache, J. S. (1989). The development of representation in young children. In Advances in child development and behavior, 22, 1-39. JAI.
Desmurget, M. (2020). Il cretino digitale. Rizzoli.
Dini, S., & Ferlino, L. (2016). La conoscenza tra le dita dei bambini. Imparare a giocare a tempo di app. TD Tecnologie Didattiche, 24(3), 147-155.
Dolto, F. (1987). Il gioco del desiderio. L'esistenza di ogni essere umano è una partita giocata fra bisogno e desiderio. Collana Sapere, editore Sei.
Ebbeck, M., Yim, H. Y. B., Chan, Y., & Goh, M. (2016). Singaporean parents’ views of their young children’s access and use of technological devices. Early Childhood Education Journal, 44, 127-134.
Farne, R. (2014). Per non morire di sicurezza. L'intenzionalità pedagogica del rischio in educazione. Infanzia: studi e ricerche, 1, 15-23.
Genta, M. L. (2021). Bambini digitali?.Cosa significa davvero mettere in mano ai nostri piccoli cellulari e device. Rischi e opportunità da 0 a 6 anni. Collana Le Comete, Editore FrancoAngeli.
Gottschalk, F. (2019). Impacts of technology use on children: Exploring literature on the brain, cognition and well-being. OECD Education Working Paper No. 195.
Grollo, M., Zanor, S., Oretti, C., Di Leva, A., & Gerosa, T. (2023). Bambini, schermi e benessere. QUADERNI ACP, 30(1), 22-25.
Harding, J. (2023). The Brain that Loves to Play: A Visual Guide to Child Development, Play, and Brain Growth. Routledge
Helvey, T. C. (1971). The age of information: an interdisciplinary survey of cybernetics. Educational Technology Pubns.
Hysing, M., Pallesen, S., Stormark, K. M., Jakobsen, R., Lundervold, A. J., & Sivertsen, B. (2015). Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based study. BMJ open, 5(1).
Idoiaga N., Berasategi N., Eiguren, A. e Picaza M. (2020). Exploring Children’s Social and Emotional Representations of the Covid-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, 11(1952), 1-9.
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) (2022). Tempo libero e partecipazione culturale. Tra vecchie e nuove pratiche https://www.istat.it/it/files//2022/09/Tempo-libero-e-partecipazione-culturale_Ebook.pdf
Johnson, B., (2020). Impacts of screen media on young children. BHM Medical Journal, 7(4), 1-5.
Kopecký, K., Hejsek, L. (2015). Mobile Touch Devices as An Effective Tools of M-Learning and E-Learning. In INTED2015 Proceedings, 7934-7936. IATED.
Lee, H. S., Park, S. W., & Heo, H. (2016). Acute acquired comitant esotropia related to excessive Smartphone use. BMC ophthalmology, 16, 1-7.
Linebarger, D. L., Barr, R., Lapierre, M. A., & Piotrowski, J. T. (2014). Associations between parenting, media use, cumulative risk, and children's executive functioning. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 35(6), 367-377.
Moige (2023). Tra digitale e cyber risk: rischi e opportunità del web. https://www.moige.it/2023/02/02/moige-il-lockdown-ha-aumentato-del-10-gli-episodi-di-bullismo-e-del-8-quelli-di-cyberbullismo-tra-i-minori-in-italia/.
Moon, J. H., Kim, K. W., & Moon, N. J. (2016). Smartphone use is a risk factor for pediatric dry eye disease according to region and age: a case control study. BMC ophthalmology, 16, 1-7 .
Morris, A. J., Filippetti, M. L., & Rigato, S. (2022). The impact of parents’ smartphone use on language development in young children. Child Development Perspectives, 16(2), 103-109.
Myruski, S., Gulyayeva, O., Birk, S., Pérez‐Edgar, K., Buss, K. A., & Dennis‐Tiwary, T. A. (2018). Digital disruption? Maternal mobile device use is related to infant social‐emotional functioning. Developmental science, 21(4).
Notte, M., Renzi, D. (2022). Le cause psicosociali della perdita dell’autonomia di spostamento infantile. In-Mind Magazine, 22.
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (2021). Children in the digital environment. Revised typology of risks. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9b8f222e-en.pdf?expires=1701180943&id=id&accname=guest&checksum=41FA6659128A3A2362A6213B8AAA57E0
Office of communication (Ofcom) (2022). Children and parents: media use and attitudes report: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0023/238361/online-nation-2022-report.pdf
Oliverio, A. (2017). Il cervello che impara: Neuropedagogia dall’infanzia alla vecchiaia. Giunti Psychometrics.
Pagani, L. S., Fitzpatrick, C., Barnett, T. A., & Dubow, E. (2010). Prospective associations between early childhood television exposure and academic, psychosocial, and physical well-being by middle childhood. Archives of pediatrics & adolescent medicine, 164(5), 425-431.
Picca, M., Ferri, P., Manzoni, P., Bove, C., Mantovani, S., & Cavalli, N. (2021). Bambini e lockdown un anno dopo: la parola ai genitori. In Bambini e lockdown un anno dopo: la parola ai genitori, 1-29. Università degli Studi Milano Bicocca.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part. On the Horizon, 9(5),1-6. https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Reid Chassiakos YL, Radesky J, Christakis D, Moreno MA, Cross C (2016). Children and Adolescents and Digital Media. Pediatrics, 138(5).
Renzi, D., & Saioni, E. (2021). L’ascolto dei bambini durante una situazione di emergenza. Un’esperienza di educazione alla democrazia. Scuola democratica, 12(3), 547-565.
Rideout, V., & Robb, M. B. (2020). The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight, 2020. San Francisco, CA: Common Sense Media.
Riva, G. (2019). Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi media. Il Mulino
Rosin, H. (2013). The touch-screen generation. The Atlantic, 20.
Schmidt, M. E., Pempek, T. A., Kirkorian, H. L., Lund, A. F., & Anderson, D. R. (2008). The effects of background television on the toy play behavior of very young children. Child development, 79(4), 1137-1151.
Shapiro, J. (2019). Il metodo per crescere i bambini nel mondo digitale. Newton Compton Editori.
Società Italiana di Pediatria (SIP) (2018). Smartphone e tablet già nel primo anno di vita: no al telefonino “pacificatore”. Arrivano le Raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria. https://sip.it/2018/06/18/smartphone-tablet-gia-nel-primo-anno-vita-no-al-telefonino-pacificatore-arrivano-le-raccomandazioni-della-societa-italiana-pediatria/
Tamburlini, G. (2023). Dispositivi digitali e bambini 0-6 anni Proteggere i bambini dagli schermi per promuovere relazioni di sviluppo. Convegno “I risultati del Sistema di Sorveglianza 0-2 anni sui principali determinanti di salute del bambino - Raccolta dati 2022”: https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/pdf/23-03-2023/TAMBURLINI_23_03_2023.pdf
Tang, L., Darlington, G., Ma, D. W., Haines, J., & Guelph Family Health Study. (2018). Mothers’ and fathers’ media parenting practices associated with young children’s screen-time: A cross-sectional study. BMC obesity, 5, 1-10.
Tayler, R. (2015). Ear bud danger: What’s happening to your https://eu.desmoinesregister.com/story/opinion/columnists/iowa-view/2015/08/01/ear-bud-danger-happening-hearing/30964039/
Telefono Azzurro e Doxa (2020). Coronavirus, l’indagine Telefono Azzurro e Doxa. https://azzurro.it/press/coronavirus-lindagine-telefono-azzurro-e-doxa/?fbclid=IwAR3o8mW7xUkfwreFya8L_0QBXuEV2Z3XZRMi4y6ty0MnJB9bgPvrwjLhFJs
Tisseron, S. (2016). 3-6-9-12. Diventare grandi all'epoca degli schermi digitali. Editrice La Scuola.
Tonucci, F. (2015). La città dei bambini. Un nuovo modo di pensare la città, Bergamo, Zeroseiup.
Toumbourou, J. W., Williams, I., Letcher, P., Sanson, A., & Smart, D. (2011). Developmental trajectories of internalising behaviour in the prediction of adolescent depressive symptoms. Australian Journal of Psychology, 63(4), 214-223.
Viola, I., & Lucantoni, M. (2022). Device, il babysitter del nuovo millennio. https://www.istitutopsicoterapie.com/device-il-babysitter-del-nuovo-millennio/
Wagner, N. J., Mills-Koonce, W. R., Propper, C. B., Willoughby, M. T., Rehder, P. D., Moore, G. A., & Cox, M. J. (2016). Associations between infant behaviors during the face-to-face still-face paradigm and oppositional defiant and callous-unemotional behaviors in early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 44, 1439-1453.
We are Social. I Dati Globali (2023). https://wearesocial.com/it/blog/2023/01/digital-2023-i-dati-globali/
World Health Organization (WHO) (2019). Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children under 5 years of age. https://iris.who.int/handle/10665/311664