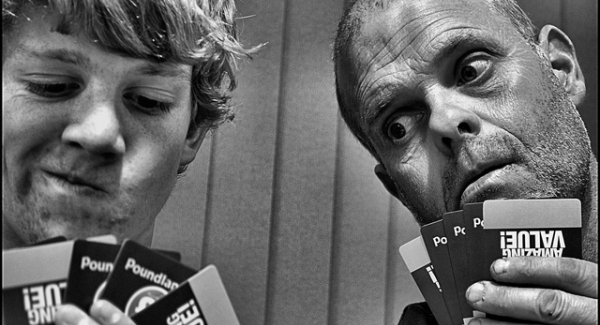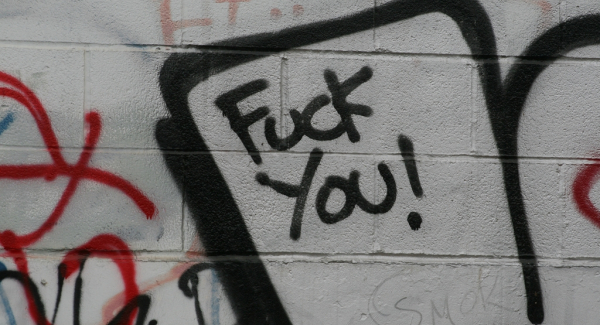Keywords: comportamenti immorali; giustificazione; gruppo di appartenenza.
Quando pensiamo ai comportamenti immorali tendiamo di solito a rappresentarci malvagi individui che compiono “per predisposizione personale” azioni scorrette e di estrema crudeltà nei confronti degli altri e della società più in generale. Le immagini di guerre e genocidi sanguinosi, o ancora di grandi truffatori e politici corrotti che si affastellano davanti ai nostri occhi, pur nella loro inquietante realtà, ci fanno sentire al riparo dalla possibilità di sentire o definire noi stessi come persone immorali. Tendiamo a tracciare una netta e rassicurante linea di confine fra le persone "per bene" che compiono azioni positive da un lato – un gruppo in cui siamo inclini a includere noi stessi – e dall’altro le persone "per male" – distanti da noi, che compiono azioni immorali e riprovevoli. In realtà, definendo il comportamento non etico come l’insieme delle azioni, dalle più piccole alle più grandi, che violano le norme morali ampiamente condivise dalla società (Cojuharenco, Shteynberg, Gelfand, & Schminke, 2011), si comprende come esso sia molto più diffuso di quanto siamo generalmente disposti ad ammettere. Sono diverse le indagini che hanno evidenziato l’ordinarietà e la diffusione dei comportamenti non etici.
Ad esempio, nella vita di tutti i giorni le persone tendono a mentire spesso (mediamente una o due volte al giorno, DePaulo & Kashy, 1998), mentre sul posto di lavoro altrettanto spesso sfruttano il tempo per altre attività personali, o compiono azioni scorrette come portare a casa oggetti di proprietà della compagnia in cui lavorano, gonfiare le fatture delle missioni, arrivare in ritardo e andare via dal posto di lavoro in anticipo senza dichiararlo (Bennet & Robinson, 2000). Impressionanti, inoltre, i risultati dell’ultimo rapporto del 2013 dell’organizzazione internazionale Transparency International da cui emerge come nel mondo circa una persona su quattro dichiara di aver pagato una tangente negli ultimi 12 mesi interagendo con le istituzioni e i servizi pubblici.
La disonestà senza disonesti: quali meccanismi psicologici in gioco per giustificare le condotte non etiche?
Considerato il livello di pervasività dei comportamenti non etici, colpisce come la maggior parte delle persone tenda invece a percepirsi come morale e dotata di sani principi e senso etico, anche nei casi più clamorosi di disonestà. Ci troviamo dunque di fronte al paradosso della disonestà diffusa senza persone che ammettano di definirsi tali, una disonestà quindi senza disonesti.
Basti pensare al caso di Bernard Madoff, il broker dell’alta finanza statunitense condannato qualche anno fa a ben 150 anni di carcere per aver compiuto una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi, trafugando illegalmente più di cinquanta miliardi di dollari e portando alla rovina un numero impressionante di persone. Intervistato in carcere, Madoff ha dichiarato di sentirsi nonostante tutto una “brava persona”. Come spiegare questa percezione di sé così distante dalla realtà dei fatti? Come il caso di Madoff segnala, le persone tendono a presentare dei veri e propri limiti cognitivi (che conducono a sovrastimare la propria moralità nonostante l’evidenza dica il contrario; Moore & Gino, 2013). Siamo propensi infatti non solo a valutare più positivamente in termini morali il comportamento da noi assunto in passato ma anche a sovrastimare le probabilità che assumeremo un comportamento etico in futuro (Tenbrunsel, Diekmann, Wade-Benzoni, & Bazerman, 2010), tendiamo a dimenticare strategicamente o a non badare troppo alle nostre azioni scorrette (Gino & Bazerman, 2009; Shu & Gino, 2012) e a “giocarci dei bonus morali” relativi a buone azioni compiute in passato per giustificare azioni scorrette nel presente (Monin & Miller, 2001). Inoltre, in termini comparativi, siamo propensi a valutare lo stesso comportamento scorretto come meno disonesto se agito da noi stessi rispetto agli altri, e questo doppio standard si estende anche alla valutazione meno negativa che siamo propensi a compiere di comportamenti scorretti agiti da membri del nostro gruppo rispetto a membri di un gruppo esterno (Valdesolo & DeSteno, 2007). Un altro limite cognitivo non trascurabile è legato al fatto che le persone tollerano maggiormente un comportamento non etico quando questo si sviluppa in modo graduale nel tempo, piuttosto che in modo brusco: infatti, una degenerazione brusca del comportamento fornisce subito un chiaro segnale che i confini etici sono stati oltrepassati, mentre un cambiamento graduale indebolisce il segnale di “pericolo morale,” non permettendo alle persone una piena consapevolezza e riconoscimento delle sue implicazioni etiche negative (Gino & Bazerman, 2009).
Ma come è possibile compiere azioni immorali e preservare allo stesso tempo un’immagine positiva di sé? Nelle persone la moralità riveste un ruolo cruciale nella definizione di sé stessi: si parla infatti di identità morale - ovvero l’importanza assegnata nella definizione di sè all’essere morali, onesti e dotati di caratteristiche eticamente rilevanti (Aquino & Reed, 2002). Benché l’identità morale influenzi positivamente il comportamento degli individui proprio in virtù degli standard morali interiorizzati, come abbiamo già avuto modo di argomentare, le persone tendono spesso a compiere azioni immorali.
Questo tipo di comportamenti tende a generare uno stato di disagio derivante dal conflitto fra due motivazioni opposte: da un lato il desiderio di avvantaggiarsi dei benefici concreti e spesso monetizzabili associati al mettere in atto il comportamento disonesto e dall’altro il desiderio di preservare un’immagine positiva ai nostri occhi e agli occhi degli altri. A questo stato di tensione psicologica Barkan, Ayal, Gino e Ariely (2010) hanno dato il nome di dissonanza etica. Così come per la dissonanza cognitiva di cui parla Festinger (1957; si veda glossario), anche nella condizione di dissonanza etica le persone sono fortemente motivate a superare lo stato psicologico negativo derivante dalla presenza simultanea di motivazioni in contraddizione fra loro mettendo in campo una molteplicità di strategie.
Un modo attraverso cui superare la dissonanza è, ad esempio, adottare una categorizzazione flessibile del proprio comportamento disonesto: si sposta un po’ più in là il confine che distingue ciò che è onesto da ciò che è disonesto con l’esito di una ridefinizione morale del proprio comportamento di fatto immorale (Mazar, Amir, & Ariely, 2008). Anche il linguaggio può essere molto efficace per superare la dissonanza etica, ridefinendo con etichette eufemistiche la negatività di un comportamento non etico e, per questo, legittimandolo (Bandura, 1990, 1999; Tenbrunsel & Messick, 2004); sono molti gli esempi a questo proposito, dagli insulti sessisti alle donne ridefiniti come degli scherzi giocosi, al licenziamento selvaggio ridefinito dalle aziende come riorganizzazione della forza lavoro, fino alle tragiche morti di civili nelle guerre che vengono rinominate come danni collaterali. Non sempre è possibile adottare le strategie di ricategorizzazione e ridefinizione del comportamento non etico prima descritte, soprattutto quando lo stesso è innegabilmente tale: in questo caso, le persone mettono in campo altri metodi per razionalizzare il comportamento disonesto e ridurre la dissonanza etica. Una di queste è ad esempio quello di impegnarsi in attività filantropiche o comportamenti altruistici per placare il senso di colpa per l’azione immorale commessa. Levav e McGraw (2009) hanno mostrato a tal proposito in uno studio sperimentale come i partecipanti che avevano ottenuto del denaro disonestamente anziché scegliere di spenderlo per fini edonistici (come una festa in spiaggia), sceglievano di versarlo per spese virtuose (il pagamento delle tasse per l’istruzione di qualcuno). Le persone, dunque, si ripuliscono la coscienza attraverso l’assunzione di condotte positive: Questa immagine della pulizia della coscienza non è solo una metafora efficace ma anche in un certo senso una strategia tramite cui le persone possono affrancarsi dal proprio senso di colpa.
Gli psicologi sociali parlano in questo caso di purificazione morale intesa come il tentativo, tramite la pulizia fisica, di liberarsi dei sentimenti negativi per aver assunto una condotta non etica (Tetlock, Kristel, Elson, Green, & Lerner, 2000). Emblematica la figura di Ponzio Pilato che secondo quanto narrano i vangeli, riferendosi a Gesù e alla sua condanna si lavò le mani davanti al popolo e dichiarò di essere innocente del sangue di quella persona giusta. Il potere simbolico dell’acqua come mezzo di purificazione dei peccati e delle colpe ricorre in molte religioni, da quella cristiana a quella induista o quella islamica. In una ricerca di Zhong, Liljenquist e Cain (2009) questo potere è stato mostrato sperimentalmente. Nel loro studio, i partecipanti dovevano ricordare un episodio da loro vissuto che riguardava, in una condizione, un atto moralmente disinteressato e, in un'altra, un comportamento non etico, avendo poi la possibilità di scegliere in regalo fra un antisettico e una matita. Dai risultati è emerso che il ricordare un proprio comportamento non etico induceva i partecipanti a scegliere maggiormente l’antisettico e, tra questi, chi lo usava lavandosi le mani riportava, in un successivo test, minori livelli di colpa.
Il comportamento non etico in relazione ai gruppi di appartenenza
I gruppi e le reti sociali presentano un ruolo fondamentale nel normalizzare il comportamento non etico rendendolo accettabile e legittimo agli occhi delle persone che ne fanno parte (Moore & Gino, 2013). Recentemente uno n’dranghetista ha dichiarato: “quando ero un assassino andavo in chiesa con animo tranquillo, ora che sono un collaboratore di giustizia non prego più serenamente” (Gratteri & Nicaso, 2013). Queste parole, sbalorditive quanto quelle prima citate di Madoff, possono essere comprese proprio facendo riferimento alla centralità che in termini identitari può rivestire l’appartenenza a un determinato gruppo, centralità a cui ci si riferisce con il concetto di identità sociale (Tajfel & Turner, 1979). I gruppi a cui le persone appartengono si organizzano e sviluppano attorno a delle norme e dei codici di comportamento più o meno espliciti, che stabiliscono quali sono i comportamenti corretti da seguire e quali invece quelli sbagliati da cui stare alla larga. Quando molto identificati col gruppo, i suoi membri tendono a interiorizzarne i valori prototipici, conformando i propri comportamenti a quelli più in linea con questi valori. Nelle associazioni criminali - n’drangheta, mafia o camorra – si è soliti definire infame proprio colui che collabora con la giustizia. Chi tradisce il mandato criminale che prevede il dovere dell’obbedienza e il vincolo del silenzio – sanciti tramite una complessa simbologia di riti di iniziazione che si mescolano non a caso con riti religiosi – perde il proprio onore, il proprio status sociale e la propria rispettabilità nella comunità di riferimento. La conformità ai valori di un gruppo non avviene solo nei gruppi criminali, ma nei gruppi più diversi che caratterizzano la vita di tutti noi. Ricerche sperimentali hanno mostrato, in questo senso, come nei gruppi in cui il comportamento non etico è considerato e accettato come prototipico gli individui cominciano a pensare e agire in modo coerente con quel prototipo, intraprendendo per questo comportamenti non etici (O’Fallon & Butterfield, 2012).
Le persone tendono, inoltre, a giudicare il comportamento non etico di altri individui come meno problematico da un punto di vista morale quando percepiscono gli stessi come vicini a sé (Gino & Galinsky, 2012). Questo non solo determina una valutazione più magnanima del comportamento non etico altrui, ma tende a ridefinire in senso non etico anche i canoni del proprio comportamento provocando un vero e proprio contagio immorale (Gino & Moore, 2013). Gli individui, infatti, sono molto suscettibili all’influenza degli altri e cercano nell’ambiente sociale degli spunti per distinguere cosa è appropriato/giusto da cosa non lo è.
Un altro aspetto interessante è collegato al fatto che quando i beneficiari del proprio comportamento non etico sono anche altre persone, oltre a se stessi, si percepisce il comportamento stesso in termini più positivi, preservando un’immagine morale di sé. In questo senso una posizione estremamente interessante è assunta dalla famiglia, senza dubbio uno dei principali e fondamentali gruppi di appartenenza per gli individui. Benché la famiglia rivesta un ruolo cruciale nella socializzazione del comportamento morale, non sempre le norme di moralità familiare si allineano con le norme di moralità civica. Per descrivere quel fenomeno in cui gli interessi a breve termine della famiglia confliggono con quelli a lungo termine della società civile con la conseguente scelta dei membri di far prevalere gli interessi familiari, si parla di familismo amorale (Banfield, 1959). Anche in questo caso va sottolineato che il familismo amorale non corrisponde all’essere amorali tout court quanto al nutrire forti sentimenti di moralità e lealtà verso la famiglia ma deboli sentimenti di moralità verso la società più in generale. Si assiste a quello che potremmo definire favoritismo morale per il proprio gruppo. Le ricerche a tal proposito ci dicono infatti che la maggior parte delle persone quando aiuta un membro dell’ingroup a raggiungere il successo crede di fare qualcosa di buono, senza considerare il danno arrecato a chi non riceve tale supporto perchè membro dell’outgroup (Bazerman & Banaji 2004). I casi di favoritismo nei confronti della propria famiglia sono molto più numerosi di quello che immaginiamo e vanno ad esempio dal tentativo dei genitori di inserire i propri figli in una buona scuola, comportamento che però dati i posti limitati della scuola stessa può andare a scapito di altri bambini, fino alla tendenza a privilegiare per una posizione lavorativa un proprio parente anche se non meritevole della stessa.
Il comportamento non etico in una dimensione sistemica
In ultima analisi, accanto ai fattori più individuali e di gruppo anche le dimensioni sistemiche sono altrettanto importanti nel comprendere cosa spinge le persone a compiere azioni non etiche. Le disuguaglianze economiche di un paese influenzano ad esempio la tendenza delle persone che vi abitano ad assumere condotte non etiche tramite l’influenza di diverse variabili come la disaffezione diffusa nei confronti del sistema sociale per la sua iniquità (Bloomquist, 2003) o ancora la fiducia generalizzata negli altri connessa a sua volta con la solidarietà sociale (Neville, 2012). Del resto una motivazione importante a comportarsi in modo onesto è proprio la fiducia che gli altri si comporteranno in modo onesto a loro volta. Non è vantaggioso infatti essere i soli onesti in una realtà di disonestà diffusa. Si pensi ad esempio all’evasione fiscale: se la fiducia nell’onestà degli altri è bassa (dalle persone che lavorano nelle istituzioni da cui si aspetta un comportamento corrotto agli altri cittadini comuni da cui ci si aspetta la tendenza a evadere il fisco), sarò meno motivato ad assumere a mia volta comportamenti onesti e virtuosi nei confronti della collettività, sentendomi legittimato a non versare le tasse allo stato per il meccanismo noto come “tutti colpevoli, nessun colpevole” (Bandura, 1990; 1999). Si genera in questo modo la norma implicita più o meno tacita del “così fan tutti” per cui, da un punto di vista sociale, non è condannabile o biasimabile evadere le tasse: ne consegue che la norma “ufficiale” per cui pagare le tasse è un dovere di ogni cittadino diventa sempre più opaca così come il suo rispetto più debole. In questo senso, rendere salienti gli standard morali può contribuire a diminuire la frequenza dei comportamenti non etici come è stato riscontrato da Mazar e colleghi (2008).
Riflettere sulle condotte non etiche evitando di patologizzarle o demonizzarle ma provando a comprenderle nella loro complessità data dall’interconnessione fra fattori individuali, gruppali e sistemici è fondamentale per provare a contrastare le stesse promuovendo un comportamento più equo nei confronti degli altri e della società.
Glossario
Dissonanza cognitiva. Così come in ambito musicale la dissonanza indica la mancanza di accordo e armonia fra due o più suoni emessi contemporaneamente, il concetto di dissonanza cognitiva - introdotto da Leon Festinger nel 1957 - descrive una condizione psicologica di tensione derivante dalla discordanza presente fra due o più credenze o cognizioni in contraddizione fra loro. Per far fronte alla dissonanza le persone mettono in atto una molteplicità di strategie creative volte a superare questo stato.
Bibliografia
Aquino, K. & Reed, A., II. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1423–1440.
Bandura, A. (1990). Mechanisms of moral disengagement. In W. Reich (Ed.), Origins of terrorism: Psychologies, ideologies, states of mind (pp. 161–191). New York: Cambridge University Press.
Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetuation of inhumanities. Personality and Social Psychology Review, 3, 193–209.
Banfield, E. C. (1958). The moral basis of a backward society. NY: Free Press.
Barkan, R., Ayal, S., Gino, F. & Ariel, D. (2010). The pot calling the kettle black: Seeing evil after experiencing ethical dissonance. Working paper #10-03-01. Center of Behavioral Economics, Duke University. Batson.
Bazerman, M. H., & Banaji, M. R. (2004). The social psychology of ordinary ethical failures. Social Justice Research, 2, 111-115.
Bennett, R. J. & Robinson, S. L. (2000). Development of a measure of workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 3, 349-360.
Bloomquist, K. M. (2003). U.S. income inequality and tax evasion: A synthesis. Tax Notes International, 4, 347–367.
Cojuharenco, I., Shteynberg, G., Gelfand, M. & Schminke, M. (2011). Self-construal and unethical behavior. Journnal of Business Ethics, 109,447-461.
DePaulo, B. M. & Kashy, D. A. (1998). Everyday lies in close and casual relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 74, 63-79.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Gino, F., & Galinsky, A. (2012). Vicarious dishonesty: When psychological closeness creates distance from one’s moral compass. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1, 15–26.
Gino, F., & Bazerman, M.H. (2009). When misconduct goes unnoticed: The acceptability of gradual erosion in others’unethical behavior. Journal of Experimental Social Psychology. 45, 708-719.
Gratteri, N. & Nicaso, A. (2013). Acqua santissima. Milano: Mondadori.
Levav, J., & McGraw, P. (2009). Accounting: How feelings about money influence consumer choice. Journal of Marketing Research, 46, 66-80.
Mazar, N., Amir, O. & Ariely, D. (2008). The dishonesty of honest people: A theory of self-concept maintenance. Journal of Marketing Research, 45, 633-644.
Monin, B., & Miller, D.T. (2001). Moral credentials and the expression of prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 81, 33–43.
Moore, C., & Gino, F. (2013). Ethically adrift: How others pull our moral compass from true north, and how we can fix it. Research in Organizational Behavior, 33, 53–77.
Neville, L. (2012). Do economic equality and generalized trust inhibit academic dishonesty? Evidence from state-level search-engine queries. Psychological Science, 23, 339-345.
O’Fallon, M. J., & Butterfield, K. D. (2012). The influence of unethical peer behavior on observers’ unethical behavior: a social cognitive perspective. Journal of Business Ethics, 109, 117-131.
Shu, L., & Gino, F. (2012). Sweeping dishonesty under the rug: How unethical actions lead to forgetting of moral rules. Journal of Personality and Social Psychology, 6, 1164-1177.
Tenbrunsel, A. E., Diekmann, K. A., Wade-Benzoni, K. A. & Bazerman, M. H. (2010). The ethical mirage: A temporal explanation as to why we are not as ethical as we think we are. Research in Organizational Behavior, 30, 153-173.
Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, C.A.: Brooks Cole.
Tenbrunsel, A. E., & Messick, D. M. (2004). Ethical fading: The role of self-deception in unethical behavior. Social Justice Research, 2, 223-236.
Tetlock, P. E., Kristel, O. V., Elson, S. B., Green, M. C. & Lerner, J. S. (2000). The psychology of the unthinkable: Taboo trade-offs, forbidden base rates, and heretical counterfactuals. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 853-870.
Valdesolo, P., & DeSteno, D. A. (2007). Moral hypocrisy: Social groups and the flexibility of virtue. Psychological Science, 18, 689–690.
Zhong, C. B., Liljenquist, K. & Cain, D. M. (2009). Moral self-regulation: Licensing and compensation. In D. de Cremer (Ed.), Psychological perspectives on ethical behavior and decision making (pp. 75-89). New York: Information Age Publishing.