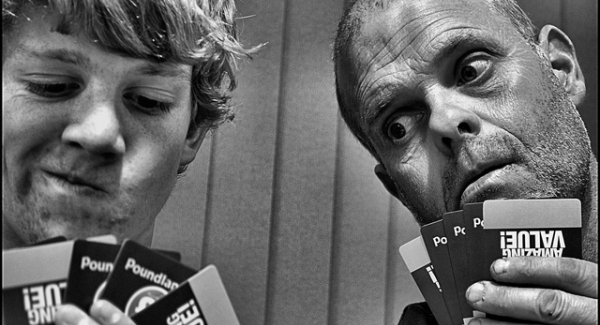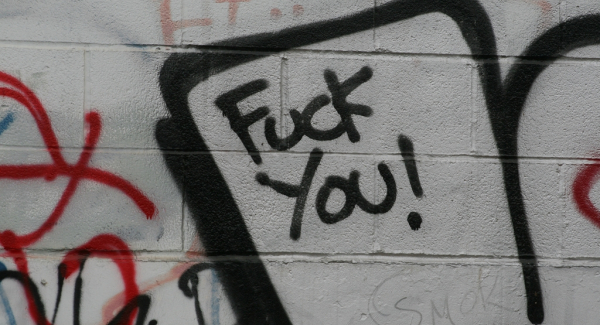Mentre scrivo è nelle sale un nuovo film di Martin Scorsese, dove si raccontano le vicende di Jordan Belfort, uno dei broker di maggior successo nella storia di Wall Street, ma anche un grandissimo truffatore. Alla sua uscita, The Wolf of Wall Street ha suscitato dibattiti molto accesi. Molti, comprese le vittime delle truffe di Belfort, hanno accusato il film di rappresentare in maniera troppo romanzata le vicende del broker, soffermandosi quasi con compiacimento sui suoi comportamenti esagerati, trasgressivi e grandiosi, e facendone quasi un eroe. In effetti gli spettatori finiscono per essere attratti e soggiogati dalla figura di Belfort, interpretato da Leonardo Di Caprio, e il film è rapidamente diventato un cult nel mondo dei broker finanziari, mondo che già altre volte ha mostrato di essere fonte di comportamenti non propriamente ineccepibili. D’altra parte, come sappiamo, durante la recente crisi economica l’intero sistema della finanza mondiale è stato più volte messo in discussione, relativamente a pratiche ritenute quanto meno dubbie dal punto di vista della moralità e del rispetto delle regole di fiducia che devono regolare i rapporti tra i cittadini e il mondo economico. Possiamo quindi dire che le discussioni intorno al film di Scorsese sono esemplificative sia dell’ambivalenza che spesso caratterizza i giudizi e i comportamenti morali, sia del complesso intreccio di fattori individuali, di gruppo e sistemici che entrano in gioco nella definizione delle norme morali.
I contributi presentati in questo numero di In-Mind offrono un quadro sintetico, ma anche chiaro e aggiornato, delle principali direzioni di ricerca verso le quali si stanno indirizzando gli studi psicosociali sulla moralità. Se già da tempo la moralità è al centro dell’attenzione della psicologia dello sviluppo e del ragionamento, è invece relativamente recente l’interesse della psicologia sociale per questo tema. Interesse che in breve tempo è stato in grado di offrire alcune chiavi di lettura stimolanti.
In modi diversi, tutti i contributi mettono in evidenza l’importanza della dimensione della moralità nelle percezioni e nelle scelte delle persone. Nel contributo di Carraro, Negri e Bobbio questa importanza è mostrata dalla stretta connessione tra la moralità e le reazioni fisiche, viscerali e profonde degli individui, in particolare l’emozione primaria del disgusto. Evidenze empiriche mostrano chiaramente che il disgusto non è suscitato solo da cibi, luoghi o odori repellenti, ma anche da comportamenti immorali, che in vario modo possono essere correlati alla percezione di qualcosa di marcio, infetto o contaminato. Carraro e collaboratori ci conducono attraverso una serie di ingegnose sperimentazioni che mostrano il legame tra disgusto e percezione morale. Il contributo non si limita però a questo. Inserisce la questione in una dimensione chiaramente sociale e politica, mostrando come le reazioni di disgusto si legano anche alle scelte ideologiche delle persone. La presenza di questa relazione tra disgusto, reazioni morali e preferenze ideologiche offre spunti interessanti relativamente a quali sono i temi politici che possono suscitare nei cittadini le reazioni più viscerali e più difficili da modificare (ad es., i matrimoni gay).
Nel contributo di Sacchi e Brambilla emerge l’importanza della moralità nella percezione sociale. Un numero consistente di ricerche mostra che la dimensione della moralità, misurata attraverso l’attribuzione di tratti quali “sincero,” “leale” ed “onesto,” gioca un ruolo predominante nell’impressione che ci formiamo degli altri. Se la psicologia sociale da tempo ha mostrato che ci formiamo molto rapidamente un’idea delle altre persone e che questa idea ruota intorno a due dimensioni principali, la “competenza” e il “calore”, la ricerca più recente ha sottolineato l’opportunità di distinguere, all’interno della dimensione del calore, tra le due sottodimensioni della “socievolezza” e della “moralità.” Effettuando studi su questa base scopriamo così che i giudizi sugli altri si fondano più sulla moralità che sulla competenza e sulla socievolezza; che nel valutare i membri di un gruppo di cui facciamo parte (ad es. un gruppo di lavoro) la cosa più importante per noi è che queste persone siano percepite come sincere e oneste; infine, che anche quando giudichiamo persone al di fuori del nostro gruppo, la prima dimensione rispetto alla quale lo facciamo, e spesso in chiave negativa, è la moralità.
Quest’ultimo punto ci introduce al contributo di Moscatelli, Menegatti, Albarello e Rubini, centrato su un’analisi del contenuto degli insulti. Il contributo ci mostra come l’attenzione alla dimensione della moralità si traduce nel linguaggio quotidiano dell’attacco e dell’imprecazione, e mette in evidenza che la moralità legata alla sfera della sessualità è quella alla quale più facilmente si fa riferimento negli insulti. Questo punto riporta a un tema affrontato anche nel contributo sul disgusto di Carraro e collaboratori, ossia la relazione tra la moralità e la dimensione della “purezza” o “santità.”
Se il riferimento ad alcuni principi morali è così importante nei nostri giudizi, ci aspetteremmo coerenza tra le norme che assumiamo come riferimento e la valutazione del nostro e dell’altrui comportamento. Di fatto questa coerenza spesso non c’è. Il contributo di Pacilli, Spaccatini, Pagliaro e Mirisola mette in evidenza una serie di vincoli cognitivi e motivazionali che condizionano fortemente il nostro ragionamento morale. La moralità è una componente importante nella definizione della nostra identità personale e tutti noi aspiriamo ad avere un’identità positiva. Non vi è quindi da stupirsi se ricorriamo a mille modi diversi per cercare di superare le contraddizioni tra le norme che sosteniamo di condividere e i nostri comportamenti (la cosiddetta “dissonanza morale”): non pensare alla norma, ridurre la gravità della violazione e altri stratagemmi per riuscire a definirci sempre e comunque come delle “brave persone.”
Ma la moralità non è una componente importante solo per la nostra identità personale; lo è anche per la nostra identità sociale. Il nostro senso di appartenenza a un gruppo si manifesta spesso proprio attraverso l’adesione alle norme che questo gruppo si è dato, norme che non necessariamente coincidono con quelle della società più ampia nella quale il gruppo si inserisce, ma che non per questo appaiono meno vincolanti. Regole chiare, precise, seguite con “religioso” scrupolo possono caratterizzare gruppi che si collocano nell’illegalità, come quelli camorristici e mafiosi o anche gruppi che, se non includono espressamente la pratica dell’illegalità, possono indirettamente favorirla, attraverso la protezione a oltranza degli interessi del gruppo a scapito di quelli della comunità più ampia di cui il gruppo fa parte (vedi il cosiddetto “familismo amorale”).
In alcuni casi, è proprio quanto accade nella comunità più ampia di cui facciamo parte a condizionare il nostro comportamento morale, anche in direzione di una violazione delle norme morali usualmente condivise. All’interno di una comunità la violazione delle regole può aumentare in modo graduale e non immediatamente visibile, il che fa sì che questa violazione finisca per essere più facilmente tollerata. Non solo. Come osservano Pacilli e collaboratori nel loro contributo, poiché le relazioni all’interno di una comunità si basano fondamentalmente sulla fiducia reciproca, quando questo patto si rompe la deriva verso il mancato rispetto delle regole può diventare inarrestabile e la violazione, inizialmente limitata ad alcuni, può estendersi sempre più.
In conclusione, se da un lato la morale è profondamente radicata nell’individuo, dall’altra è profondamente condizionata dalla società. I contributi presentati in questo numero indicano un serie di percorsi di ricerca che, se sviluppati ulteriormente, possono contribuire in modo significativo a far comprendere appieno le dinamiche di radicamento, ma anche di cambiamento, delle convinzioni e dei comportamenti morali di ciascuno.