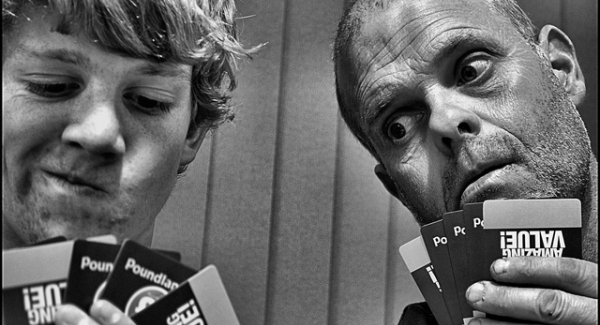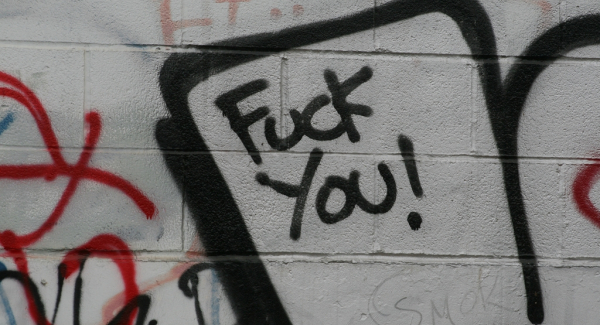Keywords: linguaggio; insulti; moralità.
Sentire e leggere insulti espliciti in televisione, nei giornali o sui social network sta diventando sempre più frequente. Negli ultimi anni anche i leader politici, che dovrebbero essere particolarmente attenti al linguaggio che utilizzano in pubblico, hanno iniziato ad insultare apertamente gli avversari con epiteti fortemente dispregiativi, quali “scimmia puzzolente" (verso un ministro di colore), “truffatore e traditore” (verso un politico che ha votato diversamente dal previsto), “coglione” (verso un politico avversario), “salma” (verso un politico anziano). Alcuni di questi insulti negano le qualità morali delle persone a cui sono diretti, mentre altri ne negano le capacità intellettive o sociali. Di recente, la psicologia ha dimostrato che moralità, competenza e socievolezza costituiscono le dimensioni principali utilizzate nella valutazione di sé e nella formazione delle impressioni sugli altri. In particolare, la moralità svolge un ruolo cruciale nel regolare il comportamento interpersonale e tra individuo e gruppo. Di conseguenza, la negazione di moralità negli altri dovrebbe costituire una delle peggiori forme di offesa e discriminazione. Questa questione può essere considerata proprio esaminando il linguaggio utilizzato dalle persone per schernire, umiliare e offendere gli altri in maniera più o meno grave e intenzionale, ossia gli insulti.
La psicologia morale

La questione di cosa sia morale o immorale, della divisione tra bene e male, tra giusto e sbagliato è stata al centro del pensiero filosofico occidentale fin dalle sue origini. La psicologia, invece, ha iniziato a occuparsi di questo tema solo di recente con gli studi di Piaget sullo sviluppo morale (si veda glossario) nei bambini. Per comprendere come si sviluppa il giudizio morale, Piaget (1932) chiedeva a bambini di circa sei anni perché non si dovessero raccontare bugie. La risposta più comune era “perché le bugie sono parolacce”. I bambini un po’ più grandi (circa 8-10 anni) erano invece in grado di spiegare che non bisogna dire bugie “perché è sbagliato” o “perché non sono la verità”. Nel primo caso, i bambini riunivano parolacce e bugie in “quello che non si può dire”. Secondo Piaget, questo indica chiaramente che, nei primi stadi dello sviluppo, la distinzione tra ciò che è giusto e sbagliato è esteriore dalla coscienza del bambino e si basa su regole imposte dall’autorità. È solo con lo sviluppo del gioco cooperativo che i bambini imparano a mettersi nei panni degli altri e a comprendere che le regole possono basarsi su una nozione più sofisticata di moralità basata sull’equità e il rispetto reciproco. Fu poi Kohlberg (1969) a sistematizzare in stadi successivi lo sviluppo morale come una forma di sviluppo cognitivo (si veda glossario), fondando così la moderna psicologia morale. Secondo questo studioso, i principi universali di giustizia costituiscono il culmine dello sviluppo morale. In seguito, Gilligan (1982) notò che il concetto di giustizia non rendeva conto di tutte le sfaccettature della moralità e propose di considerare “l’etica del prendersi cura” degli altri come un aspetto dello sviluppo morale indipendente dall’ “etica della giustizia”. La psicologia dello sviluppo morale ha quindi individuato due principali dimensioni della moralità: una riguarda il far male e la cura degli altri, l’altra riguarda la giustizia e la reciprocità.
Tuttavia, al di fuori delle civiltà occidentali, i temi legati alla lealtà e al rispetto verso collettività più ampie, come la famiglia, il proprio gruppo, la comunità, o il proprio Paese, così come la purezza spirituale e religiosa, sono spesso parti fondamentali del dominio morale. In base a queste osservazioni, Haidt e collaboratori (Graham et al., 2013; Haidt & Graham, 2007) hanno elaborato la Teoria dei Fondamenti Morali (si veda glossario), per cui ”la moralità è un sistema di valori, virtù, norme, pratiche, identità, tecnologie, istituzioni e meccanismi psicologici che lavorano insieme per sopprimere o regolare l’egoismo e rendere possibile la vita sociale” (Haidt, 2008; p. 70). Secondo questa teoria esistono cinque fondamenti morali innati e universali: 1) i comportamenti dannosi verso gli altri o la preoccupazione per le persone più deboli; 2) le idee di giustizia e rispetto dei diritti altrui; 3) la fedeltà o il tradimento del proprio gruppo; 4) il rispetto verso l’autorità, l’ordine sociale e le tradizioni; 5) i valori di purezza, virtù e integrità sia spirituale che fisica. Ricerche successive hanno mostrato che gruppi diversi, culture e nazioni diverse, così come persone con ideologie diverse basano i propri valori morali su fondamenti diversi. Ad esempio, le persone con ideologie liberali considerano più importanti i valori legati al danno/cura degli altri e all’uguaglianza, mentre i conservatori basano i propri valori morali maggiormente sui principi di rispetto dell’autorità, lealtà verso il proprio gruppo e purezza (Graham et al., 2011). Similmente, le culture orientali (ossia collettiviste) valorizzano maggiormente i principi legati alla purezza e alla lealtà verso l’ingroup rispetto alle culture occidentali (individualiste).
Ellemers e collaboratori (per una rassegna, vedi Ellemers, Pagliaro, & Barreto, 2013) hanno approfondito questa questione studiando la moralità come dimensione fondamentale per la regolazione dei comportamenti all’interno dei gruppi e per la valorizzazione dell’ingroup. Secondo questo approccio, la moralità si riferisce a comportamenti corretti e appropriati verso gli altri, e può essere definita da tratti quali onestà, sincerità e affidabilità. A sua volta, la moralità si contrappone alla socievolezza, intesa come l'abilità di formare connessioni sociali con gli altri e definita da caratteristiche quali amichevole e piacevole, e alla competenza, che riguarda l’efficacia e l’abilità delle persone di svolgere con successo determinati compiti (Leach, Ellemers, & Barreto, 2007). L'importanza di tali dimensioni è spiegata dal fatto che, per sopravvivere, le persone devono comprendere se gli altri siano animati da buone o cattive intenzioni verso di loro, ossia se siano morali e socievoli, così come se siano in grado di mettere in atto tali intenzioni, ossia se siano competenti (vedi anche Fiske, Cuddy, & Glick, 2007). Tuttavia, numerosi studi hanno dimostrato che la moralità, rispetto a socievolezza e competenza, è la dimensione predominante attraverso cui giudichiamo sia gli individui sia i gruppi. Infatti, le persone si identificano maggiormente con gruppi che considerano morali e tendono ad allontanarsi dal proprio gruppo quando questo è percepito come immorale (Leach et al., 2007). Questo accade poiché una persona immorale appartenente al proprio gruppo è minacciosa per l’immagine e per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo stesso (Brambilla, Sacchi, Pagliaro, & Ellemers, 2013). La moralità è più importante di competenza e socievolezza anche quando dobbiamo cercare informazioni o formarci un’impressione sugli altri (Brambilla, Sacchi, Rusconi, Cherubini, & Yzerbyt, 2011; Wojciszke, 2005). Ma cosa accade quando la mancanza di moralità è espressa nei termini delle “parolacce” già indicate dai bambini di Piaget?
Il linguaggio degli insulti

Gli insulti rappresentano una pratica sociale relativamente frequente nelle interazioni tra persone, tesa a rendere l’altro oggetto di disprezzo (van Oudenhoven et al., 2008), negando ciò che è a lui vicino e caro (Semin & Rubini, 1990) e colpendolo nell’onore e nella reputazione (Rodriguez Mosquera, Manstead, & Fischer, 2002). Se l’obiettivo dell’abuso verbale è in ogni caso quello di ferire le persone contro cui è diretto, i termini utilizzati differiscono ovviamente per il contenuto a cui fanno riferimento, il significato e il grado in cui sono effettivamente percepiti come un’offesa dalla persona che ne è oggetto. Già E. R. Leach (1964) aveva individuato tre categorie principali di oscenità: le parole ‘sporche’, che includono i riferimenti al sesso e agli escrementi, la blasfemia e i termini che equiparano un essere umano ad un animale.
Una tassonomia più articolata è stata in seguito proposta da Semin e Rubini (1990), che hanno distinto tra insulti individualistici, insulti relazionali e imprecazioni. Il primo tipo di insulti fa riferimento alla negazione di proprietà individuali ‘normali’ di tipo intellettivo (ad es., “stupido”) o fisico (“ciccione”), ma anche alla messa in atto di comportamenti socialmente indesiderabili (“screanzato”). A questa categoria appartengono anche gli insulti relativi a organi o attività sessuali (“vaffanculo”) e le offese che fanno ricorso a analogie tra la persona e gli animali (“oca”). Mentre tutti questi epiteti sono centrati sull’individuo contro cui sono diretti, gli insulti relazionali fanno riferimento alle persone a lui/lei vicine, ad esempio chiamando in causa relazioni incestuose o sessuali con familiari (“figlio di troia”). In questa seconda categoria rientrano anche gli insulti che coinvolgono i gruppi di appartenenza (“sporco ebreo”). Infine, l’ultima categoria comprende le imprecazioni riguardanti le figure religiose e i termini che fanno genericamente riferimento a organi o atti sessuali (“che palle”).
Come argomentato da Semin e Rubini (1990), l’analisi degli insulti rende possibile mettere in luce la diversa costruzione culturale del concetto di persona – come individuo singolo o come membro di un gruppo – in contesti culturali differenti. Infatti, gli autori hanno mostrato che nell’Italia del Sud, che rappresenta un contesto a orientamento collettivista in cui il gruppo di appartenenza, i suoi obiettivi e le sue norme sono più importanti rispetto a quelli dell’individuo (Hofstede, 1980; Triandis, 1988; vedi anche Schneider & Schneider, 1976), la proporzione di insulti di tipo relazionale è maggiore che in Italia centrale o in Italia del Nord. Viceversa, in Italia del Nord, caratterizzata da un orientamento culturale che valorizza l’individuo rispetto al gruppo (Triandis, 1988), sono più numerosi gli insulti che implicano la negazione di proprietà individuali. Sebbene in questo studio gli insulti siano principalmente distinti in base al fatto che si riferiscano al singolo o alla sua rete di relazioni, i contenuti delle diverse sottocategorie lasciano intuire come essi tocchino tutte le principali dimensioni di giudizio, mirando ad attaccare l’altro sul piano della moralità ma anche delle abilità intellettuali e sociali.
Indicazioni in tal senso emergono anche da un più recente studio interculturale di van Oudenhoven et al. (2008). Attraverso l’esame degli epiteti spontaneamente prodotti dalle persone di fronte ad alcune situazioni-stimolo, gli autori hanno evidenziato che in diverse realtà nazionali gli insulti utilizzati, così come la percezione del loro carattere offensivo, variano in modo consistente. In particolare, in culture collettiviste come la Spagna e la Croazia sono molto diffusi gli insulti relativi alla famiglia ed alle relazioni sociali, mentre in culture caratterizzate da alta mascolinità (ossia culture che enfatizzano i valori maschili tradizionali come l’assertività e il successo, quali la Germania o l’Italia; Hofstede, 1980, 1991), risultano più frequenti gli insulti relativi alla inadeguatezza sociale e all’incapacità sessuale maschile. Alcuni tipi di insulti sono inoltre utilizzati in modo relativamente unico da specifiche culture: per esempio, i tedeschi utilizzano molti epiteti relativi alla mancanza di pulizia/purezza, come “sporco maiale”, mentre i norvegesi sembrano influenzati da paure di tipo religioso o pre-cristiano e usano insulti come “satana” o “diavolo.”
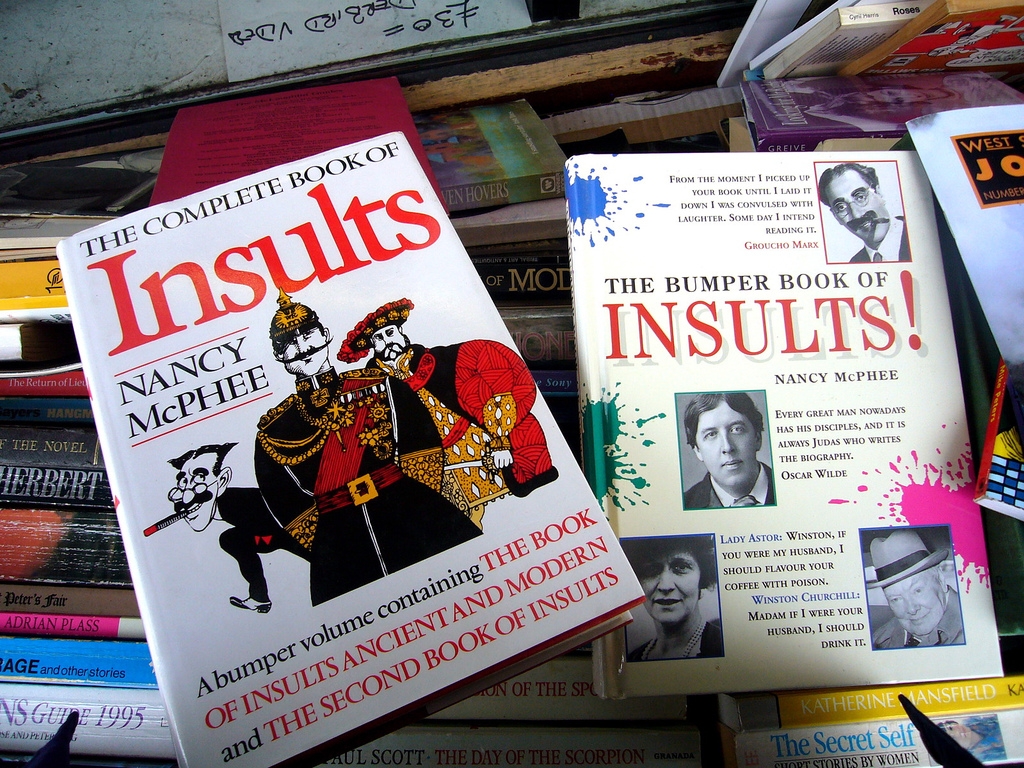
E’ importante infine notare che alcune categorie di termini offensivi costituiscono un taboo in tutte le undici nazioni esaminate da van Oudenhoven et al. (2008): gli epiteti relativi alla sessualità e quelli che chiamano in causa la mancanza di intelligenza. Guardando a questi risultati dal punto di vista delle teorizzazioni sul giudizio sociale (Ellemers et al., 2013; Leach et al., 2007), è dunque possibile affermare che gli epiteti più frequenti e diffusi riguardano da un lato la moralità, nella sua accezione di purezza sessuale (Haidt & Graham, 2007), e dall’altro la competenza.
Una distinzione simile emerge anche dagli studi di Haslam, Loughnan e Sun (2011). Concentrandosi su una particolare categoria di termini offensivi, ossia le metafore animali (cf. Loghnan & Haslam, 2007; Viki et al., 2006), gli autori mostrano che le metafore percepite come più offensive sono quelle che implicano una visione dell’altro come meno umano. In altre parole, l’uso di metafore animali è un mezzo per deumanizzare l’altro. Questo avviene, secondo gli autori, sia attraverso metafore riguardanti depravazione e disgusto morale, che fanno riferimento, ad esempio, ad animali quali serpenti o topi, sia mediante analogie con animali meno “rivoltanti” e più vicini all’uomo nella scala evolutiva, come la scimmia, che enfatizzano la degradazione della persona al livello intellettivo di un animale. Anche i risultati di Haslam et al. (2011), dunque, suggeriscono che le due dimensioni principali attorno a cui ruota il linguaggio più offensivo e deumanizzante siano la moralità e la competenza.
La negazione della moralità attraverso gli insulti
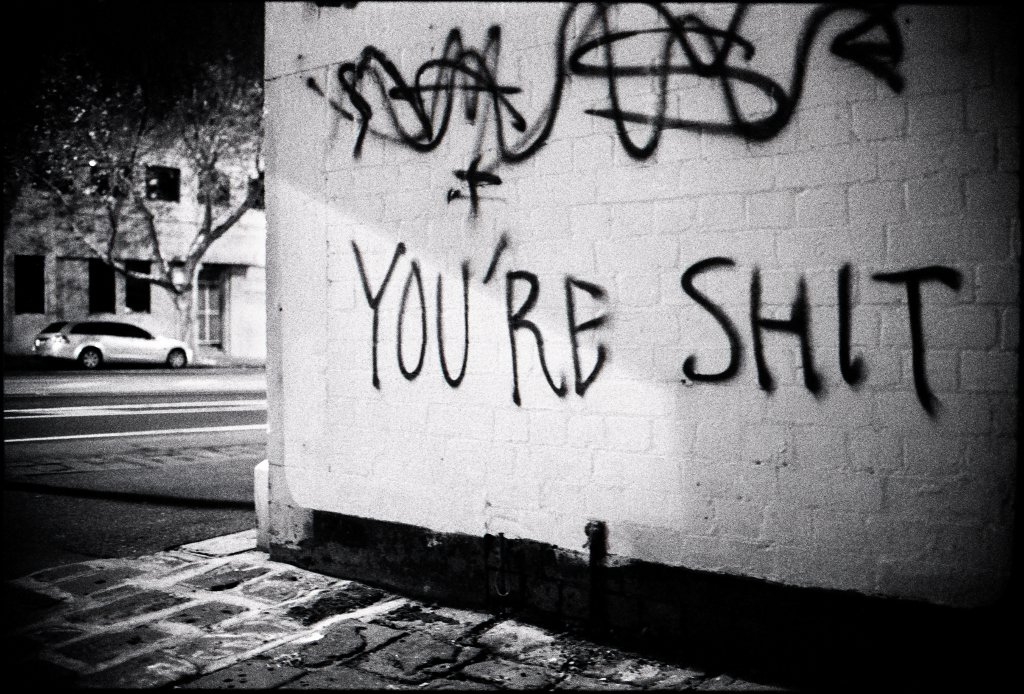
La ricerca sul linguaggio dispregiativo lascia dunque intuire che le dimensioni di moralità e competenza assumano un ruolo fondamentale anche quando le persone insultano gli altri o dicono ‘parolacce’. Questo tema è stato specificatamente indagato da Rubini e Albarello (2011, 2012). In un primo studio, per ottenere un inventario di termini offensivi, le autrici hanno chiesto a un campione di studenti universitari di generare il più alto numero possibile di insulti pensando a diverse situazioni in cui potrebbero essere utilizzati. Due giudici indipendenti (si veda glossario) hanno quindi condotto un’analisi del contenuto dei quasi 3000 epiteti prodotti al fine di distinguere alcune categorie ricorrenti. In questo modo, sono stati individuati insulti concernenti la mancanza di competenza intellettuale (“idiota”), di capacità sociali (“asociale”) e di moralità (“disonesto”).
A conferma del maggior peso della moralità nel giudizio sociale, uno studio successivo di Rubini e Albarello (2012) ha evidenziato che gli insulti di tipo morale sono nel complesso percepiti come più severi, seguiti da quelli di competenza e infine di socievolezza. Anche in questo studio, è emersa una differenziazione di genere, dovuta tuttavia al target a cui sono indirizzati gli insulti: quando il target è un uomo, infatti, gli insulti di moralità sono percepiti come più gravi rispetto a quelli relativi alle altre due categorie, mentre i termini denotanti assenza di moralità e di competenza sono risultati ugualmente offensivi quando il target è femminile.In linea con la letteratura sul primato della moralità nel giudizio sociale (Ellemers et al., 2013), i risultati ottenuti da Rubini e Albarello (2011) mostrano come gli epiteti relativi alla mancanza di moralità siano in generale i più frequenti, seguiti da quelli concernenti le capacità intellettive, mentre gli insulti centrati sulla mancanza di socievolezza sono meno citati. E’ importante notare, inoltre, che gli insulti relativi alla mancanza di moralità risultano i più articolati, in quanto fanno riferimento a diversi tipi di comportamento attribuiti al target degli insulti stessi o a persone a lui vicine. Nello specifico, Rubini e Albarello (2011) hanno distinto tra insulti relativi alla moralità sessuale (“troia”), insulti che riflettono un’attribuzione di caratteristiche sessuali (“testa di cazzo”), epiteti che mettono in discussione la moralità delle persone vicine al target (“figlio di puttana”) e insulti che accusano il target di appartenere a un gruppo sociale valutato negativamente (“fascista”). Infine, un’ulteriore categoria riguarda la mancanza di moralità in ambito “pubblico” (“traditore”). Considerando queste sotto-dimensioni di moralità, i termini più frequenti sono quelli relativi alla moralità sessuale ed all’attribuzione di caratteristiche sessuali, seguiti dagli insulti centrati sulla moralità pubblica. Rubini e Albarello (2011) riportano inoltre alcune differenze di genere, dovute al maggiore uso di insulti di tipo morale e legati alla sessualità da parte dei maschi.
Nel complesso, gli studi di Rubini e Albarello (2011, 2012) dimostrano come il linguaggio costituisca un mezzo privilegiato per la trasmissione di giudizi sociali sulle tre dimensioni fondamentali individuate in letteratura – moralità, socievolezza e competenza (Leach et al., 2007; vedi anche Fiske et al., 2002) – evidenziando allo stesso tempo il ruolo primario della dimensione di moralità nella svalutazione dell’altro. Inoltre, questi studi mettono in luce l’importanza di adottare un approccio multidimensionale allo studio della moralità. Gli insulti che Rubini e Albarello (2011) hanno classificato come appartenenti alla categoria di moralità pubblica sembrano richiamare, nel contenuto, la concettualizzazione di moralità relativa alla relazione tra individuo e gruppo proposta da Leach et al. (2007). Tuttavia, l’analisi del linguaggio dispregiativo mostra chiaramente come attraverso gli insulti le persone tendano a ferire l’altro soprattutto chiamando in causa altre componenti di moralità, ed in particolare quella che Haidt e Graham ( 2007) definiscono “purezza” o “santità”. A questo proposito, è possibile affermare che i dati di Rubini e Albarello (2011) sono in linea con quanto riscontrato nella ricerca interculturale di van Oudenhoven et al. (2008) circa la pervasività e la connotazione di taboo proprie dei termini dispregiativi di tipo sessuale. Ulteriori ricerche focalizzate sui contesti di utilizzo di diversi tipi di insulti – attraverso la considerazione di fattori quali il genere del parlante e del target degli epiteti, la loro appartenenza di gruppo, ecc. – permetteranno da un lato di specificare ulteriormente le dimensioni di giudizio utilizzate nel linguaggio dispregiativo, dall’altro di approfondire le implicazioni psicologiche del linguaggio dispregiativo e la sua funzione nella regolazione dei rapporti tra le persone.
Glossario
Giudici indipendenti. Persone esperte sul tema oggetto di indagine e all’oscuro delle ipotesi di ricerca e delle condizioni sperimentali, la cui attività consiste nel codificare o valutare le risposte dei partecipanti ad un determinato compito.
Sviluppo cognitivo. Riguarda il modo in cui si sviluppano le capacità del bambino di pensare e comprendere il mondo fisico e sociale.
Sviluppo morale. Riguarda la nascita e lo sviluppo del concetto di moralità dall’infanzia all’età adulta.
Teoria dei Fondamenti Morali. Secondo questa teoria i valori morali si basano su fondamenti innati e universali, che però rivestono un’importanza diversa in culture diverse. La teoria riconosce cinque principali fondamenti che riguardano: Prendersi cura vs. Fare del male, Onestà vs. Disonestà; Lealtà vs. Tradimento; Autorità vs. Sovversione; Santità vs. Degradazione.
Bibliografia
Brambilla, M., Rusconi, P., Sacchi, S., & Cherubini, P. (2011). Looking for honesty: The primary role of morality (vs. sociability and competence) in information gathering. European Journal of Social Psychology, 41, 135-143.
Brambilla, M., Sacchi, S., Rusconi, P., Cherubini, P., & Yzerbyt, V. Y. (2011). You want to give a good impression? Be honest! Moral traits dominate group impression formation. British Journal of Social Psychology, 51, 149-166.
Brambilla, M., Sacchi, S., Pagliaro, S., & Ellemers, N. (2013). Morality and intergroup relations: Threats to safety and group image predict the desire to interact with outgroup and ingroup members. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 811-821.
Ellemers, N., Pagliaro, S., & Barreto, M. (2013). Morality and behavioural regulation in groups: A social identity approach. European Review of Social Psychology, 24, 160-193.
Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11, 77-83.
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s develompment. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 366-385.
Graham, J., Haidt, J., Koleva, S., Motyl, M., Iyer, R., Wojcik, S., & Ditto, P. H. (2013). Moral foundations theory: The pragmatic validity of moral pluralism. Advances in Experimental Social Psychology, 47, 55–130.
Haidt, J. (2008). Morality. Perspectives on Psychological Science, 3, 65-72.
Haidt, J., & Graham, J. (2007). When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research, 20, 98-116.
Haslam, N., Loughnan, S., & Sun, P. (2011). Beastly: What makes animal metaphors offensive? Journal of Language and Social Psychology, 30, 311-325.
Hofstede, G. (1980). Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage.
Hofstede, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.
Kohlberg, L. (1969). Stage and sequence: The cognitive-developmental approach to socialization. In D. A. Goslin (Ed.), Handbook of socialization theory and research (pp. 347-480). Chicago, IL: Rand McNally.
Leach, C. W., Ellemers, N., & Barreto, M. (2007). Group virtue: The importance of morality (vs. competence and sociability) in the positive evaluation of in-groups. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 234 - 249.
Leach, E. (1964). Anthropological aspects of language: Animal categories and verbal abuse. In E. H.Lenneberg (Ed.), New directions in the study of language (pp. 23-63). Cambridge, MA: MIT Press.
Loughnan, S., & Haslam, N. (2007). Animals and androids: Implicit associations between social categories and nonhumans. Psychological Science, 18, 116-121.
Piaget, J. (1932). Le jugement moral chez l'enfant. Paris: PUF.
Rodriguez Mosquera, P. M., Manstead, A. S. R., & Fischer, A. H. (2002). Honor in the Mediterranean and Northern Europe. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33, 16-36.
Rubini, M., & Albarello, F. (2011, July). Denying the fundamental components of others by verbal abuse. XVI General Meeting of the EASP, Stockholm, Sweden.
Rubini, M., & Albarello, F. (2012, September). Furbetti e disonesti! La negazione della moralità degli altri attraverso gli insulti verbali. XI Congresso Nazionale AIP, Chieti.
Schneider, J., & Schneider, P. (1976). Culture and political economy in western Sicily: Studies in social discontinuity. New York: Academic Press.
Semin, G. R., & Rubini, M. (1990). Unfolding the concept of person by verbal abuse. European Journal of Social Psychology, 20, 463-474.
Triandis, H.C. (1988). Collectivism vs. individualism: A reconceptualization of a basic concept in cross-cultural psychology. In C. Bagley e C.K. Verma (Eds.) Cross-cultural studies of personality, attitudes and cognition (pp. 60-95). London: Macmillan.
Van Oudenhoven, J. P., de Raad, B., Askevis-Leherpeux, F. Boski, P., Brunborg, G.S., Carmona, et… Woods, S. (2008). Terms of abuse as expression and reinforcement of cultures. International Journal of Intercultural Relations, 32, 174-185.
Viki, G. T., Winchester, L., Titshall, L., Chisango, T., Pina, A. & Russell, R. (2006). Beyond secondary emotions: The infrahumanization of outgroups using human-related and animal-related words. Social Cognition, 24, 753-775.
Wojciszke, B. (2005). Morality and competence in person- and self-perception. European Review of Social Psychology, 16, 155 - 188.