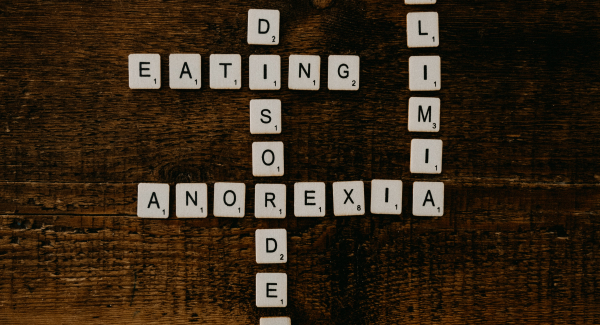Secondo un report pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Marzo 2022), nel primo anno della pandemia di COVID-19 si sarebbe verificato un aumento importante nella prevalenza globale dei disturbi d’ansia (+25.6%) e della depressione maggiore (+27.6%; vedi glossario). Il confronto è stato effettuato con gli anni precedenti alla pandemia, ed il fenomeno è ancora oggetto di studi e verifiche da parte dei ricercatori e delle ricercatrici in tutto il mondo, che hanno formato un gruppo dedicato, chiamato “COVID-19 Mental Disorders Collaborators”. Anche in Italia si sarebbe verificato questo fenomeno. Nello specifico, è stato riportato che, confrontando i dati raccolti nel corso del 2020 con quelli provenienti sia dal periodo immediatamente precedente all’inizio della pandemia sia dal biennio 2018-2019, si sarebbe verificato un aumento dei sintomi depressivi soprattutto nelle donne, nelle persone giovani, e nelle persone in difficoltà economica (Gigantesco et al., 2022; si veda anche Medda et al., 2022). Questi dati si accompagnano a quelli provenienti da studi condotti e pubblicati prima della pandemia, e che suggerivano già allora una tendenza all’aumento dei casi e delle richieste di trattamento per disturbi psicologici (Olfson et al., 2015; Lipson et al., 2019; Rehm & Shield, 2019), aumento in parte dovuto anche all’incremento globale della popolazione, nonché al miglioramento delle capacità diagnostiche e alla diminuzione dello stigma nei confronti del disagio psicologico (Baxter et al., 2014). Nel loro complesso, quindi, si tratta di dati che hanno senz’altro contribuito a una maggiore attenzione da parte di scienziati/e e istituzioni alla salute mentale. Facendo di nuovo riferimento al contesto italiano, nel 2022 sono stati ultimati i lavori della Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione, un’importante iniziativa costituita nel 2016 e che potrà contribuire al miglioramento delle politiche nel campo della salute mentale in Italia. Sempre nel 2022, in Italia è stato previsto il cosiddetto ‘Bonus Psicologo’, ossia un contributo messo a disposizione dallo Stato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Si tratta sicuramente di risposte molto importanti, soprattutto se si considerano le potenziali conseguenze che disturbi d’ansia e depressione, non adeguatamente trattati, potrebbero avere sulla salute degli individui, sia nell’immediato sia nel lungo termine. Una di queste conseguenze, secondo evidenze recenti, sembrerebbe essere l’aumento del rischio di sviluppo di demenza (vedi glossario) nell’età senile. Per demenza intendiamo quella condizione patologica caratterizzata da una progressiva perdita della funzionalità del cervello, delle funzioni cognitive e dell’autonomia della persona. Quando si parla di demenza, spesso si pensa alla malattia di Alzheimer, ossia a una patologia neurodegenerativa che rappresenta la prima causa di demenza oggigiorno. Tuttavia, esistono altre patologie che sono associate all’insorgenza di demenza, come ad esempio le alterazioni del sistema circolatorio cerebrale (demenza vascolare, vedi glossario), e la malattia a corpi di Lewy, caratterizzata dall’accumulo anomalo di corpi proteici che danneggiano le cellule cerebrali. Ad oggi, secondo l’OMS, nel mondo più di 55 milioni di persone soffrono di demenza. Inoltre, le stime attuali prevedono un incremento importante dei casi, con più di 130 milioni di persone affette da demenza entro il 2050 (Nichols et al., 2022; Sengoku, 2020;). Purtroppo, si tratta di una patologia ancora priva di una cura efficace, e che è, quindi, oggetto di moltissimi studi in tutto il mondo. Questi studi vengono infatti condotti con l’obiettivo di comprendere a pieno i meccanismi patologici che causano la demenza, con lo scopo di sviluppare un trattamento efficace in grado di arrestarla, nonché di individuare possibili strategie preventive. Grazie a questi studi oggi sappiamo che esistono numerosi fattori di rischio modificabili per lo sviluppo di demenza, ossia delle condizioni che ne possono aumentare la probabilità, ma su cui, al contempo, noi possiamo agire. In un recente studio pubblicato sulla rivista The Lancet, una commissione di ricercatori formatasi per studiare i meccanismi di prevenzione, intervento e cura della demenza, ha elencato una lista di ben 12 fattori di rischio modificabili per la demenza (Livingston et al., 2020). Questi fattori di rischio, secondo gli autori, sarebbero responsabili del 40% dei casi di demenza. Ciò vuol dire che, se si potessero eliminare tutti e 12, quasi la metà dei casi di demenza potrebbe essere evitata. Tra questi, insieme a ipertensione, obesità, alcol, fumo, diabete, inquinamento dell’aria, trauma cranico, perdita dell’udito, inattività fisica, basso livello di scolarità, isolamento sociale, è stata inserita la depressione (Livingston et al., 2020). Come si può vedere dall’elenco, si tratta di una lista che pone l’accento su diversi aspetti, tra cui emergono la salute fisica e quella psicologica. Secondo alcuni studiosi, il legame tra salute psicologica, soprattutto depressione, e demenza, è stato relativamente sottovalutato (Dafsari & Jessen, 2020), ed è quindi per questo che il presente articolo vuole prenderlo in esame, al fine di sensibilizzare i lettori e le lettrici all’adozione di uno stile di vita in cui la salute psicologica venga considerata importante tanto quanto quella fisica, fin dalla giovane età. Infatti, prima di descrivere i meccanismi biologici che legano depressione e demenza, è bene sottolineare che, quando si parla di depressione come fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di demenza, si parla di depressione che si manifesta in ‘giovane età’, ossia prima dei 60 anni.
Inoltre, si parla di una depressione caratterizzata da una sintomatologia grave e ricorrente, ossia che si ripresenta più volte nel corso del tempo (Byers & Yaffe, 2011; Cantón-Habas et al., 2020; Kuring et al., 2020; Yu et al., 2020). Infatti, dopo i 60 anni di età, un disturbo depressivo spesso può rappresentare un cosiddetto ‘prodromo’, ossia un sintomo precoce della demenza stessa, che sia essa causata da una malattia neurodegenerativa come quella di Alzheimer, o che sia essa causata da un danneggiamento del sistema circolatorio cerebrale, come accade nella demenza vascolare (Bennett & Thomas, 2014). Ma quali sono i motivi per cui la depressione aumenterebbe il rischio di sviluppare demenza? Ad oggi gli studi suggeriscono che la depressione sia associata a una serie di meccanismi neurobiologici che aumenterebbero il rischio di sviluppare patologie del sistema nervoso centrale che causano demenza (Jamieson et al., 2019). Uno di questi meccanismi è l’aumento dei livelli di glucocorticoidi, ossia di alcuni ormoni steroidei, tra cui il famoso cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Nella depressione, questa disregolazione ormonale avrebbe un impatto su tutto il sistema dell’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, ossia il nostro sistema di risposta allo stress, e sarebbe legata ad effetti nocivi per il cervello, specialmente per l’ippocampo, una delle strutture cerebrali coinvolte nei processi di memoria. Uno dei danni principali è l’atrofia (vedi glossario), ossia la perdita di volume, poiché è associata allo sviluppo di disturbi cognitivi, e conseguentemente di demenza (Dafsari & Jessen, 2020; Ouanes & Popp, 2019). Il meccanismo che lega l’alterazione dei livelli di glucocorticoidi all’atrofia di alcune strutture cerebrali sembrerebbe risiedere in un’alterazione nella produzione di alcune proteine molto importanti per il nostro cervello, ossia le neurotrofine (vedi glossario). Si tratta di sostanze essenziali per il nostro cervello, in quanto consentono la crescita di nuove cellule, la cosiddetta neurogenesi (vedi glossario), e la neuroplasticità (vedi glossario), ossia la capacità del nostro sistema nervoso di adattarsi e di modificarsi nel corso della vita. Altro meccanismo che può spiegare il legame tra depressione e demenza è l’aumento della risposta infiammatoria negli individui che soffrono di depressione (Miller & Raison, 2016). La risposta infiammatoria è una sorta di risposta di difesa che il nostro organismo mette in atto in condizioni di pericolo, ossia in presenza di lesioni, virus, batteri, e tutto ciò che può provocare malattia. Nello specifico, essa consiste in una serie di processi biologici e chimici, come la produzione di sostanze chiamate citochine infiammatorie, e l’attivazione cronica delle cellule gliali, ossia di quelle cellule che svolgono funzione nutritiva e di sostegno per i neuroni, e li proteggono in caso di lesioni. Queste risposte infiammatorie, laddove diventino croniche, sono state associate a una serie di altre modificazioni a livello cerebrale, come ad esempio la diminuzione di alcuni neurotrasmettitori come dopamina e serotonina, sostanze chimiche fondamentali nel mantenimento del tono dell’umore. Inoltre, sempre le risposte infiammatorie sono state associate a una diminuzione delle neutrofine e a neurodegenerazione, ossia progressiva perdita di funzionalità e morte delle cellule nervose. Aumento dei livelli di cortisolo, risposta infiammatoria e disregolazione dei neurotrasmettitori, sono stati inoltre associati alla comparsa di due caratteristiche patologiche della malattia di Alzheimer, ossia all’accumulo di beta-amiloide (vedi glossario) in placche, e all’aggregazione di proteina tau in cosiddette matasse neurofibrillari (Kinney et al., 2018). Infine, la risposta infiammatoria associata alla depressione è stata correlata anche a cambiamenti nel funzionamento dei vasi sanguigni. Il malfunzionamento del sistema circolatorio può avere importanti conseguenze a livello cerebrale, ad esempio provocando fenomeni di ipoperfusione cerebrale, ossia di diminuzione dell’apporto di sangue nel cervello (Daulatzai, 2017). Questi fenomeni, a loro volta, possono portare a diverse patologie, tra cui gli ictus ischemici, ossia interruzioni del flusso sanguigno con conseguente morte dei neuroni. Sebbene gli ictus si manifestino spesso in forma lieve, passando spesso inosservati, è la loro ripetizione nel tempo a
d essere associata allo sviluppo della cosiddetta demenza vascolare, o multifartuale (vedi glossario). Il legame tra sintomatologia depressiva, presenza di patologie a carico dei vasi sanguigni e demenza è ancora oggetto di studio, ma è importante ricordare come presenza di un disturbo depressivo sia spesso associata anche all’adozione di comportamenti poco salutari come abuso di alcool, fumo e scarsa attività fisica, e quindi allo sviluppo di patologie come obesità e diabete, tutti fattori di rischio essi stessi per lo sviluppo sia di patologie cerebrovascolari, che di demenza (Livingston et al., 2020). Questi comportamenti poco salutari vengono associati non solo alla depressione, ma anche ai disturbi d’ansia, i quali a loro volta sono considerati sia un prodromo (vedi glossario) sia dei fattori di rischio indipendenti per lo sviluppo di demenza (Gimson et al., 2018; Becker et al., 2018; Kuring et al., 2020). Riguardo i meccanismi che legano la presenza di disturbi d’ansia e demenza, ad oggi le conoscenze sono ancora limitate, e le ipotesi riguardano anche in questo caso la presenza di stati infiammatori e processi di invecchiamento cellulare accelerato, a sua volta legati a processi di minore neuroplasticità e di neurodegenerazione (Santabarbara et al., 2019). Nel complesso, sebbene si tratti di evidenze ancora recenti, e che richiedono quindi di essere confermate e
d affiancate da nuovi dati, esse forniscono un punto di partenza molto importante e promettente.
Esse, infatti, rappresentano senz’altro un importante passo avanti della ricerca psicologica e neuroscientifica, sia nell’ambito della depressione sia della demenza. Da un lato, infatti, hanno incrementato e stanno ancora aumentando le conoscenze riguardo i meccanismi biologici associati a disturbi come la depressione e l’ansia, e riguardo i loro effetti a lungo termine sulla salute cerebrale. Dall’altro, hanno posto l’attenzione sulla possibilità di prevenire e ritardare il più possibile l’insorgenza demenza agendo su fattori di rischio modificabili, ossia prendendosi cura della salute mentale, fin dalla giovane età.
Glossario
Atrofia: fenomeno caratterizzato dalla riduzione di volume di tessuti e organi.
Beta-amiloide: proteina ritenuta il principale componente dei depositi di amiloide osservabili sotto forma di ‘placche’ nei pazienti affetti da malattia di Alzheimer e sindrome di Down.
Demenza: condizione patologica caratterizzata dalla progressiva perdita delle funzioni cerebrali e che porta a un declino delle funzioni cognitive e dell’autonomia della persona.
Demenza vascolare: condizione patologica caratterizzata da una significativa diminuzione delle capacità cognitive in conseguenza della presenza di patologie legate al malfunzionamento del sistema circolatorio a livello cerebrale.
Depressione (maggiore): disturbo del tono dell’umore caratterizzato da sintomi come perdita di interesse verso le normali attività, pensieri negativi e pessimistici, aumento/perdita di peso, difficoltà cognitive e sintomi vegetativi come alterazione del sonno e dell’appetito.
Disturbo d’ansia (generalizzata): disturbo caratterizzato da ansia e preoccupazione eccessiva, e da sintomi come irrequietezza, tensione muscolare, difficoltà cognitive, alterazioni del sonno.
Fattore neurotrofico: proteina codificata dal gene BDNF (brain-derived neurotrophic factor), un membro della famiglia dei fattori di crescita delle neurotrofine.
Invecchiamento cellulare: processo tramite cui le cellule smettono di replicarsi e di svolgere efficientemente le loro funzioni.
Neurodegenerazione: processo cronico e selettivo di morte cellulare dei neuroni. Esempi di malattia neurodegenerative sono la malattia di Alzheimer e la malattia di Parkinson.
Neurogenesi: processo tramite il quale nuove cellule nervose si formano a partire da cellule immature, come le cellule staminali.
Neuroplasticità: capacità del sistema nervoso di adattare la propria struttura in risposta a stimoli interni o esterni, inclusi eventi patologici come traumi cranici o ictus.
Neurotrasmettitori: sostanze chimiche che trasmettono le informazioni tra le cellule del sistema nervoso.
Neurotrofine: proteine che determinano la sopravvivenza, lo sviluppo e la funzione dei neuroni.
Prodromo: manifestazione morbosa che precede l’insorgenza dei sintomi caratteristici di una malattia.
Bibliografia
Barca, M. L., Eldholm, R. S., Persson, K., Bjørkløf, G. H., Borza, T., Telenius, E., ... & Engedal, K. (2019). Cortisol levels among older people with and without depression and dementia. International Psychogeriatrics, 31(4), 597-601.
Baxter, A. J., Scott, K. M., Ferrari, A. J., Norman, R. E., Vos, T., & Whiteford, H. A. (2014). Challenging the myth of an “epidemic” of common mental disorders: trends in the global prevalence of anxiety and depression between 1990 and 2010. Depression and anxiety, 31(6), 506-516.
Becker, E., Rios, C. L. O., Lahmann, C., Ruecker, G., Bauer, J., & Boeker, M. (2018). Anxiety as a risk factor of Alzheimer's disease and vascular dementia. The British Journal of Psychiatry, 213(5), 654-660.
Bennett, S., & Thomas, A. J. (2014). Depression and dementia: cause, consequence or coincidence?. Maturitas, 79(2), 184-190.
Byers, A. L., & Yaffe, K. (2011). Depression and risk of developing dementia. Nature Reviews Neurology, 7(6), 323-331.
Cantón-Habas, V., Rich-Ruiz, M., Romero-Saldaña, M., & Carrera-González, M. D. P. (2020). Depression as a risk factor for dementia and Alzheimer’s disease. Biomedicines, 8(11), 457.
COVID-19 Mental Disorders Collaborators. Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Lancet. 2021; 398: 1700-1712
Dafsari, F. S., & Jessen, F. (2020). Depression—an underrecognized target for prevention of dementia in Alzheimer’s disease. Translational Psychiatry, 10(1), 160.
Daulatzai, M. A. (2017). Cerebral hypoperfusion and glucose hypometabolism: Key pathophysiological modulators promote neurodegeneration, cognitive impairment, and Alzheimer's disease. Journal of neuroscience research, 95(4), 943-972.
Ettman, C. K., Cohen, G. H., Abdalla, S. M., Trinquart, L., Castrucci, B. C., Bork, R. H., ... & Galea, S. (2022). Assets, stressors, and symptoms of persistent depression over the first year of the COVID-19 pandemic. Science Advances, 8(9), eabm9737.
Gigantesco, A., Minardi, V., Contoli, B., & Masocco, M. (2022). Depressive symptoms among adults in 2018–2019 and during the 2020 COVID-19 pandemic in Italy. Journal of affective disorders, 309, 1-8.
Gimson, A., Schlosser, M., Huntley, J. D., & Marchant, N. L. (2018). Support for midlife anxiety diagnosis as an independent risk factor for dementia: a systematic review. BMJ open, 8(4), e019399.
Han, L. K., Aghajani, M., Clark, S. L., Chan, R. F., Hattab, M. W., Shabalin, A. A., ... & Penninx, B. W. (2018). Epigenetic aging in major depressive disorder. American Journal of Psychiatry, 175(8), 774-782.
Istituto Superiore di Sanità. Consensus Conference sulle terapie psicologiche per ansia e depressione. Documento finale. Gruppo di lavoro “Consensus sulle terapie psicologiche per ansia e depressione” 2022, x, 105 p. Consensus ISS 1/2022
Jamieson, A., Goodwill, A. M., Termine, M., Campbell, S., & Szoeke, C. (2019). Depression related cerebral pathology and its relationship with cognitive functioning: A systematic review. Journal of affective disorders, 250, 410-418.
Kinney, J. W., Bemiller, S. M., Murtishaw, A. S., Leisgang, A. M., Salazar, A. M., & Lamb, B. T. (2018). Inflammation as a central mechanism in Alzheimer's disease. Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 4, 575-590.
Kuring, J. K., Mathias, J. L., & Ward, L. (2020). Risk of Dementia in persons who have previously experienced clinically-significant Depression, Anxiety, or PTSD: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Affective Disorders, 274, 247-261.
Lipson, S. K., Lattie, E. G., & Eisenberg, D. (2019). Increased rates of mental health service utilization by US college students: 10-year population-level trends (2007–2017). Psychiatric services, 70(1), 60-63.
Livingston, G., Huntley, J., Sommerlad, A., Ames, D., Ballard, C., Banerjee, S., ... & Mukadam, N. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet, 396(10248), 413-446.
Medda, E., Toccaceli, V., Gigantesco, A., Picardi, A., Fagnani, C., & Stazi, M. A. (2022). The COVID-19 pandemic in Italy: Depressive symptoms immediately before and after the first lockdown. Journal of affective disorders, 298, 202-208.
Mental Health and COVID-19: Early evidence of the pandemic’s impact: Scientific brief, World Health Organization, 2 March 2022
Miller, A. H., & Raison, C. L. (2016). The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. Nature reviews immunology, 16(1), 22-34.
Nichols, E., Steinmetz, J. D., Vollset, S. E., Fukutaki, K., Chalek, J., Abd-Allah, F., ... & Liu, X. (2022). Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet Public Health, 7(2), e105-e125.
Olfson, M., Druss, B. G., & Marcus, S. C. (2015). Trends in mental health care among children and adolescents. New England Journal of Medicine, 372(21), 2029-2038.
Ouanes, S., & Popp, J. (2019). High cortisol and the risk of dementia and Alzheimer’s disease: a review of the literature. Frontiers in aging neuroscience, 11, 43.
Rehm, J., & Shield, K. D. (2019). Global burden of disease and the impact of mental and addictive disorders. Current psychiatry reports, 21, 1-7.
Saczynski, J. S., Beiser, A., Seshadri, S., Auerbach, S., Wolf, P. A., & Au, R. (2010). Depressive symptoms and risk of dementia: the Framingham Heart Study. Neurology, 75(1), 35-41.
Santabárbara, J., Lipnicki, D. M., Villagrasa, B., Lobo, E., & Lopez-Anton, R. (2019). Anxiety and risk of dementia: Systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. Maturitas, 119, 14-20.
Santomauro, D. F., Herrera, A. M. M., Shadid, J., Zheng, P., Ashbaugh, C., Pigott, D. M., ... & Ferrari, A. J. (2021). Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic. The Lancet, 398(10312), 1700-1712.
Sengoku, R. (2020). Aging and Alzheimer's disease pathology. Neuropathology, 40(1), 22-29.
Yu, O. C., Jung, B., Go, H., Park, M., & Ha, I. H. (2020). Association between dementia and depression: a retrospective study using the Korean National Health Insurance Service-National Sample Cohort database. BMJ open, 10(10), e034924.
Foto di <a href="https://unsplash.com/de/@tjump?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&…">Nik Shuliahin </a> su <a href="https://unsplash.com/it/foto/BuNWp1bL0nc?utm_source=unsplash&utm_medium…">Unsplash</a>