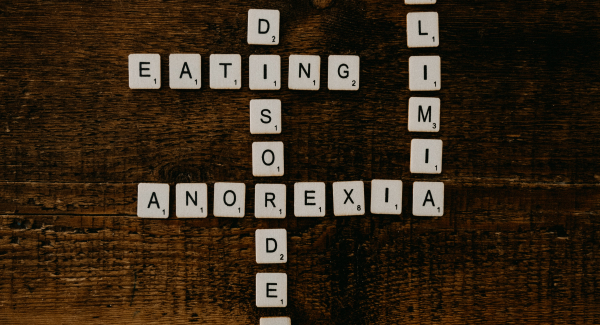Gli obiettivi di una Human Library (HL) sono molteplici: informare e sensibilizzare sulle tematiche connesse a stereotipi, pregiudizi e discriminazioni in una determinata realtà territoriale; educare alla realtà multiculturale, promuovendo l’accettazione e la convivenza; far vivere le diversità come valore aggiunto per le comunità locali. L’esperienza, oggi diffusa in tutto il mondo, è nata in Danimarca nel 1993, quando, dopo un fatto di cronaca a sfondo razzista, un gruppo di giovani creò l’associazione ‘Stop the Violence'. Da questo gruppo di cinque amici che si sono riuniti in risposta diretta all'episodio violento del 1993, nel 1995 il numero delle persone aderenti è cresciuto fino a circa 7.000 in tutta la Danimarca e, nel giro di pochi anni, ha raggiunto addirittura i 30.000 (The Stop the Violence Movement in Denmark; http://www.eycb.coe.int/domino/051.html). L’attivismo di questi/e giovani su temi come la non-violenza e l’antirazzismo si concretizzava attraverso l’organizzazione di eventi sociali, come concerti, conferenze tematiche, gruppi di discussione (Dreher & Mowbray, 2012). La prima Human Library ha rappresentato l’estensione di questo attivismo giovanile. Il primo evento è stato organizzato nel 2000 all’interno di un grande Festival in Danimarca (Roskilde Music Festival), coinvolgendo circa 75 Libri-Persona. Da allora molti eventi sono stati organizzati in tutto il mondo (6 continenti e 85 paesi, per maggiori informazioni, https://humanlibrary.org/) tra cui alcuni anche in Italia (Human Library Toscana - Associazione Culturale Pandora). La Human Library (HL; https://humanlibrary.org/) oggi compie 22 anni, eppure si tratta di un progetto-intervento ancora poco conosciuto nel contesto italiano, che si propone di contrastare stereotipi e pregiudizi sociali. L’idea è quella di una biblioteca vivente, dove i libri sono persone che raccontano le loro storie di stereotipi, pregiudizi e discriminazione, utilizzando un dialogo attivo basato sul rispetto e mostrando come la diversità sia un valore aggiunto e un arricchimento per la collettività (Little et al., 2011). Il Libro-Persona dopo un corso di formazione con gli organizzatori della HL sceglie il titolo che più rappresenta il proprio vissuto e che desidererebbe condividere durante l’esperienza con il Lettore/Lettrice. Solitamente viene utilizzato come titolo la categoria sociale (vedi glossario) con la quale la persona è stata definita e descritta dal contesto sociale, ad esempio “rom”, “immigrato”, “lesbica”, “rumena”. Durante l’evento HL, che si svolge in luoghi pubblici come le biblioteche, ma anche all’aperto in occasioni di festival o altri eventi, il Lettore/Lettrice, che può essere un passante, un frequentatore di biblioteche o un partecipante all’evento pubblico, viene invitato/a a scegliere il proprio titolo (solitamente si invita la persona a leggere una “storia sconosciuta” o di cui si hanno poche informazioni). Successivamente il Libro-Persona scelto viene preso in prestito per una lettura-conversazione in cui i Libri si raccontano e condividono le proprie esperienze e i propri vissuti emotivi in un faccia-a-faccia solo al termine del quale il Lettore/Lettrice potrà fare domande sulla trama/vita del Libro-Persona. A organizzare e turnare questi scambi tra persone appartenenti a contesti, culture ed esperienze differenti, c’è un/a conduttore/trice della HL, o bibliotecario/a, che è sempre presente nella sala lettura dove i Libri-Persona si raccontano, e si occupa della gestione di ogni sessione dall’inizio alla fine. Le HL sono state individuate come buone prassi per l’integrazione e la valorizzazione delle diversità da parte della European Commissions Directorate General for Freedom, Security and Justice. La stessa commissione, incoraggia, infatti, gli stati membri dell’UE, etc, incoraggiando gli Stati membri dell'UE a utilizzare questa metodologia e/o sostenere iniziative locali per l’organizzazione di eventi HL.
L’intervento della HL sembra essere in linea con le quattro condizioni illustrate da Allport (1954) come necessarie affinché il contatto intergruppi sia efficace nel miglioramento delle relazioni sociali nei contesti intergruppi. Secondo l’ipotesi del contatto intergruppi (Allport, 1954), infatti, è possibile ridurre il pregiudizio tra persone appartenenti a gruppi differenti (ad esempio, le persone eterosessuali e LGBTQ+, o le persone immigrate e native) favorendo le possibilità di un contatto reciproco di tipo non casuale tra esse. In particolare, il contatto dovrebbe: (a) essere frequente, o possibile nel futuro, (b) avvenire all’interno di un quadro di sostegno sociale e istituzionale, e (c) verificarsi tra persone appartenenti a gruppi differenti ma con uno status paritetico e con uno scopo comune, almeno durante l’incontro. Se queste quattro condizioni vengono soddisfatte è più probabile che si giunga a una significativa riduzione del pregiudizio tra le persone coinvolte. Studi successivi hanno dimostrato che anche in mancanza di alcune di queste condizioni cosiddette ottimali, il contatto intergruppi possa ugualmente favorire relazioni sociali armoniche e comportamenti intergruppi positivi (Pettigrew & Tropp, 2006). A partire dal lavoro di Allport, sono stati condotti numerosi studi sul contatto intergruppi che hanno permesso l’individuazione di elementi di efficacia del contatto, suggerendo che la riduzione del pregiudizio attraverso il contatto è più probabile se le persone che si trovano a interagire hanno un contatto volontario (Pettigrew et al., 2011), dispongono della concreta possibilità di disconfermare gli stereotipi durante l’interazione (Dixon & Rosenbaum, 2004), non possiedono livelli eccessivamente elevati di pregiudizio e/o non hanno numerose esperienze di contatto negativo con componenti dell’altro gruppo (McKeown & Dixon, 2017).
Questi elementi, in particolare, sottolineano il ruolo della HL come un intervento sul campo che richiama ed estende l’efficacia del contatto intergruppi. Al riguardo, la letteratura scientifica sottolinea l’urgente necessità di strutturare interventi sul campo volti a comprendere le modalità più efficaci di applicazione dell’ipotesi del contatto per contrastare il fenomeno della discriminazione nei confronti di vari gruppi e in diversi contesti (Paluck et al., 2019). Dunque l’intervento di HL può essere considerato una delle diverse specifiche applicazioni dell’ipotesi del contatto intergruppi. Una metanalisi di Lemmer e Wagner (2015) su altri interventi “fuori dal laboratorio” basati sul contatto diretto ne conferma l’efficacia nell’aumentare la conoscenza reciproca tra gruppi e nel ridurre pregiudizi e atteggiamenti negativi nei confronti di gruppi sociali stigmatizzati. Infatti, dalla letteratura più recente sappiamo che il contatto faccia-a-faccia tra gruppi risulta valido in diversi contesti, con popolazioni e target di pregiudizio vari. Ad esempio, vi sono recenti studi nazionali (e.g., Matera et al., 2021; Vezzali et al., 2015) e internazionali (e.g., Mousa, 2020; Petrick & Popper, 2020), condotti all’interno di contesti formativi con minori , che hanno dimostrato come il contatto diretto risulti efficace nel ridurre il pregiudizio nei confronti di persone con disabilità fisica, minoranze religiose ed etniche. Questi studi, così come avvenuto per altre forme di contatto diretto come il cooperative learning (Van Ryzin & Roseth, 2019), hanno messo in evidenza che il contatto intergruppi diretto e strutturato può in maniera precoce, anche attraverso un’aumentata empatia, attenuare l’utilizzo delle categorie sociali (Noi e Loro) che costituiscono la base del pregiudizio. Un interessante filone di studi si è focalizzato sul contatto diretto come possibile strategia per ridurre i conflitti interculturali radicati come quello in Israele tra la minoranza Araba e la maggioranza ebraica. Da questi studi (e.g., Halabi & Sonnenschein, 2004; Maoz, 2011) è emerso che le occasioni di contatto interpersonale (altamente strutturate), che propongono una comunicazione simmetrica e giusta, sono efficaci nel ridurre atteggiamenti negativi e pregiudizi nei confronti della minoranza. Inoltre, sempre nel contesto israeliano, è stato dimostrato che le occasioni di contatto migliorano le intenzioni future di contatto e aumentano l'empatia anche in gruppi caratterizzati da un’intensa storia conflittuale (ebrei e palestinesi) (Shani & Boehnke, 2017). Questi studi ci suggeriscono che il contatto diretto può promuovere il miglioramento delle relazioni anche tra gruppi sociali con un passato storico e attuale conflittuale. Analizzando le modalità di svolgimento di un evento HL, sono riscontrabili i prerequisiti citati da Allport (1954). Il contatto che ha luogo in queste occasioni è infatti supportato e organizzato da associazioni e istituzioni autorevoli per la cittadinanza. L’interazione ha una durata di 30 minuti e garantisce un approfondimento della conoscenza dell’altro e la costruzione di una relazione tra le persone. L’interazione è simmetrica, infatti i due individui coinvolti hanno solitamente status paritario e durante l’esperienza di contatto hanno pari responsabilità nel raggiungimento di uno scopo comune. Quest’ultimo, seppure con ‘responsabilità’ differenti per il Lettore/Lettrice e il Libro-Persona, consiste nella condivisione di un’esperienza personale per la cui realizzazione sono necessarie la partecipazione di ciascuna persona coinvolta nell’interazione e la percezione che i propri vissuti siano parte della comune esperienza umana.
Inoltre, il contatto intergruppi in HL coinvolge membri di gruppi stigmatizzati che sono disposti a condividere le loro esperienze, e quindi un contatto che fa leva sulla self-disclosure (la volontà della persona di condividere aspetti significativi di se stessoa; vedi Glossario) e la comprensione intima tra gli interlocutori/interlocutrici, queste due variabili in precedenti studi sono risultate importanti nel determinare l’efficacia del contatto nella riduzione del pregiudizio (e.g., Bagci et al., 2021; Marinucci et al., 2021). Infine, negli eventi HL, i Libri-Persona incarnano i rappresentanti tipici dei gruppi stigmatizzati aumentando così la salienza dell'appartenenza al gruppo, che è un importante facilitatore della generalizzazione degli effetti del contatto (secondary transfer effect, vedi glossario; Brown & Hewstone, 2005).
La Human Library sotto la lente della ricerca empirica
Negli ultimi anni sono stati sviluppati alcuni studi internazionali volti a dimostrare l’efficacia della HL come dispositivo di riduzione del pregiudizio intergruppi (Bagci & Blazhenkova, 2020). Orosz e colleghi (2016) si sono proposti di verificare l'efficacia dell'approccio della HL nel ridurre i pregiudizi nei confronti delle persone Rom e LGBT, gruppi minoritari oggetto di pregiudizio e stigmatizzazione nel contesto ungherese. Gli studiosi hanno ipotizzato che i partecipanti che interagivano con un ‘Libro’ Rom, successivamente alla lettura, avrebbero riportato livelli inferiori di pregiudizio, verso le persone Rom in generale; allo stesso modo i partecipanti che interagivano con un ‘Libro’ LGBT, dopo l’interazione, avrebbero riportato livelli inferiori di pregiudizio verso le persone LGBT. Il progetto-intervento prevedeva che i Lettori/Lettrici entrassero in contatto con Libri-Persone provenienti dalla comunità Rom e LGBT (precedentemente formati). Gli studenti e le studenti ungheresi partecipanti all’intervento dapprima compilavano un questionario contenente misure volte a rilevare il pregiudizio verso i gruppi stigmatizzati oggetto dell’intervento e successivamente erano liberi di scegliere, per la sessione di contatto, un ‘Libro’ appartenente a una comunità stigmatizzata (Rom, LGBT, homeless). Gli studenti e le studenti potevano porre ai ‘Libri’ qualsiasi domanda desiderassero e, rispondendo alle domande, i ‘Libri’ potevano condividere le loro storie ed esperienze di pregiudizio, discriminazione ed esclusione sociale. Subito dopo la conversazione, ai partecipanti e alle partecipanti veniva chiesto di compilare nuovamente un questionario con le misure di pregiudizio in relazione alle persone Rom e alle persone LGBT. Lo studio ha rivelato una riduzione della distanza sociale (vedi glossario), tra adolescenti e i membri dei due gruppi, nonché un atteggiamento più favorevoli nei confronti di entrambi i gruppi. I risultati, dunque, hanno fornito una preliminare evidenza relativa al fatto che l’intervento HL potrebbe essere utile nel ridurre i pregiudizi verso le persone Rom e le persone LGBT in un contesto sociale, come quello ungherese, in cui i pregiudizi verso questi gruppi sono salienti ed espliciti nel discorso pubblico. Tuttavia, uno dei limiti di questo studio è che gli effetti dell’intervento sono stati misurati immediatamente dopo l’esperienza HL, precludendo la possibilità di verificare i reali cambiamenti di atteggiamento dei Lettori/Lettrici nei confronti dei gruppi target nel tempo. Oltre a quanto messo sopra in evidenza, in uno studio condotto in Polonia (Groyecka et al., 2019), è stato indagato se partecipare a più sessioni di lettura con Libri-Persona differenti riducesse, in maniera persistente nel tempo, la distanza sociale verso le persone musulmane (una minoranza religiosa di recente presenza in Polonia) e omosessuali. I vari Libri-Persona dell’evento includevano appartenenti a minoranze religiose (persone musulmane, sia uomini sia donne, induiste, ebree), minoranze sessuali (persone omosessuali uomini e donne, transgender) e ulteriori categorie sociali stigmatizzate (persone vegane, rom, siriane, positive all’HIV, ex-alcoliste). I risultati hanno mostrato che la partecipazione all’evento HL ha modificato in modo significativo la distanza sociale delle persone polacche nei confronti dei musulmani rispetto ai dati registrati prima dell’evento. In particolare, nei partecipanti che avevano ‘letto’ più Libri-Persona, la riduzione della distanza sociale verso le persone musulmane era maggiore e tale riduzione era mantenuta al follow-up (vedi glossario). Il cambiamento di atteggiamento nei confronti delle persone omosessuali non è però risultato significativo, aprendo il dibattito sulla efficacia dell’intervento per alcuni gruppi sociali rispetto ad altri. Una spiegazione potrebbe riguardare il diverso livello di conoscenza e percezione di minaccia verso questi gruppi che possono essere attenuati da questo intervento (minore conoscenza e maggiore percezione di minaccia verso i musulmani rispetto agli omosessuali). Inoltre, le evidenze emerse sarebbero da monitorare in termini temporali (ossia, possono gli effetti benefici rilevati post-intervento durare a lungo?) e contestuali (ossia, come potrebbe essere strutturata una HL in quei paesi in cui convivono gruppi ad alta conflittualità?). Alcuni suggerimenti per fare fronte ai limiti riscontrati dai recenti studi (Groyecka et al., 2019; Orosz et al., 2016) potranno essere implementati in prossime ricerche-intervento.
Ad esempio, successivamente alle ‘letture’, potrebbero essere organizzate delle attività di collaborazione e cooperazione tra Libri e Lettori/Lettrici, oppure una modalità più indiretta per i potenziali effetti benefici del primo contatto tra Lettori/Lettrici e Libri potrebbe essere quella di organizzare all’interno del sito web/pagina dell’evento HL una sezione di forum di discussione dove i partecipanti possano approfondire la preliminare reciproca conoscenza. È possibile concludere che la HL può essere considerata una valida strategia di riduzione del pregiudizio in quanto rispondente alle condizioni ottimali delineati nella teoria del contatto intergruppi. La HL, infatti, svolgendosi in un contesto protetto, istituzionale, con persone ‘formate’ e diversificate in termini di target di pregiudizio potrebbe rappresentare un modo promettente e creativo per aumentare la tolleranza e l’inclusione verso le diversità, nonché per aumentare le conoscenze tra persone appartenenti a gruppi sociali differenti. Ci auguriamo quindi che questo articolo possa contribuire alla diffusione ed utilizzo di questo strumento per continuare nell’instancabile processo di miglioramento delle relazioni tra tutti i gruppi sociali che compongono il variegato gruppo umano.
Glossario
Categoria sociale: gruppo di persone definite dalla classe sociale o da altri attributi comuni di natura sociale, come genere, razza, status economico/lavorativo.
Self-disclosure: processo comunicativo attraverso il quale una persona rivela informazioni significative su sé stessa a un'altra.
Secondary transfer effect: generalizzazione degli effetti del contatto (ossia, la riduzione del pregiudizio) verso membri di outgroup diversi non direttamente coinvolti nell’esperienza contatto.
Distanza sociale: distanza percepita da un individuo o da un gruppo rispetto ad un altro, in particolare per quello che riguarda l'appartenenza a classi e strati sociali diversi o a differenti culture e subculture (etnia, religione, stili di vita, ecc.).
Follow-up: progetto di ricerca a lungo termine volto a esaminare il grado in cui gli effetti osservati dopo l’intervento persistono nel tempo.
Bibliografia
Allport, G.W. (1954). The Nature of Prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
Bagci, S. C., & Blazhenkova, O. (2020).
Unjudge someone: human library as a tool to reduce prejudice toward stigmatized group members. Basic and Applied Social Psychology, 42(6), 413-431. https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1792298
Bagci, S. C., Husnu, S., Turnuklu, A., & Tercan, M. (2021). Do I really want to engage in contact? Volition as a new dimension of intergroup contact. European Journal of Social Psychology, 51(2), 269-284. https://doi.org/10.1002/ejsp.2733
Brown, R., & Hewstone, M. (2005). An Integrative Theory of Intergroup Contact. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, Vol. 37, pp. 255–343). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(05)37005-5
Dreher, T. & Mowbray, J. (2012). The Power of One on One: Human Libraries and the Challenges of Antiracism Work. New South Wales: UTS Publishing.
Groyecka, A., Witkowska, M., Wróbel, M., Klamut, O., & Skrodzka, M. (2019). Challenge your stereotypes! Human Library and its impact on prejudice in Poland. Journal of Community & Applied Social Psychology, 29(4), 311-322. https://doi.org/10.1002/casp.2402
Lemmer, G., & Wagner, U. (2015). Can we really reduce ethnic prejudice outside the lab? A meta‐analysis of direct and indirect contact interventions. European Journal of Social Psychology, 45(2), 152-168. https://doi.org/10.1002/ejsp.2079
Maoz, I. (2011). Does contact work in protracted asymmetrical conflict? Appraising 20 years of reconciliation-aimed encounters between Israeli Jews and Palestinians. Journal of Peace Research, 48(1), 115-125. https://www.jstor.org/stable/29777473
Marinucci, M., Maunder, R., Sanchez, K., Thai, M., McKeown, S., Turner, R. N., & Stevenson, C. (2021). Intimate intergroup contact across the lifespan. Journal of Social Issues, 77(1), 64-85. https://doi.org/10.1111/josi.12399
Matera, C., Nerini, A., Di Gesto, C., Policardo, G. R., Maratia, F., Dalla Verde, S., ...
& Brown, R. (2021). Put yourself in my wheelchair: Perspective‐taking can reduce prejudice toward people with disabilities and other stigmatized groups. Journal of Applied Social Psychology, 51(3), 273-285. https://doi.org/10.1111/jasp.12734
McKeown, S., & Dixon, J. (2017). The “contact hypothesis”: Critical reflections and future directions. Social and Personality Psychology Compass, 11(1), e12295. https://doi.org/10.1111/spc3.12295
Orosz, G., Bánki, E., Bőthe, B., Tóth‐Király, I., & Tropp, L. R. (2016). Don't judge a living book by its cover: effectiveness of the living library intervention in reducing prejudice toward Roma and LGBT people. Journal of Applied Social Psychology, 46(9), 510-517. https://doi.org/10.1111/jasp.12379
Shani, M., & Boehnke, K. (2017). The effect of Jewish–Palestinian mixed-model encounters on readiness for contact and policy support. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 23(3), 219. https://doi.org/10.1037/pac0000220
Van Ryzin, M. J., & Roseth, C. J. (2019). Effects of cooperative learning on peer relations, empathy, and bullying in middle school. Aggressive Behavior, 45(6), 643-651. https://doi.org/10.1002/ab.21858
Vezzali, L., Stathi, S., Crisp, R. J., & Capozza, D. (2015). Comparing direct and imagined intergroup contact among children: Effects on outgroup stereotypes and helping intentions. International Journal of Intercultural Relations, 49, 46-53. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2015.06.009