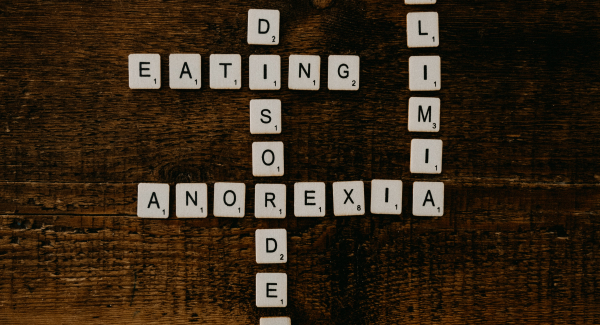“Mi spiace ma nella nostra struttura non è previsto accogliere pazienti di genere maschile…”
“Uno dei principali indici di malnutrizione, condizione cruciale per essere ricoverati, è lo stato amenorroico, ovvero l’interruzione del ciclo mestruale”.
Queste sono solo alcune delle frasi che un paziente di genere maschile affetto da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (di seguito riportati come “disturbi alimentari” o con la sigla DNA) può sentirsi rivolte proprio nei luoghi di cura ai quali ha chiesto aiuto.
Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5; APA, 2013) definisce i DNA come “caratterizzati da un persistente disturbo dell’alimentazione o di comportamenti collegati con l’alimentazione che determinano un alterato consumo o assorbimento di cibo e che danneggiano significativamente la salute fisica o il funzionamento psicosociale” (p. 379), suddividendoli in otto categorie diagnostiche, tra cui le più note: Anoressia Nervosa/AN, Bulimia Nervosa/BN, Disturbo da Alimentazione Incontrollata/DAI (si rimanda al glossario).
Nonostante negli ultimi trent’anni il dibattito scientifico attorno ai disturbi alimentari abbia visto rilevanti evoluzioni per quanto riguarda le questioni connesse al genere, come l’eliminazione del criterio relativo all’amenorrea (interruzione del ciclo mestruale) dal DSM-5 per la diagnosi di Anoressia Nervosa (Fries et al., 2013; Murray et al., 2017) e la crescente produzione di letteratura e attenzione clinica e mediatica sul tema, la questione rimane tuttavia ancora insidiosa: agli uomini non è concesso soffrire di DNA. Tanto meno, è concesso avere accesso – facilmente – alle cure appropriate.
I disturbi alimentari sono una cosa “da femmine”. Come le bambole, il rosa, la libertà di piangere, l’accudimento della prole e del focolare domestico.
Ma ne siamo proprio sicurɜ?
I disturbi alimentari: una piaga democratica e inclusiva
Storicamente le patologie alimentari sono state considerate, sia dall’opinione pubblica sia da gran parte di quella medico-clinica, esclusive del genere femminile (Ricciardelli, 2015). In particolare, della popolazione adolescente e giovane adulta, cisgender, eterosessuale, di etnia bianca, appartenente a classi sociali agiate (Cuzzolaro, 2014). Le radici di tale generalizzazione hanno origini piuttosto antiche: basti pensare all’associazione tra anoressia e disturbo isterico (Lasègue, 1873), o ancora al caso delle “Sante Anoressiche” descritto da Rudolph M. Bell (1985), solo per citare due degli esempi più esplicativi a riguardo. Tali radici si sono poi via via rafforzate nel corso dei decenni, esacerbate dalla cultura di massa che ha per lungo tempo rintracciato nei modelli proposti dal mondo della moda e dello spettacolo la fonte della diffusione dei DNA specialmente tra le adolescenti.
Solo negli ultimi anni si è cominciato ad abbracciare l’idea che questa classe di disturbi possa interessare la popolazione nella sua interezza, seppur con peculiarità e declinazioni differenti a seconda dell’intersecarsi di numerosi fattori, tra cui il genere, l’orientamento sessuale, l’età, solo per citarne alcuni (Spitoni, 2019). Questo è sorprendente, se si pensa che quella che viene diffusamente riconosciuta come la prima definizione clinica di Anoressia Nervosa (per opera di Richard Morton nel 1689, si veda il glossario) è basata sul resoconto di due pazienti - che in assenza di patologie organiche manifeste, rifiutavano di alimentarsi - di cui uno di genere maschile.
La diagnosi nella popolazione maschile: una realtà sottostimata
Perché, quindi, i DNA sono rimasti dominio di una psicopatologia tutta al femminile per secoli?
Uno dei motivi è sicuramente rintracciabile negli studi epidemiologici, che sottolineano una loro maggior prevalenza nella popolazione femminile con un rapporto tra i generi che si aggira attorno a 1:4 (Sweeting, 2015), con variazioni piuttosto consistenti a seconda del disturbo: da 1:3 a 1:10 per l’anoressia, da 1:3 a 1:12 per la bulimia, da 1:2 a 1:6 per il disturbo d’ alimentazione incontrollata (Darcy et al., 2011; Hudson et al. 2007). Se questa maggior prevalenza nel genere femminile è incontrovertibile, è altrettanto incontrovertibile che quella nella popolazione maschile abbia visto una rapida crescita negli ultimi anni (Ricciardelli, 2015) e sia destinata ad aumentare ulteriormente (Smink et al., 2012; Udo et al., 2018). Ciò è evidente specialmente se si considera la popolazione adolescente: all’interno di essa i tassi di prevalenza tra i generi risultano sempre più vicini, specialmente per quanto riguarda i disturbi dell’immagine corporea e i comportamenti alimentari disfunzionali non riconducibili a una specifica categoria diagnostica (Ackard et al., 2007; Strigel-Moore et al., 2009), come i DANAS/EDNOS o i DAAS/OSFED (si veda il glossario).
Inoltre, si evince in modo altrettanto evidente che i dati inerenti alla popolazione maschile potrebbero essere notevolmente sottostimati in virtù della minor propensione, motivata da stereotipi culturali e di genere, a riconoscere all’interno della suddetta popolazione problematiche inerenti all’alimentazione e alle forme corporee (Faravelli et al., 2006; Murray et al., 2017).
Questo è vero anche in riferimento agli strumenti e ai manuali diagnostici, a lungo costruiti sulla base dell’applicabilità alla sola popolazione femminile, alcuni dei quali considerano come necessari segni e sintomi il cui verificarsi nel genere maschile è biologicamente impossibile - come la sopracitata amenorrea - o diversamente interpretabile in base al genere - come l’Indice di Massa Corporeo (IMC, calcolabile secondo la formula (peso (kg))/(altezza^2 (mt))). Se infatti è vero che nel DSM-5 il criterio diagnostico relativo all’amenorrea è stato eliminato, è altrettanto vero che l’IMC è rimasto l’unico criterio preso in considerazione per valutare la gravità del disturbo anoressico, senza tenere in considerazione la differente morfologia del corpo maschile e di quello femminile. Ed è evidente come, a parità di IMC, una persona di genere maschile e una di genere femminile possano presentare stati psicofisici e di malnutrizione molto differenti tra loro, in virtù delle differenze genere-specifiche (Ricciardelli, 2015).
Ciò si configura come una questione di importanza cruciale, se si pensa che, nella gran parte delle strutture pubbliche dedicate al trattamento dei DNA, l’IMC è considerato come uno dei fattori principali nella valutazione della presa in carico e del relativo progetto di cura (De Virgilio et al., 2012).
La malpractice clinica: una popolazione in esilio
La mancata considerazione di queste specificità ha portato a rilevanti criticità nella pratica diagnostica e nell’implementazione di strategie efficaci e mirate da un punto di vista terapeutico: sottostimare casi con disturbi gravi, non rilevare manifestazioni subcliniche comunque associate a livelli significativi di compromissione o addirittura alla formulazione di diagnosi differenziali errate, come è spesso accaduto con la diagnosi di depressione (Jones et al., 2010). Nell’ambito del trattamento, quindi, solo di recente si è giunti alla strutturazione di piani d’intervento pensati tenendo conto delle manifestazioni genere-specifiche della sintomatologia (Darcy et al., 2011). Per molti anni numerose strutture residenziali e semiresidenziali dedicate al trattamento di queste patologie non hanno previsto la potenziale presa in carico di pazienti di genere maschile, in quanto la domanda non veniva percepita come un’urgenza sanitaria tale da motivare un ripensamento delle strutture o un investimento per adeguare il contesto sanitario alla loro accoglienza (Dalla Ragione et al., 2009; Murray et al., 2017). Ancora oggi, alcune di queste strutture hanno difficoltà a prendere in carico soggetti di genere maschile e/o non presentano protocolli d’intervento mirati che non si basino su prototipi sintomatologici femminili (Hoek et al., 2003; Murray et al., 2017). Questo ha contribuito al consolidarsi dello stigma legato all’essere un uomo con sintomi alimentari (Darcy et al, 2011; Harvey et al, 2003), che, a sua volta, contribuisce alla minore capacità, sia da parte del soggetto sia da parte dellɜ professionistɜ della salute mentale con cui entra in contatto, di riconoscere questi sintomi e quindi indirizzare l’individuo verso trattamenti adeguati (Jones et al., 2010).
Un ulteriore fattore culturale legato agli stereotipi di genere (si veda il glossario) concorre alla diagnosi inefficace dei DNA nella popolazione maschile: la comprovata maggior prevalenza di tale categoria di disturbi tra le minoranze sessuali (si veda il glossario) e il conseguente timore di vedere ipotizzata una presunta omosessualità, nei soggetti affetti da DNA che si rivolgono ai contesti di cura.
Spieghiamoci meglio.
Il mondo sommerso dei DNA nella popolazione maschile: gli stereotipi di genere
Per quanto riguarda la popolazione maschile, la letteratura evidenzia chiaramente una maggior prevalenza di sintomi alimentari nel sottogruppo omosessuale e bisessuale rispetto a quello eterosessuale. Questo è riscontrato in vari contesti di ricerca: da quello clinico (Ming et al., 2014), ai veterani di guerra (Bankoff et al., 2016), dagli studenti del college (Diemer et al., 2015; Matthews-Ewald et al., 2014), fino a campioni di studi randomizzati controllati (Austin et al., 2009; Bell et al., 2019; Kamody et al., 2019). In particolare, una ricerca di Feldman e Meyer (2010) ha mostrato che gli uomini gay e bisessuali rappresentano dal 14 al 42% della popolazione clinica affetta da disturbi alimentari, contro il 4% rappresentato dagli uomini eterosessuali. Evidenze coerenti sono riportate dallo studio di Kamody (2019), che sottolinea una prevalenza di diagnosi di DNA nel gruppo minoritario 1.9-3.6 volte superiore alla controparte eterosessuale, così come dallo studio di Austin (2009), che riscontra una percentuale di disturbi alimentari restrittivi pari al 6% tra gli uomini gay e bisessuali rispetto all’1% della popolazione eterosessuale maschile.
Ed è facilissimo accedere a tali evidenze, in virtù della solidità dei risultati: se si inserisce nei motori di ricerca “disturbi alimentari maschili”, già dai primi risultati emerge una forte associazione con la quesitone dell’orientamento sessuale. Ed è altrettanto noto a tuttɜ che, ricercare informazioni online è una delle prime attività a cui ci si dedica di fronte a una qualsiasi problematica.
Tra le possibili ricadute che queste evidenze e considerazioni possono avere sulla popolazione -clinica e non - ve ne sono alcune particolarmente significative da un punto di vista sia clinico sia socioculturale, di seguito approfondite.
Queste implicazioni hanno a che vedere con gli stereotipi di genere che permeano la società, i quali richiedono – più o meno violentemente - a tutti gli individui di aderire a una serie di norme per essere riconosciuti e considerati degni rappresentanti del proprio genere di appartenenza, sulla base di una matrice di stampo maschilista patriarcale -espressione della cultura dominante (Ellemers, 2018). Tale sistema di credenze, nel quale ogni individuo si ritrova immerso sin dalla nascita, seppur con gradienti differenti a seconda dei contesti di appartenenza, esige dal genere maschile una serie di caratteristiche, tra le quali la forza, la virilità, l’indipendenza, la rigidità, la razionalità, il non avere bisogno di aiuto. Al contrario, richiede al genere femminile attributi e attitudini quali la fragilità, la sensibilità, l’emotività, la malleabilità, la dipendenza e il bisogno di protezione, cura e sostegno (Ellemers, 2018).
Alla luce di tali considerazioni – e di molte altre per le quali si rimanda a “Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità” (Pacilli, 2020) –, è intuibile come gli stereotipi di genere suggeriscano una superiorità del maschile sul femminile, con la conseguenza che il maschile tema di sentirsi avvicinato all’altro genere, in quanto ciò comporterebbe una perdita di prestigio e, sostanzialmente, di valore e potere.
Applicando tali riflessioni al tema dei DNA, è ipotizzabile che un uomo eterosessuale affetto da tali disturbi possa sperimentare rilevanti difficoltà nel mostrarsi fragile e nel chiedere aiuto, per timore di veder messa in discussione la propria mascolinità - che, come ricordiamo, si basa sull’assunto che l’uomo debba essere forte e non debba avere bisogno di aiuto. Un po’ come succede ai bambini che provano vergogna per la predilezione di giochi, colori, dispositivi culturali stereotipicamente associati al genere femminile. O, ancora, come può succedere a un uomo che può temere di veder messo in discussione il proprio orientamento eterosessuale o la propria “mascolinità”, in virtù della maggior prevalenza di DNA nelle minoranze sessuali e degli annessi stereotipi organizzati attorno a tematiche omofobe... cosa c’è di peggio, in una società ancora fortemente organizzata attorno a una cultura machista patriarcale?
Allo stesso tempo, qualora un uomo gay si trovi immerso in dinamiche di omonegatività interiorizzata (si veda il glossario) e di conseguenza non sia riuscito a fare coming out (si veda il glossario), potrebbe avere difficoltà nel chiedere aiuto per il proprio disturbo alimentare. Potrebbe temere che il disturbo possa tradirlo, possa farlo uscire allo scoperto, con sé stesso e con l’interlocutore.
Queste, a mio avviso, sono ulteriori considerazioni che rendono centrale il tema della diagnosi dei DNA nella popolazione maschile e che contribuiscono alla sottostima di questi disturbi nella specifica popolazione, ipotizzata con forza dalla letteratura.
Concludendo, è corretto affermare che i disturbi alimentari siano ugualmente frequenti nei generi? No.
Oggettivamente la popolazione femminile risulta maggiormente esposta, rispetto a quella maschile. D’altra parte, è questo un motivo convincente per ignorare e sottovalutare i disturbi alimentari negli uomini? No.
La psicopatologia è una, è democratica e non fa discriminazioni in base al genere quando si tratta di provocare malessere. Forse è bene che anche l’approccio alle cure si orienti in questa direzione e, con esso, l’opinione pubblica.
Non esistono disturbi da maschi e disturbi da femmine. Esistono le persone, esistono le storie – a volte dolorose - e ogni storia merita di essere salvata.
Glossario
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DANAS, in base alla classificazione DSM-5): (a) pica; (b) disturbo da ruminazione; (c) disturbo Alimentare Evitante/Restrittivo dell’assunzione di cibo; (d) Anoressia Nervosa (AN); (e) bulimia Nervosa (BN); (f) disturbo da Alimentazione Incontrollata (DAI) / Disturbo da Binge-Eating (BED); (g) disturbo della Nutrizione o dell’Alimentazione con Altra Apecificazione (DAAS); (h) Disturbo della Nutrizione o dell’Alimentazione Senza Specificazione (DANAS) (per approfondire le singole categorie diagnostiche, si rimanda al Manuale).
Prima definizione clinica di Anoressia Nervosa: «il figlio del reverendo Steele, intorno al sedicesimo anno d'età, cadde gradualmente in un'assenza totale di appetito, (…), struggendosi via via sempre di più per due anni, (…). Perciò giudicai questa consunzione come nervosa, come cosa che avesse le sue radici nell'abito del suo corpo e sorgesse da una perturbazione del suo Sistema di Nervi»
(Citato in Silverman, 1995).
DANAS: la categoria “Disturbi Alimentari Non Altrimenti Specificati” (DSM-5) si applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un DNA, che causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i criteri per uno qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei DNA. Tale categoria DANAS è utilizzata in situazioni in cui il clinico sceglie di non comunicare la ragione specifica per cui la manifestazione non soddisfa i criteri per nessuno specifico DNA. Esempi di manifestazioni in questione possono verificarsi in contesti di pronto soccorso, dove non è possibile raccogliere informazioni sufficientemente approfondite tali da rendere impossibile porre una diagnosi più specifica.
DAAS: la categoria “Disturbi Alimentari con Altra Specificazione” (DSM-5) si applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un DNA, che causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i criteri per uno qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei DNA. Tale categoria DAAS è utilizzata in situazioni in cui il clinico sceglie di comunicare la ragione specifica per cui la manifestazione non soddisfa i criteri per nessuno specifico DNA. Esempi di manifestazioni che possono essere specificate con tale dicitura sono: (a) anoressia nervosa atipica; (b) bulimia nervosa (a bassa frequenza e/o di durata limitata); (c) disturbo da binge-eating (a bassa frequenza e/o di durata limitata); (d) disturbo da condotta di eliminazione; (e) sindrome da alimentazione notturna.
Minoranze sessuali: con tale termine si fa riferimento alla popolazione composta da individui omosessuali e/o bisessuali, indipendentemente dal genere, ma che comunque non si riconoscono nella maggioranza rappresentata dalla popolazione eterosessuale.
Stereotipi di genere: insieme rigido di credenze condivise e trasmesse socialmente, su quelli che sono e devono essere i comportamenti, i ruoli, le occupazioni, i tratti, l’apparenza fisica di una persona in relazione alla sua appartenenza di genere.
Omonegatività interiorizzata: definita anche “omofobia interiorizzata” o “stigma sessuale interiorizzato”, sta a indicare l’insieme di sentimenti e atteggiamenti negativi (dal disagio al disprezzo) che le stesse persone omosessuali possono provare (più o meno consapevolmente) nei confronti della propria (e altrui) omosessualità.
Coming out: termine anglosassone, ormai entrato nell’uso comune anche in italiano, indica il gesto volontario di rivelare il proprio orientamento sessuale alle altre persone.
Bibliografia
Ackard, D. M., Fulkerson, J. A., & Neumark-Sztainer, D. (2011). Stability of eating disorder diagnostic classifications in adolescents: five-year longitudinal findings from a population-based study. Eating disorders, 19(4), 308–322.
Austin, S. B., Ziyadeh, N. J., Corliss, H. L., Rosario, M., Wypij, D., Haines, J., Camargo, C. A., Jr, & Field, A. E. (2009). Sexual orientation disparities in purging and binge eating from early to late adolescence. The Journal of adolescent health: official publication of the Society for Adolescent Medicine, 45(3), 238–245.
Bankoff, S. M., Richards, L. K., Bartlett, B., Wolf, E. J., & Mitchell, K. S. (2016). Examining weight and eating behavior by sexual orientation in a sample of male veterans. Comprehensive psychiatry, 68, 134–139.
Bell, R. M. (1985). Holy anorexia. University of Chicago Press.
Bell, K., Rieger, E., & Hirsch, J. K. (2019). Eating Disorder Symptoms and Proneness in Gay Men, Lesbian Women, and Transgender and Non-conforming Adults: Comparative Levels and a Proposed Mediational Model. Frontiers in psychology, 9, 2692.
Cuzzolaro M. (2014). Anoressie e bulimie. Il Mulino.
Dalla Ragione L., Scoppetta M. (2009). Giganti d’argilla. I disturbi alimentari maschili. Il pensiero scientifico editore.
Darcy M. A. (2011). Eating Disorders in Adolescent Males: A Critical Examination of Five Common Assumptions. Adolescent Psychiatry, 1(4), 307-312.
De Virgilio G., Coclite D., Napoletano A., Barbina D., Dalla Ragione L., Spera G., Di Fiandra T. (2013). Conferenza di consenso sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) negli adolescenti e nei giovani adulti. Roma: Istituto Superiore di Sanità. Rapporti ISTISAN 13/6.
Diemer, Elizabeth W. et al. (2015). Gender Identity, Sexual Orientation, and Eating-Related Pathology in a National Sample of College Students. Journal of Adolescent Health, 57(2), 144 – 149.
Ellemers, N. (2018). Gender stereotypes. Annual Review of Psychology, 69, 275–298.
Faravelli, C., Ravaldi, C., Truglia, E., Zucchi, T., Cosci, F., & Ricca, V. (2006). Clinical epidemiology of eating disorders: results from the Sesto Fiorentino study. Psychotherapy and Psychosomatics, 75(6), 376-383.
Feldman, M. B., & Meyer, I. H. (2010). Comorbidity and age of onset of eating disorders in gay men, lesbians, and bisexuals. Psychiatry research, 180(2-3), 126–131.
Fries, J., & Sullivan, V. (Eds.). (2017). Eating Disorders in Special Populations: Medical, Nutritional, and Psychological Treatments. CRC Press.
Harvey, J.A., Robinson, J.D. (2003). Eating Disorders in Men: Current Considerations. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 10, 297–306.
Hoek, H. W., & Van Hoeken, D. (2003). Review of the prevalence and incidence of eating disorders. International Journal of eating disorders, 34(4), 383-396.
Hudson, J. I., Hiripi, E., Pope Jr, H. G., & Kessler, R. C. (2007). The prevalence and correlates of eating disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Biological psychiatry, 61(3), 348-358.
Jones, W. R., & Morgan, J. F. (2010). Eating disorders in men: A review of the literature. Journal of Public Mental Health, 9(2), 23-31.
Kamody, R. C., Grilo, C. M., & Udo, T. (2020). Disparities in DSM‐5 defined eating disorders by sexual orientation among US adults. International Journal of Eating Disorders, 53(2), 278-287.
Lasègue E.C. (1873). On hysterical anorexia. Medical Times and Gazette, 2, 265-266.
Lingiardi, V., Baiocco, R., & Nardelli, N. (2012). Measure of internalized sexual stigma for lesbians and gay men: A new scale. Journal of Homosexuality, 59(8), 1191-1210.
Lingiardi, V., & Nardelli, N. (2014). Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali. Raffaello Cortina.
Matthews-Ewald, M. R., Zullig, K. J., & Ward, R. M. (2014). Sexual orientation and disordered eating behaviors among self-identified male and female college students. Eating Behaviors, 15(3), 441-444.
Ming, T. S., Shan, P. L. M., Cen, A. K. S., Lian, L. E., & Kim, E. B. S. (2013). Men do get it: eating disorders in males from an Asian perspective. ASEAN Journal of Psychiatry, 15(1), 72-82.
Murray, S. B., Rieger, E., Hildebrandt, T., Karlov, L., Russell, J., Boon, E., Dawson, R. T., & Touyz, S. W. (2012). A comparison of eating, exercise, shape, and weight related symptomatology in males with muscle dysmorphia and anorexia nervosa. Body image, 9(2), 193–200.
Murray, H. B., & Robb, A. S. (2017). Eating Disorders in Males. Eating Disorders in Special Populations,233-246).
Pacilli M. G. (2020). Uomini duri. Il lato oscuro della mascolinità. Il Mulino.
Ricciardelli, L., & McCabe, M. (2015). Eating disorders in boys and men. The Wiley handbook of eating disorders, 492-506.
Silverman J. A. (1689). History of Anorexia Nervosa. In: Brownell K.D., Fairburn C. J. G. (1995). “Eating Disorders and Obesity. A comprehensive handbook”. The Guilford Press, 25, 41-44.
Smink, F. R., van Hoeken, D., & Hoek, H. W. (2012). Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Current psychiatry reports, 14(4), 406–414.
Spitoni G.F. (2019). “Manuale dei disturbi alimentari”. Carocci editore.
Striegel-Moore, R. H., Rosselli, F., Perrin, N., DeBar, L., Wilson, G. T., May, A., & Kraemer, H. C. (2009). Gender difference in the prevalence of eating disorder symptoms. The International journal of eating disorders, 42(5), 471–474.
Sweeting, H., Walker, L., MacLean, A., Patterson, C., Räisänen, U., & Hunt, K. (2015). Prevalence of eating disorders in males: a review of rates reported in academic research and UK mass media. International journal of men's health, 14(2).
Ph autore del contributo by Ilaria Elena Borin per il Progetto 'I 1000 volti DCA'.
Ph by Photo by <a href="https://unsplash.com/@anniespratt?utm_source=unsplash&utm_medium=referr…">Annie Spratt</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/anorexic?utm_source=unsplash&utm_medium=r…">Unsplash</a>