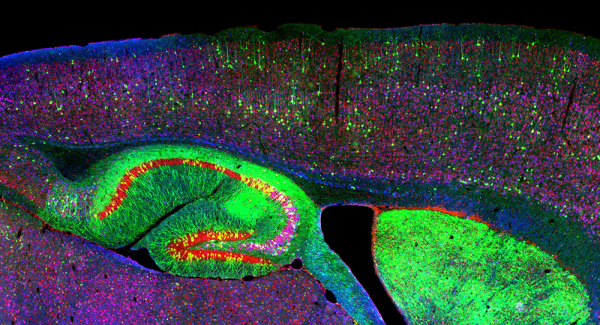Research funding: Il presente lavoro rientra nell’ambito del progetto PRIN (2012)-20123X2PXT_003.
“I personaggi femminili dei videogiochi vengono oggettivati sessualmente e sono pensati e disegnati al solo scopo di eccitare i giocatori. Ma non solo. In molti titoli la donna diventa oggetto di stupro, quasi a glorificare la sopraffazione maschile sulla donna”
Anita Sarkeesian, fondatrice di Feminist Frequency
Recentemente la classe politica ha rivolto la propria attenzione a quella che la quasi totalità dei gruppi parlamentari ha considerato come una vera emergenza: il digital divide fra genitori e figli (si veda glossario). A differenza di quanto si possa immaginare, ciò che desta preoccupazione non è tanto la distanza fra genitori e figli nell’utilizzo delle nuove tecnologie, quanto il fatto che i genitori spesso ignorano cosa accade quando i figli giocano con un videogame. I tempi dei mattoncini di Tetris sono ormai lontani, non è raro infatti che i videogiochi moderni siano ambientati in sobborghi metropolitani caratterizzati da comportamenti aggressivi e immorali e in cui le donne sono spesso rappresentate come oggetti da sfruttare sessualmente e bersaglio preferito di violenza.
Il mercato dei videogiochi è oggi in costante e continua espansione, con un pubblico sempre più ampio e differenziato. Statistiche a livello mondiale mostrano infatti come il divario fra utenti di genere maschile e femminile si sia enormemente assottigliato negli ultimi 20 anni (Entertainment Software Association, 2010). Da un rapporto ISFE del 2012 sul consumo dei videogiochi in Europa, emerge infatti che ben il 43% dei videogiocatori sono di genere femminile (ISFE, 2012). Negli Stati Uniti le percentuali sono ancora più marcate: oltre il 48% delle donne sono infatti giocatrici assidue; nel Regno Unito e in Spagna, le donne costituiscono, rispettivamente, il 52% e il 48% dell’utenza complessiva (Entertainment Software Association, 2010). Tuttavia l’opinione più comunemente diffusa è che i videogames siano ancora un passatempo prettamente maschile. Nonostante queste evidenze, lo sviluppo dei videogiochi persiste nel considerare come target di riferimento solo il pubblico maschile: il cambiamento avvenuto nell’audience dei consumatori di prodotti videoludici non rispecchia infatti un cambiamento nei contenuti che questi propongono. La rappresentazione femminile nell’universo dei videogiochi è rimasta invariata negli ultimi 25 anni. Ad oggi, solo il 15% dei personaggi dei 25 titoli più venduti è di genere femminile (Gittleson, 2014).
Secondo la Electronic Entertainment Design and Research, che nel 2012 ha analizzato un campione di 669 videogiochi, solo 24 presentavano una protagonista femminile. Da uno studio di Downs e Smith (2010), che analizza i personaggi dei videogiochi più venduti a livello mondiale, emergono risultati sconcertanti: tra i personaggi analizzati nei 60 videogiochi più venduti in America, l’86% sono di genere maschile e solo il 14% femminile. Inoltre, la figura femminile nei video games non solo viene sotto rappresentata ma viene anche raffigurata in modo selettivo. Molto spesso i personaggi di gioco di genere femminile sono personaggi secondari, dei quali quasi la metà ricopre il ruolo di oggetto decorativo, che non interagisce con il giocatore e che viene rappresentato in maniera stereotipata (Heintz-Knowles & Henderson, 2001). Il corpo della donna è irrealistico e iper-sessualizzato: il petto è generalmente molto accentuato, la vita molto stretta, la figura longilinea e magra (Downs & Smith, 2010). La percentuale di personaggi femminili rappresentati in maniera sessualizzata (si veda glossario) supera di molto quella dei personaggi maschili – il 41% contro l’11% (Downs & Smith, 2010) – il che costituisce un potente contributo al rafforzamento degli stereotipi di genere e alla diffusione dell’immagine femminile come oggetto sessuale.
La rappresentazione selettiva e la sotto-rappresentazione della figura femminile identificano due strategie differenti spesso presenti nel linguaggio mediatico, attraverso cui viene rinforzata una visione stereotipica degli uomini e delle donne. Nel mondo virtuale dei videogiochi tali strategie risultano particolarmente marcate e tendono molto spesso a convergere. Questi aspetti sono ancora più rilevanti se si considera il ruolo fondamentale che i media hanno nella diffusione e nell’apprendimento degli stereotipi. Come mostrato da recenti ricerche (si veda ad es., Byerly & Ross, 2006; Galdi, 2014; Galdi, Maass, & Cadinu, 2014), i moderni media giocano un ruolo primario nella rappresentazione della donna proponendo un modello stereotipato e sessualmente oggettivato che, invece, è in sostanza assente nella rappresentazione mediatica del genere maschile (Volpato, 2013).
Il videogioco che ha fatto della sessualizzazione femminile e della violenza il proprio marchio di fabbrica, unendo rappresentazione sessualizzata e violenza di genere, è sicuramente la serie di Grand Theft Auto (GTA), uno dei giochi più diffusi a livello globale, con oltre 32 milioni di copie vendute dell’ultimo capitolo; complessivamente è il gioco più venduto nella storia. In GTA, il 90% delle figure femminili non ricopre ruoli primari e viene trattato essenzialmente come un oggetto sessuale, spesso target di violenza, ricoprendo un ruolo decorativo rispetto al protagonista che rappresenta invece l’incarnazione della mascolinità tradizionale (Gabbiadini, Riva, Andrighetto, Volpato, & Bushman, 2015).
Un altro prodotto videoludico che deve la propria fortuna alla rappresentazione sessualizzata della protagonista è la serie Tomb Raider. Lara Croft, la protagonista del videogioco, è una delle più note eroine del panorama videoludico. Lara è dotata di grande intelligenza e agilità fisica ed è spesso indicata come il prototipo dell’immaginario sessuale virtuale maschile, per via delle curve generose e degli abiti succinti che gli sviluppatori del gioco hanno voluto regalarle.
Anche i sistemi di classificazione dei contenuti dei videogiochi – come, ad esempio, la classificazione ESRB (Entertainment Software Ratings Board) – che dovrebbero fornire indicazioni ai consumatori circa i contenuti dei prodotti videoludici e determinare la fascia di età più adatta per l’utilizzo dei videogame – non sempre considerano la rappresentazione oggettivata della donna come un elemento da segnalare. Da un’analisi condotta dall’organizzazione Children Now (2001), emerge che molti giochi classificati come E-rated, ovvero per i bambini dai sei anni in su, contengono scene violente, spesso impunite – come d’altronde accade in tutti i videogiochi violenti – favorendo così l’imitazione di comportamenti preoccupanti.Inoltre in questi videogame i personaggi femminili costituiscono una minoranza e sono rappresentati parzialmente nudi e con forme sproporzionate, sebbene vengano indicati come adeguati ad un utenza infantile dal sistema di valutazione ESRB (Heintz-Knowles & Henderson, 2001).
Date tali evidenze e data la diffusione sempre crescente dei titoli videoludici, è rilevante indagare quali siano gli effetti dell’esposizione a videogame che propongono una visione sessualizzata della donna.
Gli effetti dell’esposizione a personaggi sessualmente stereotipati
La letteratura scientifica mostra che videogiochi con contenuti sessuali espliciti e violenza di genere possono favorire una maggiore tolleranza alla violenza sessuale (Dill, Brown, & Collins, 2008) e una più elevata accettazione degli stereotipi di genere (Yao, Mahood, & Linz, 2010); inoltre, l’interazione con avatar sessualizzati in ambienti virtuali tridimensionali favorisce comportamenti sessisti (Fox & Beilenson, 2009), processi di auto-oggettivazione (si veda glossario) della donna (Fox, Bailenson & Tricase, 2013) e una maggiore adesione al mito dello stupro (Fox, Ralston, Cooper, & Jones, 2014). In questo studio in particolare, gli studiosi hanno invitato alcune studentesse di un’università ad interagire in uno spazio virtuale attraverso avatar sessualizzati, mentre un secondo gruppo di partecipanti interagiva con avatar non sessualizzati. In seguito, tutte le partecipanti hanno risposto ad alcune domande circa le loro credenze relativamente ad atti di violenza sessuale. Ciò che è emerso è che le ragazze che avevano “indossato” un avatar (si veda glossario) sessualizzato erano maggiormente propense a giustificare atti di violenza sessuale contro una donna, biasimando la vittima di violenza e accettando scusanti per il perpetratore.
Behm-Morawitz e Mastro (2009) hanno indagato le conseguenze a breve termine che l’interazione di gioco attraverso personaggi femminili stereotipati e sessualizzati può avere sui videogiocatori sia di genere maschile che femminile. I partecipanti allo studio erano assegnati in modo casuale a giocare con un personaggio di gioco femminile sessualizzato o con un personaggio femminile non sessualizzato. I risultati suggeriscono che a essere influenzata è la rappresentazione della donna in termini assoluti: i partecipanti di genere maschile, che avevano giocato con avatar femminili sessualizzati, mostravano, infatti, minor fiducia nelle capacità cognitive del genere femminile e riportavano atteggiamenti meno favorevoli e idee più tradizionaliste e conservatrici sul ruolo della donna nella società. Diversi sono stati anche gli effetti che si sono verificati sulle partecipanti di sesso femminile, le quali hanno riportato prestazioni peggiori nel gioco e una più bassa percezione delle proprie capacità cognitive e fisiche, nonostante i personaggi femminili del videogioco fossero dotati di abilità e caratteristiche eccezionali. Inoltre, dopo aver giocato con avatar sessualizzati, le partecipanti esprimevano atteggiamenti più negativi verso il proprio stesso genere. Questo risultato è in linea con altre ricerche sui media tradizionali (Galdi, 2014; Galdi et al., 2014); sono, infatti, molti i casi in cui donne, sottoposte all’influenza di immagini oggettivanti, stereotipate e sessualizzate, tendono ad assumere il punto di vista dell’osservatore, attribuendo a se stesse la caratteristica di oggetto sessuale. Come suggerito da Aubrey (2006), che ha indagato come e quanto l’esposizione a media oggettivanti e sessualizzanti possa influire sulla percezione del proprio corpo da parte di una donna, questo fenomeno è spiegabile sulla base della teoria dell’oggettivazione (si veda glossario) proposta da Fredrickson e Roberts (1997): i media che veicolano immagini sessualizzate della figura femminile provocano, in chi assiste, l’apprendimento di tali concetti, innescando in molte donne processi di auto-oggettivazione, che si esprimono in vissuti di vergogna per il proprio corpo e di ansia per non essere adeguate al modello proposto.
I moderni videogiochi offrono all’utente finale un ambiente in cui è molto più facile immedesimarsi. Rispetto alla visione di un film ad esempio, durante il quale gli individui sono spettatori passivi, i videogiochi richiedono una partecipazione attiva delle persone. L’interattività del gioco, ovvero il fatto di dover muovere un personaggio e reagire attivamente agli stimoli che il gioco propone, favorisce una maggiore immedesimazione con il personaggio di gioco. L’identificazione individuale con un agente virtuale, ovvero il fenomeno per cui un giocatore è portato a fondere e confondere elementi dei videogiochi con quelli della realtà, diviene un aspetto particolarmente rilevante nel processo di auto-oggettivazione indotto da una rappresentazione virtuale, che merita un ulteriore approfondimento.
L’altro me: Game Transfer Phenomena e Proteus Effect
Ma per quale motivo, interagendo attraverso un avatar sessualizzato, le persone tendono ad auto-oggettivarsi? Qual è il processo psicologico che spiega come i tratti di un personaggio virtuale possano essere interiorizzati da una persona? Il processo del cosiddetto Game Transfer Phenomena (GTP) avviene quando i giocatori vedono, sentono, sperimentano o interpretano il mondo reale basandosi sui contenuti dei videogiochi, ricreando, trasformando e allineando gli elementi tratti dai videogiochi nel “puzzle” della vita reale (Ortiz de Gortari, Aronsson, & Griffiths, 2011). Il GTP è oggetto di indagine di un’area di ricerca recentemente sviluppatasi, che ha lo scopo di esplorare e comprendere come le esperienze virtuali, vissute giocando con un videogioco o in un ambiente virtuale tridimensionale, possano essere trasferite nella vita reale. Vengono indagati gli effetti psicologici, cognitivi e fisiologici innescati da un’eccessiva esposizione ai videogiochi e i meccanismi psicologici coinvolti in questa esperienza. La traslazione delle esperienze virtuali nel mondo reale viene innescata dall’associazione tra stimoli della vita reale ed elementi tratti dai videogiochi; essa causa una conseguente alterazione dei processi mentali, della percezione sensoriale, degli impulsi e dei riflessi, del comportamento automatico e delle azioni dei giocatori, che vengono basate sui contenuti del videogioco. Quando si manifesta, il GTP può coinvolgere uno o più sensi, come, ad esempio, la vista e l’udito: non è raro infatti che i videogiocatori riportino di aver avuto “visioni” accompagnate da musiche tipiche del videogioco al quale stavano giocando (Ortiz De Gortari et al., 2011).
E’ possibile distinguere due tipi differenti di GTP: automatico e intenzionale (Ortiz De Gortari et al., 2011). I fenomeni automatici derivano dal coinvolgimento del giocatore, che prolunga l’esperienza di gioco anche dopo aver smesso di giocare. Essi includono esperienze definite intrusive, che portano all’alterazione delle capacità percettive dovute alla persistenza delle immagini virtuali nella mente del giocatore, come ad esempio l’impressione di continuare a schiacciare un bottone, oppure di essere ancora in movimento. I fenomeni di trasferimento intenzionale riguardano, invece, l’assunzione consapevole nella vita reale di comportamenti e atteggiamenti veicolati dal gioco. Il trasferimento intenzionale manifesta spesso l’imitazione del comportamento di personaggi o il riferimento a elementi virtuali nell’interazione con altri individui nella vita reale. La similarità tra mondo reale e videogiochi può essere la causa delle associazioni tra questi due mondi e proprio l’esposizione alla riproduzione di elementi reali nei videogames sembra essere la determinante principale del GTP (Ortiz de Gortari et al., 2011). Dagli studi finora svolti, si evince che a essere coinvolti in queste esperienze di traslazione sono per lo più i giocatori assidui; restano tuttavia ancora inesplorate le differenze individuali che possono favorire il GTP.
Un'altra conseguenza che nasce dalla commistione tra reale e virtuale è il cosiddetto Proteus Effect. Si tratta nuovamente del trasferimento di elementi del videogioco nel mondo reale, legato però più alle caratteristiche di un avatar sulla propria persona. Il Proteus Effect si verifica quando la rappresentazione del sé viene modificata in maniera significativa, spesso in modo del tutto dissimile al sé fisico. Il giocatore osserva il comportamento dell’avatar e ne ricava inferenze circa le sue credenze o atteggiamenti, adeguando i propri comportamenti a quelli del personaggio virtuale. Il primo studio che esamina gli effetti della personificazione di un avatar è stato condotto da Fox e colleghi (2013). I partecipanti allo studio erano esclusivamente ragazze e i ricercatori hanno indagato se il sistema di credenze, atteggiamenti e di percezione del sé fosse influenzato quando esse interagivano attraverso avatar rappresentati in maniera sessualizzata. I risultati mostrano che le partecipanti che interagivano attraverso un avatar iper-sessualizzato, rispetto a un avatar non sessualizzato, ne interiorizzavano maggiormente le caratteristiche fino ad auto-oggettivarsi e ad avere pensieri focalizzati sul proprio corpo (Fox et al., 2013). Come già descritto in precedenza, questi processi favorirebbero addirittura una maggiore adesione al mito dello stupro da parte delle ragazze (Fox et al., 2014). Tuttavia, l’identificazione con il personaggio di gioco, ovvero il grado in cui le partecipanti credevano di essere il loro avatar, non ha mostrato effetti significativi; secondo gli autori, infatti, il solo elemento rilevante è il modo in cui l’avatar viene rappresentato e vestito. Questo risultato è apparentemente in disaccordo con quanto recentemente mostrato da altri studi (si veda Gabbiadini et al., 2015), secondo i quali l’identificazione con il personaggio di gioco assume un ruolo primario nello spiegare gli effetti dei videogiochi dai contenuti sessisti. Questa differenza nei risultati potrebbe essere spiegata dal fatto che nello studio di Fox e colleghi (2013) le partecipanti erano immerse in un ambiente tridimensionale creato ad hoc per l’occasione, senza una precisa caratterizzazione dell’ambiente virtuale circostante, privo di azione e interazione con il mondo virtuale, come invece accade nei videogame moderni nei quali l’interazione e l’intreccio della narrazione sono elementi estremamente rilevanti.
Analizzando i risultati degli studi sopra esposti, si ricava un quadro piuttosto complesso e articolato circa gli effetti che i videogiochi moderni possono avere sugli individui e l’importanza che questi effetti assumono nel contesto sociale. Tuttavia, nonostante il crescente interesse della ricerca nei confronti della rappresentazione di genere nei prodotti videoludici, non esiste in letteratura uno studio che indaghi con una prospettiva integrata gli effetti che l’utilizzo di personaggi sessualizzati ha sul giocatore. Inoltre, nella maggior parte dei moderni action videogame, la rappresentazione sessualizzata delle eroine di gioco si accompagna a contenuti mediatici violenti. Lo studio proposto da Behm-Morawitz e Mastro (2009) che rappresenta un lavoro pionieristico, tuttavia lascia inesplorate molteplici ipotesi, come ad esempio la verifica degli effetti dell’utilizzo di un personaggio sessualizzato sui processi di auto-oggettivazione. Alcune indicazioni circa questo aspetto vengono fornite dai risultati degli studi di Fox e collaboratori (Fox et al., 2009, Fox et al., 2013, Fox et al., 2014) i quali, tuttavia, non hanno considerato un videogame vero e proprio ma un ambiente tridimensionale creato ad-hoc, privo quindi degli aspetti narrativi tipici dei moderni videogiochi.
Tuttavia colpi di scena e azione sono elementi tipici dei moderni videogame. La mancanza degli aspetti narrativi tipici di un videogame evidenziata nella letteratura precedente offre nuovi spunti di indagine. Risulta quindi interessante una replica degli studi di Fox e colleghi (Fox et al., 2009, Fox et al., 2013, Fox et al., 2014) considerando dei reali videogames –invece che ambienti virtuali creati ad-hoc – per verificare se l’azione di gioco possa esercitare delle influenze. E’ altresì importane approfondire quale ruolo giochino le variabili di differenza individuale come l’identificazione con il personaggio di gioco. Questo interesse è oggi ancor più rilevante, data l’attenzione mostrata tanto dalle istituzioni pubbliche quanto dal popolo delle videogiocatrici, che hanno iniziato a esprimere perplessità sull’industria videoludica, sempre più caratterizzata da dinamiche di gioco complesse ed articolate e priva di un efficace sistema di valutazione dei contenuti proposti.
Glossario