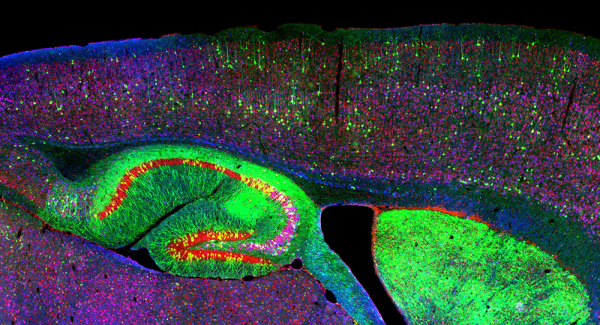La creatività si riferisce in senso lato a un insieme di processi psicologici e comportamenti che consentono agli individui e ai gruppi di produrre contributi nuovi e utili alle vite proprie e a quelle altrui. Nella misura in cui si associa al progresso tecnologico, alla produzione artistica, e allo spettacolo, la creatività è connotata in modo estremamente positivo (Sawyer, 2012). Ma essendo strumentale, la creatività può essere usata per scopi negativi. L’inganno, l’intrigo e il tradimento richiedono intelligenza sociale, e dunque traggono giovamento da una mente creativa (Gino & Wiltermuth, 2014; Mayer & Mussweiler, 2011). Se la consideriamo come una capacità o un processo, dunque indipendentemente dai suoi potenziali risultati, la creatività (così come il denaro o la conoscenza) è priva di una connotazione di valore (Weber, 1917). Le persone sono generalmente interessate alla natura e al processo della creatività, e spesso si chiedono come possono fare per incrementare la creatività loro, o dei loro figli, studenti, dipendenti, etc. In questo articolo prendo in esame i classici lavori sulla creatività e sostengo che ciascuno di questi approcci cattura una parte del fenomeno, ma che, preso da solo, ciascuno di questi approcci è non solo incompleto, ma sbagliato. La creatività, sostengo, emerge da un’interazione dialettica tra forze contrapposte, all’interno della quale ciascuna forza richiede l’esistenza dell’altra. La creatività scomparirebbe se una di queste forze vincesse lo scontro. È lo scontro di forze che genera creatività.
L’articolo è organizzato attraverso una serie di sette dialettiche. Introdurrò ciascuna dialettica facendo riferimento alle fonti classiche rilevanti. Infine concluderò con un sommario integrativo e una nota sulla relazione tra psicologia della creatività e psicologia del giudizio e della presa di decisione
Dialettica 1: il paradosso di Russell
Le teorie duali (dual-process) sono tornate (di nuovo) a dominare la psicologia. Aristotele, i Padri della Chiesa, Freud avevano distinto una semplice mente intuitiva da una mente più alta, e più razionale (Dawes, 1976). Kahneman (2011) e altri autori recenti hanno rinforzato questa visione. Alcuni decenni orsono, lo psicologo umanista Abraham Maslow (1968) presentò un’ipotesi basata su un modello duale riguardo alla creatività, definendo la creatività come capacità caratteristica dell’auto-realizzazione, cioè della più alta tra le motivazioni umane. Eppure, nella sua visione, la creatività richiede una parziale regressione alla spontaneità infantile, giocosità, e indifferenza all’opinione degli altri. La spontaneità caratterizza un processo primario libero, spontaneo, ma che non può essere lasciato completamente privo di freni. Deve esserci anche un processo secondario capace di definire standard e convenzioni, un processo che dà una direzione e pone limiti al processo primario. Cos’è allora la creatività? È la spontaneità del processo primario, o la sua spontaneità all’interno dei vincoli del processo secondario? Dal punto di vista logico non può essere entrambe le cose, a meno di non cadere in un caso del paradosso di Russell. Nella sua critica della classica teoria degli insiemi, Russell (1902) notò che un insieme non può contenere se stesso. Un catalogo di libri non può contenere se stesso nella lista dei libri senza essere auto-contraddittorio. Allo stesso modo la creatività non può riferirsi simultaneamente a un processo primario, intuitivo, e a un’interazione tra un processo primario e un processo secondario che gli fa da controllore. Tuttavia, una visione dialettica della creatività non viene messa in crisi da questo paradosso logico. Anziché temere una confutazione per contraddizione, la prospettiva dialettica suggerisce che il fenomeno di cui ci occupiamo nasca dalla tensione tra forze o idee opposte, ed emerga come una sintesi dall’interazione tra tesi e antitesi.
Dialettica 2: tra Caso e Intenzionalità
Da dove nascono i pensieri e i comportamenti spontanei? La maggior parte degli psicologi cognitivi sostiene che gli eventi mentali possono essere ricondotti a stimoli esterni i cui effetti si propagano attraverso la rete di associazioni della nostra mente. Non così Campbell (1960), secondo il quale le idee fluiscono da un generatore di idee inconscio che sforna in modo casuale delle mutazioni di idee precedenti. L’analogia con le mutazioni genetiche e l’evoluzionismo di Darwin è deliberata. Dato un copioso flusso di idee sempre in mutazione, occasionalmente qualcuna si adatta bene a un compito psicologico in atto. In quel momento diventa conscia e dà luogo a un fenomeno di insight (aha!). Secondo Campbell, l’insight è il risultato di un processo di variazione casuale e ritenzione selettiva, e non un concetto esplicativo. La proposta di Campbell è in contrasto dialettico con l’ipotesi che il problem solving creativo sia frutto di ricerca sistematica e guidata dall’impegno, nella quale la soluzione viene gradualmente avvicinata e alla fine raggiunta attraverso l’attenta eliminazione, passo passo, di opzioni alternative. Questa visione era fatta propria soprattutto dagli psicologi della Gestalt (Wertheimer, 1959), ed è ben illustrata dall'analisi del problema della candela e della scatola di fiammiferi di Duncker (1945). La visione dialettica della creatività suggerisce che né il caso (Campbell) né l’intenzionalità (Duncker) possono arrivare al successo da soli. La mutazione casuale ha bisogno di un criterio per avere successo, e la ricerca sistematica necessita di un sistema per generare opzioni. La proposta di Guilford (1950) che la creatività implichi un’intelligenza diversa cattura questa dialettica. Guilford distinse tra pensiero convergente, che riduce le opzioni fino a quando una singola risposta corretta viene individuata, e pensiero divergente, che genera molteplici alternative (ad esempio, una lista di modi in cui potrebbero essere utilizzati i fiammiferi). Il processo primario genera alternative, ma lo fa nei limiti definiti dal criterio di utilità.
Dialettica 3: oltre le Convenzioni e l’Expertise
Se un processo creativo primario può manifestarsi solo all’interno dei limiti imposti da un processo secondario di controllo, occorre chiarire meglio quale sia la natura di questi limiti. In una prospettiva non dialettica il limite è definito sia in positivo (obiettivo) sia negativo (inibizioni). Maslow (1968) vedeva i limiti sociali, le aspettative normative e la pressione dei pari come barriere all’espressione creativa. Una persona il cui comportamento è prodotto dall’abitudine e limitato dalla paura non può essere creativa. L’expertise professionale permette a un individuo di padroneggiare abilità, tecniche e modi di pensare (Fleck, 1935). L’expertise definisce il recinto all’interno del quale le persone pensano e agiscono efficacemente. La prospettiva dialettica suggerisce che questo recinto è necessario per l’esplorazione e l’innovazione al di là del recinto. Gutenberg padroneggiava la tecnologia del suo tempo (Figura 1a e 1b). Comprendeva l’ingegneria del torchio per fare il vino e conosceva i caratteri mobili. Il suo contributo creativo fu quello di non pensare né come un vignaiolo né come uno scriba. Combinando la meccanica del torchio con il potenziale combinatorio delle lettere, Gutenberg rivoluzionò la comunicazione.
Comprendeva l’ingegneria del torchio per fare il vino e conosceva i caratteri mobili. Il suo contributo creativo fu quello di non pensare né come un vignaiolo né come uno scriba. Combinando la meccanica del torchio con il potenziale combinatorio delle lettere, Gutenberg rivoluzionò la comunicazione.
Mednick (1962) propose una teoria cognitive su come le idée sono organizzate nella mente, e come questa organizzazione dipenda dal grado di expertise. In individui con una gerarchia associativa ripida, la conoscenza è strettamente interconnessa. Lo spazio mentale di un ingegnere è densamente popolato di concetti, ciascuno dei quali attiva rapidamente altri concetti nello stesso spazio. Concetti che stanno al di fuori di questo spazio definito dall’ambito professionale sono difficilmente raggiungibili. Individui con una gerarchia associativa più piatta hanno accesso più rapidamente a associazioni remote. Questa è un’idea dialettica. L’expertise è importante, ma quando è troppo diventa un limite. Mednick sviluppò il noto “Remote Associates Test” per quantificare il gradiente di associazione. Se, ad esempio, vengono mostrate le parole “sedia”, “legno”, e “biliardo”, una persona con una gerarchia associativa piatta sarà più rapida a indicare la parola “tavolo” come elemento comune (e quindi remoto) rispetto a una persona con gerarchia associativa ripida o priva di gerarchia. Il pensiero di Mednick è speculare a quello di Guilford. Guilford chiederebbe alle persone di elencare parole legate a “tavolo”, ma non l’una con l’altra.
Dialettica 4: Distruzione Creativa
Schumpeter (1942), il noto apologeta del capitalismo ciclico, sosteneva che le crisi economiche, anche le più catastrofiche delle recessioni, sono momenti di distruzione creativa. La distruzione del vecchio è necessaria per la genesi del nuovo, potenzialmente migliore. Rank (1925), influente Neo-Freudiano, elevò la dialettica di distruzione e creazione a “principio generale della vita”. Rank avrebbe avuto inattesi alleati tra gli psicologi della gestalt. Il concetto chiave della teoria della Gestalt è la Prägnanz (in tedesco nel testo, n.d.t.), cioè l’idea che la mente interpreti un insieme di stimoli scegliendo la configurazione che meglio vi si adatta, e rifiutando tutte le possibili alternative. La percezione è creativa nel senso che aggiunge interpretazione e coerenza a stimoli disparati. Dal momento che soltanto un’interpretazione può avere accesso alla coscienza, tutte le altre devono essere distrutte a livello subliminale. Allo stesso modo, l’ideazione e l’azione creative devono testare e scartare tutte le possibilità tranne una. Rank affermava che è vero anche l’inverso, cioè che ogni distruzione implica creazione. Questa è una affermazione grossolana e probabilmente falsa. È più prudente dire che ogni distruzione contiene il seme di una creazione. Se e come una nuova creazione emerge, dipende dall’intero insieme delle dialettiche.
Dialettica 5: l’Omeostasi Disturbata
Un’enfasi a senso unico sul processo primario semplifica eccessivamente la creatività e induce la soddisfazione illusoria di un desiderio. Chi non vorrebbe ottenere qualcosa in cambio di nulla? Sfruttando questa illusione, i guru del self-help potrebbero scrivere libri sui +/- 7 facili modi per diventare più creativi. Una prospettiva dialettica rispetta invece il ruolo critico dell’impegno. Russell (1930) descrisse il modo in cui secondo lui occorre affrontare un compito che richiede un impegno mentale prolungato. Se dopo settimane o mesi di lavoro non si fosse riusciti a produrre una soluzione, occorrerebbe sospendere l’impegno cosciente, lasciando che la mente prosegua il lavoro in maniera sotterranea. Spesso, nella sua esperienza, questo approccio è ripagato dopo qualche tempo, quando la soluzione emerge apparentemente dal nulla. Russell aveva compreso la dialettica tra impegno e resa, anticipando così la psicologia dell’effetto incubazione (Ellwood, Pallier, Snyder, & Gallate, 2009). Questa dialettica è un principio generale della vita al pari di quello di Rank. È facilmente spiegabile con l’analogia del corpo. Un corpo sano richiede l’equilibrio di esercizio e riposo, e lo stesso vale per la mente. Non è l’omeostasi ad essere importante, ma il ritorno all’omeostasi dopo un periodo di stress.
Dialettica 6: Oltre la Mente
Il pensiero lineare e il desiderio di semplicità sono ostacoli sulla strada di chi voglia apprezzare le dialettiche della creatività. I guru e i loro ammiratori possono prendere nota della scoperta che un umore positivo è associato con l’ideazione creativa (ad esempio il pensiero divergente di Guilford) e il problem-solving (ad esempio la progettazione creativa di Duncker). La ricerca supporta tra l’altro un legame causale. Davis (2009) trovò in una meta-analisi della letteratura sul tema che l’induzione di un umore positivo facilita la creatività. Il principale meccanismo implicato non è però la valenza dell’umore in sé. Per quanto possa essere vero che essere felici renda le persone più audaci e più sicure di sé, e quindi creative, un semplice meccanismo associativo sembra sufficiente per spiegare il fenomeno. Per fortuna, la maggior parte delle persone conserva più ricordi positivi che negativi. La valenza dell’umore rende più facilmente accessibili ricordi con la stessa valenza. Questo “priming cognitivo” (Isen, 1999) regola la quantità di materiale disponibile in un contesto creativo. La dialettica consiste nel fatto che gli esseri umani hanno un controllo limitato sul loro stato dell’umore. L’umore è un sistema di segnalazione, plasmato dall’evoluzione, che dice alle persone quanto le cose stiano andando bene o male in un certo momento. Se l’umore divenisse completamente sottoposto al controllo volontario, la sua funzione di segnalazione cesserebbe. Individui dotati di una mente dialettica, però, possono auto-ingannarsi esponendosi a situazioni che li facciano stare bene.
Una dialettica legata a questa è la dialettica del potere. Individui dotati di potere interpersonale sono meno limitati da inibizioni sociali o abitudini. Dunque, sono più creativi di individui con meno potere (Galinsky, Magee, Gruenfeld, Whitson, & Liljenquist, 2008). Eppure, difficilmente hanno un controllo diretto sulla fonte del loro potere. La loro mente deve portarli a percepire di avere potere; ad esempio, possono adottare una postura aperta ed espansiva del loro corpo (Carney, Cuddy, & Yap, 2010), oppure possono brandire utensili forti e potenti come martelli pneumatici, trapani o aspiratori industriali.
Dialettica 7: il Progresso attraverso la Difesa
L’ultima dialettica sta sulla sottile linea di confine tra creatività e psicopatologia. Freud (1905) riteneva che la produzione culturale (creatività) fosse dovuta alla sublimazione di impulsi sessuali inaccettabili. Weber (1934) riteneva che i Protestanti fossero resi migliori dalle nozioni di depravazione e dannazione. Coloro che adottano la dottrina della predestinazione è più probabile che lavorino duramente e investano i loro guadagni nel tentativo di decifrare i segnali della grazia di Dio. In una linea di ricerca molto creativa, Cohen e coll. hanno unito Freud e Weber, dimostrando che Protestanti con disturbi psichici producono più risultati creativi (poesie, sculture in creta) rispetto a cattolici, Ebrei, e Protestanti senza disturbi (Kim, Zeppenfeld, & Cohen, 2013). Come le altre dialettiche, anche quella del progresso attraverso i meccanismi psicologici di difesa non offre una strada che porti diretta verso la creatività. La creatività emerge dal conflitto e dalla contraddizione. Questa dialettica suggerisce che così come le conseguenze della creatività non sono necessariamente positive, allo stesso modo non sono necessariamente desiderabili o razionali tutte le fonti della creatività.
Conclusione
L’approccio diretto alla creatività supera i modelli lineari. Per quanto i modelli lineari possano rivelarsi utili approssimazioni, non riescono a catturare la natura dinamica della creatività. Può essere vero e utile che andare a farsi una passeggiata e lasciar vagare la mente consentano a un flusso creativo di idee di affacciarsi. Studi sperimentali che supportano questa idea sono frutto del paradigma lineare (Baird, Smallwood, Mrazek, Kam, Franklin, & Schooler, 2012), ma l’approccio lineare ignora la necessità di forze contrapposte. La spontaneità necessita di controllo (dialettica 1), il caso richiede una direzione (dialettica 2), l’innovazione ha bisogno di expertise (dialettica 3), la creazione di distruzione (dialettica 4), l’omeostasi di stress (dialettica 5), l’ideazione mentale di stimoli esterni (dialettica 6), e il progresso culturale ha bisogno di sofferenza psichica (dialettica 7). Considerando i modelli lineari come solo parzialmente corretti, la prospettiva dialettica mette in guardia contro l’idea che ricette semplici per l’incremento della creatività siano realmente ciò di cui abbiamo bisogno. Tentare di aumentare la creatività a comando ha la stessa probabilità di successo che ordinare a qualcuno “Sii spontaneo!”. Dialetticamente parlando, questi sforzi non sono del tutto futili: devono semplicemente essere intesi entro il loro contesto dinamico.
La prospettiva dialettica è simile alle teorie duali sulla cognizione in quanto entrambe postulano una polarità psicologica. Le teorie duali distinguono tra processi efficienti ma imprecisi (intuizione, percezione, emozione, pensiero euristico) e processi precisi ma inefficienti (pensiero deliberato). Questi due tipi di processi o sistemi si ritiene possano lavorare sia in parallelo sia in modo seriale. Secondo l’idea più recente e popolare, il secondo tipo di processo controlla l’operato del primo e solo occasionalmente interviene per correggerne gli errori. Al contrario, la prospettiva dialettica assume che fenomeni interessanti, come il pensiero creativo, emergano dalla tensione tra forze psicologiche in opposizione, nessuna delle quali, da sola, è in grado di produrre un risultato.
Pensate all’illusione di Müller-Lyer (1889). Secondo la psicologia dei processi duali, i processi percettrivi inducono la falsa impressione che le due linee differiscano in lunghezza, mentre i processi cognitivi conoscono la verità – per quanto non siano in grado di cambiare la percezione stessa (Sloman, 1996). Secondo la prospettiva dialettica, un tipo di analisi mentale determina che le due linee verticali sono identiche esattamente come lo stimolo che giunge all’apparato sensoriale. Un altro tipo di analisi nota che brevi linee oblique suggeriscono una direzione particolare. Una linea verticale sembra essere il margine esterno di un corpo tridimensionale, mentre l’altra sembra esserne il margine interno. La soluzione dialettica è quella di assumere che la linea che apparentemente costituisce il margine interno sia più lontana, e benché nella prima analisi appaia di lunghezza identica all’altra, in realtà debba essere più lunga. L’illusione nasce dalla dialettica di un disaccordo tra stimolo fisico e inferenza intelligente. La percezione è creativa.
Glossario