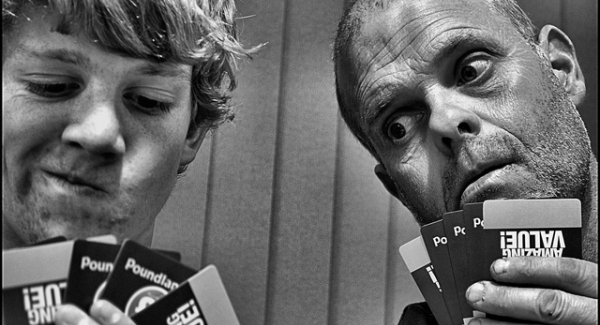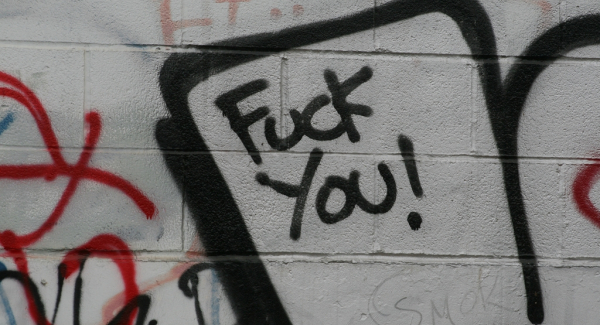Keywords: Ideologia politica; moralità; teoria dei fondamenti morali; sensibilità al disgusto
Una peculiarità degli esseri umani sembra essere la dimensione morale, caratteristica di primaria importanza anche nel giudizio sociale. Tuttavia, il termine moralità si presenta come un vocabolo piuttosto generico all’orecchio comune, indicando soltanto il fatto che la condotta di un individuo possa conformarsi o meno a determinati canoni o standard. La moralità gode, quindi, di una duplice natura: Da un lato si caratterizza come dimensione universale per la priorità che esercita nel giudizio sociale, ma dall’altro, proprio per l’autonomia data al singolo individuo nella “conoscenza del bene e del male,” si connota per la sua specificità individuale. Rappresentativa del secolare dibattitto filosofico sul tema è senz’altro la lapidaria affermazione del filosofo Kant “Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me” (Kant, 2012).
Nello specifico, questo contributo intende proporre una riflessione rispetto ad una serie di differenze individuali legate al significato attribuito alla parola moralità, in particolare in relazione alle discrepanze tra persone che supportano diverse ideologie politiche. Nonostante, infatti, già dagli anni ‘60 si sia iniziato a parlare di “fine dell’ideologia” (ad es., Jost, 2006), la ricerca scientifica che ruota attorno all’argomento è sempre stata molto fiorente ed oggi, grazie forse a nuovi strumenti di indagine, si riscontra un rinnovato e vivo interesse per la ricognizione delle radici profonde dell’ideologia politica, tanto da poter parlare di “fine della fine dell’ideologia” (Jost, 2006). Questa fine della fine è caratterizzata anche dall’inizio di un nuovo approccio nello studio di questo argomento: un approccio più scientifico, allo scopo di comprendere i correlati e l’origine dell’ideologia politica. Alcuni studi hanno, infatti, messo in luce correlati dell’ideologia che rimandano a fattori cognitivi molto profondi (ad es., Amodio, Jost, Master, & Yee, 2007). Prima di descrivere alcuni di questi lavori, riteniamo importante definire il significato che in questo contesto assumono i termini di conservatore e progressista (o “liberal” seguendo la terminologia anglosassone).
Dalla prospettiva della psicologia sociale cognitiva, l’ideologia politica può essere descritta come una struttura funzionale all’individuo per gestire determinati bisogni e motivazioni, come ad esempio ridurre l’incertezza, l’ansia, la paura e l’ambiguità (ad es., Jost, Federico, & Napier, 2009; Jost, Nosek, & Gosling, 2008). In quest’ottica, conservatori e progressisti si differenziano soprattutto per il loro diverso atteggiamento nei confronti del cambiamento. I conservatori appaiono caratterizzati, ad esempio, da un maggiore attaccamento alla tradizione e da un maggiore rifiuto dell’ambiguità; al contrario, i progressisti sembrano più aperti al cambiamento, riuscendo meglio a tollerare le situazioni incerte e ambigue. Da questa definizione si evince che la distinzione tra conservatori e progressisti qui proposta riflette solo in parte il bipolarismo politico italiano tra centro-destra e centro-sinistra, e sembra quindi andare oltre la mera affiliazione partitica. Infatti, l’ideologia politica così descritta correla con preferenze, atteggiamenti e comportamenti che travalicano la sfera politica, così da poter concludere che l’uomo è un animale ideologico in diversi ambiti (Jost et al., 2008; Tomkins, 1963, 1965). Emergono spesso curiose differenze, ad esempio, nei profili di personalità (ad es., Caprara & Zimbardo, 2004), negli stili cognitivi (ad es., Jost, Glaser, Kruglanski, & Sulloway 2003), nelle reazioni automatiche in risposta a stimoli negativi (ad es., Carraro, Castelli, & Macchiella 2011; Castelli & Carraro, 2011), così come nelle risposte neurali (ad es., Amodio et al., 2007) e fisiologiche (Oxley et al., 2008), nonché nelle misure volumetriche di alcune strutture cerebrali come l’amigdala destra (Kanai, Feilden, Firth, & Rees, 2011), regione coinvolta nelle risposte fisiologiche e comportamentali alla paura.
Anche per quanto riguarda più nello specifico l’ambito della moralità, la ricerca scientifica ha evidenziato delle differenze profonde tra conservatori e progressisti. In letteratura si ritrovano diversi modelli e approcci che, però, conducono sostanzialmente alle medesime conclusioni. Ad esempio, alcuni studi focalizzati sugli orientamenti valoriali hanno mostrato la presenza di due dimensioni fondamentali alla base dell’orientamento politico (Heaven & Oxman, 1999). Una dimensione (International Harmony and Equity/Armonia internazionale ed equità), più caratteristica dei progressisti, si riferisce all’integrità e al benessere proprio ed altrui, alla libertà e all’uguaglianza come valori guida. L’altra dimensione (National Security and Order/Sicurezza nazionale e ordine) si ritrova maggiormente nel pensiero conservatore poiché rimanda soprattutto alla forza, all’ordine, alla disciplina, al potere e al successo personale. In modo analogo, considerando il sistema di valori proposto da Schwartz (1992; si veda glossario), i conservatori sembrano aderire maggiormente a valori quali Sicurezza, Potere, Successo, Conformismo e Tradizione, mentre i progressisti ottengono punteggi maggiori nei valori di Universalismo, Benevolenza e Autodirezione (Cohrs, Moschner, Maes, & Kielmann, 2005). Altre indicazioni interessanti provenienti dalla letteratura scientifica riguardano i valori sociali che orientano il comportamento delle persone nei contesti di relazione interpersonale e intergruppi (social value orientation, SVO; Van Lange, Bekkers, Chirumbolo, & Leone, 2012; si veda glossario). Secondo questa letteratura, i conservatori sembrano essere caratterizzati da un orientamento di tipo individualista e competitivo, mentre i progressisti da un orientamento prosociale e cooperativo.
Dopo questa sintetica panoramica, nei paragrafi successivi l’attenzione sarà focalizzata sulle differenze tra progressisti e conservatori soprattutto in relazione alla teoria dei fondamenti morali (Haidt & Joseph, 2004) e alla sensibilità al disgusto. Riguardo quest’ultimo punto, appare, infatti, ormai ampiamente riconosciuto che la disapprovazione morale e il disgusto fisico siano fortemente connessi tra loro sia a livello cognitivo, sia a livello comportamentale e fisiologico (ad es., Eskine, Kacinik, & Prinz, 2011). Inoltre, la ricerca ha recentemente sottolineato che i conservatori manifestano una maggiore sensibilità al disgusto rispetto ai progressisti (ad es., Inbar & Pizarro, 2009) e che certi elementi ambientali collegati al disgusto (o al contrario all’igiene) possono determinare delle reazioni e delle valutazioni più negative nei confronti dei comportamenti immorali, così come possono promuovere l’adozione di opinioni più conservatrici riguardo la moralità e le minoranze sociali (ad es., Helzer & Pizarro, 2011).
Teoria dei fondamenti morali (MFT)
La teoria dei fondamenti morali (Moral Foundation Theory, di seguito semplicemente MFT; Graham, Haidt, & Nosek, 2009; per la versione italiana del questionario si veda Bobbio, Nencini, & Sarrica, 2011) propone una visione funzionalista della moralità ed è stata inizialmente formulata allo scopo di capire perché il concetto di moralità sia al contempo tanto diverso passando da una cultura ad un’altra (evidenza trans-culturale) ma anche tanto simile tra le varie culture (evidenza universalista). In altre parole, la MFT cerca di integrare nella stessa visione le due caratteristiche peculiari della moralità accennate anche all’inizio di questo contributo, ovvero la sua natura per certi aspetti universale e per altri aspetti personale. La MFT propone cinque cardini, chiamati appunto fondamenti morali (gli Autori ne hanno recentemente proposto anche un sesto, Liberty/Oppression – Libertà/Oppressione; si veda Iyer, Koleva, Graham, Ditto, & Haidt, 2012), attorno ai quali ciascuna cultura, istituzione, gruppo, persona, guarda la realtà e ne costruisce l’interpretazione, stabilendo quindi cosa sia da considerarsi morale e cosa invece debba essere considerato immorale. In tale ottica, perciò, la moralità appare caratterizzata sia da una componente innata sia da una componente condizionata dalla cultura di appartenenza e, quindi, condivisa (Bobbio et al., 2011; Graham et al., 2009; Haidt & Joseph, 2004). Per quanto riguarda più nel dettaglio il contenuto e la descrizione di questi cardini, il primo fondamento morale (denominato Care/Harm - Prendersi cura/Ferire) sinteticamente riguarda il prendersi cura, il difendere e il farsi carico dell’altro considerato potenzialmente indifeso o bisognoso. Sembra essere, quindi, legato alla capacità di empatizzare con il dolore altrui. Il secondo pilastro (Fairness/Cheating - Giustizia/Imbroglio) raggruppa aspetti riguardanti la giustizia e la reciprocità nelle relazioni interpersonali e intergruppi. Il terzo fondamento morale (Loyalty/Betrayal – Fedeltà/Tradimento) si riferisce ai sentimenti di lealtà, di fedeltà e di attaccamento al proprio gruppo di appartenenza (i.e., ingroup), qualunque esso sia. Sembra quindi essere alla base, ad esempio, del senso di patriottismo e del sacrificio in favore dell’ingroup. Il quarto cardine (Authority/Subversion – Autorità/Sovversione) raggruppa aspetti centrati sul rispetto dell’autorità e del potere. Appare, quindi, alla base dell’ubbidienza e della subordinazione, nonché dell’attenzione e del rispetto nei confronti della tradizione. Infine, il quinto fondamento morale, chiamato dagli autori Sanctity/Degradation (Santità/Degrado), raccoglie contenuti come la purezza e la spiritualità e appare fortemente legato alla sensibilità al disgusto e al pericolo di contaminazione. Alla base vi è l’idea che il corpo sia una sorta di tempio che non debba quindi essere profanato da attività immorali e/o fonte di contaminazione.
Graham et al. (2011) hanno recentemente cercato di mappare il dominio morale di conservatori e progressisti secondo la MFT. Gli autori, attraverso quattro studi e usando diverse metodologie, hanno mostrato come i progressisti (vs. conservatori) siano maggiormente attenti alle tematiche che riguardano l’aiuto e la giustizia (ovvero i primi due fondamenti morali, chiamati anche fondamenti “Individualizzanti” o “Centrati sull’individuo”), mentre i conservatori sembrano ritenere ugualmente rilevanti tutti i fondamenti morali, attribuendo quindi più importanza rispetto ai progressisti agli altri tre fondamenti morali (chiamati anche “Vincolanti” o “Centrati sul gruppo”). Questo si rifletterebbe, inoltre, anche in una maggiore complessità morale propria dei conservatori poiché la loro condotta morale sembrerebbe reggersi su più fondamenti rispetto ai progressisti. Tale pattern di risultati è emerso costantemente in numerosi studi condotti in diverse parti del mondo impiegando diverse tipologie di campioni e metodologie, come ad esempio misure self-report, analisi del contenuto di sermoni e racconti di vita personale, così come analizzando le espressioni del volto (ad es., Cannon, Schnall, & White, 2011; Van Leeuwen & Park, 2009). Inoltre, Graham, Nosek, e Haidt (2012) hanno recentemente dimostrato che le persone sono consapevoli di tali differenze e che addirittura nello stereotipo condiviso le differenze morali tra conservatori e progressisti vengono sovrastimate. Scendendo più nel dettaglio riguardo la relazione tra l’ideologia politica e i cinque fondamenti morali, Graham et al. (2011) hanno individuato relazioni positive molto forti per quanto riguarda Authority/Subversion, Loyalty/Betrayal e Sanctity/Degradation, mentre la relazione tra ideologia e fondamenti morali è più debole e negativa nel caso di Care/Harm e Fairness/Cheating. In questo contesto, una relazione positiva indica che la polarità positiva (i.e., Authority, Loyalty e Sanctity) di un determinato fondamento è maggiormente rilevante per i conservatori rispetto ai progressisti, una relazione negativa indica il contrario. Inoltre, da un punto di vista pratico e applicativo, la forza di queste associazioni potrebbe suggerire che i dibattiti culturali e politici più difficili sono proprio quelli che riguardano il rispetto della tradizione, dell’autorità, nonché la purezza fisica e spirituale, in quanto sono quelli in cui l’opinione di conservatori e progressisti appare massimamente discrepante. Al contrario, dal punto di vista morale, il più alto grado di comunanza e quindi di accordo tra le parti può essere trovato in questioni relative al prendersi cura/danneggiare gli altri.
Sensibilità al disgusto, ideologia e giudizio morale
Negli ultimi decenni la ricerca scientifica ha evidenziato dei legami molto forti tra il giudizio morale, l’ideologia politica e una delle emozioni primarie (si veda glossario): il disgusto. Molteplici studi (ad es., Eskine, Kacinik, & Prinz, 2011; Schnall, Haidt, Clore, & Jordan, 2008) hanno, infatti, indicato che i giudizi morali espressi nei confronti di comportamenti ritenuti moralmente sbagliati tendono ad essere più duri se espressi in un contesto ambientale capace di suscitare l’emozione di disgusto. Inoltre, sebbene il legame tra disgusto e giudizio morale appaia essere generalizzabile, ovvero riscontrabile in quasi tutti gli individui, esso sembra particolarmente rilevante per coloro che abbracciano un’ideologia politica più conservatrice, i quali mostrano sia livelli maggiori di sensibilità al disgusto sia giudizi più intransigenti riguardo alle questioni morali inerenti la purezza.
L’emozione del disgusto può essere facilmente suscitata da un odore, da un suono, da una parola, o dalla visione di qualcosa di repellente. Quest’emozione primaria (Ekman, 1994) si esprime attraverso risposte comportamentali atte ad allontanare da sé l’oggetto che ha causato tale stato emotivo. La stessa espressione facciale associata a questa emozione, comprendente l’arricciamento del naso, il sollevamento del labbro superiore e la fuoriuscita della lingua, sembra essere un meccanismo teso ad espellere il cibo malsano dalla bocca e ad impedire l’ingresso di agenti patogeni nelle cavità nasali (Susskind, Lee, Cusi, Feiman, Grabski, & Anderson, 2008). Alcuni studiosi (ad es., Curtis & Biran, 2001; Schaller & Duncan, 2007) indicano il disgusto come un elemento di un più ampio “sistema immunitario comportamentale” che, prodotto dell’evoluzione, svolgerebbe la funzione adattiva di motivare atteggiamenti e comportamenti finalizzati ad evitare i pericoli di contaminazione, di contagio e di malattia.
Nonostante l’antecedente primario dell’emozione del disgusto sia costituito dalla presenza di oggetti contaminati e malsani, come cibi maleodoranti o decomposti, il disgusto va ben oltre il dominio fisico e la prevenzione del contagio, tanto da poter essere suscitato anche da comportamenti ritenuti immorali o impuri. A questo proposito, ad esempio , in uno studio di Zhong e Liljenquist (2006) nel quale si chiedeva ai partecipanti di ricordare comportamenti immorali commessi in passato, è emerso che questa minaccia alla propria integrità morale provocava in loro un aumento del bisogno di lavarsi. In un altro studio (Schnall et al., 2008) si è osservato che i partecipanti fatti accomodare ad un tavolo sporco giudicavano più negativamente comportamenti moralmente discutibili rispetto ai partecipanti che sedevano ad un tavolo pulito. Altri studiosi (Eskine et al., 2011) hanno somministrato ai partecipanti una bevanda dolce, amara oppure neutra, e successivamente hanno chiesto loro di esprimere un giudizio rispetto ad una serie di vignette raffiguranti comportamenti moralmente trasgressivi. I risultati hanno mostrato che più la bevanda era stata percepita amara, ovvero disgustosa, più i giudizi morali viravano al negativo.
L’intimo legame tra disgusto e moralità è emerso anche in alcuni studi aventi l’obiettivo di misurare la relazione tra la sensibilità al disgusto (rilevata attraverso dei questionari) e gli atteggiamenti nei confronti di alcune tematiche socio-politiche (ad es., Inbar, Pizarro, Knobe, & Bloom, 2009; Terrizzi, Shook, & Ventis, 2010). In generale, i risultati hanno mostrato come la sensibilità al disgusto sia predittiva di posizioni più conservatrici in ambito sociale come, ad esempio, un atteggiamento più negativo nei confronti dell’immigrazione, dell’aborto, dell’eutanasia, dei matrimoni gay e della ricerca sulle cellule staminali. Sembra, pertanto, che a una maggiore sensibilità al disgusto corrispondano sia posizioni più negative rispetto a questioni sociali che coinvolgono il contatto intergruppi e quindi una possibile contaminazione del corpo, sia un’affiliazione politica più conservatrice come emerso anche da uno studio condotto negli Stati Uniti da Inbar e collaboratori (Inbar, Pizarro, Iyer, & Haidt, 2012). I loro risultati hanno evidenziato che la sensibilità al disgusto e, in particolare, la paura di contaminazione, era predittiva di un’intenzione di voto alle presidenziali americane più favorevole a John McCain (il candidato conservatore) rispetto a Barack Obama.
In conclusione, quindi, la forte reazione emotiva di disgusto elicitata non solo da elementi tangibili ma anche da comportamenti immorali, appare essere una sorta di meccanismo di difesa in grado di aumentare il ricorso protettivo a credenze di tipo conservatore. Essa sembra, quindi, attivare una serie di meccanismi psicologici funzionali allo scopo di gestire e ridurre la paura e lo stato di incertezza determinati da pensieri come la paura del contagio fisico. Questo potrebbe, quindi, spiegare in parte perché il conservatorismo possa essere associato anche al maggior ricorso a politiche sociali di chiusura, di salvaguardia e di difesa da possibili contaminazioni.
GLOSSARIO
Emozioni primarie. Le emozioni di base sono considerate la paura, la tristezza, la rabbia, il disgusto, la gioia e la sorpresa.
Social Value Orientation (SVO). È un costrutto che fa riferimento e descrive gli orientamenti personali nel distribuire delle risorse (ad es., del denaro tra sé e un’altra persona) in situazioni di contesti di gruppo o diadi. Vengono descritti tre diversi tipi di orientamenti: prosociale (o cooperativo, atto a massimizzare gli interessi propri ed altrui e quindi orientato all’equità); individualista (che tende solo a massimizzare i propri interessi senza porre attenzione agli interessi altrui); competitivo (che mira esclusivamente a massimizzare la distanza tra i propri interessi e gli interessi altrui - a proprio vantaggio - non ponendo quindi attenzione al guadagno proprio in senso assoluto).
Valori fondamentali. Nella teoria universale dei valori personali Shalom H. Schwartz (1992) individua 10 tipi di orientamenti valoriali derivanti da esigenze umane riconosciute in tutte le culture: Potere (status sociale e prestigio), Successo (successo personale), Edonismo (piacere personale e gratificazione dei sensi), Stimolazione (eccitazione, novità e sfide stimolanti), Autodirezione (azione e indipendenza di pensiero), Universalismo (rispetto e protezione degli uomini e della natura), Benevolenza (benessere delle persone con cui si è a diretto contatto), Tradizione (rispetto e accettazione delle tradizioni), Conformismo (conformità alle aspettative e norme sociali), Sicurezza (incolumità e stabilità della società e della propria persona).
BIBLIOGRAFIA
Amodio, D. M., Jost, J. T., Master, S. L., & Yee, C. M. (2007). Neurocognitive correlates of liberalism and conservatism. Nature Neuroscience, 10, 1246-1247.
Bobbio, A., Nencini, A., & Sarrica, M. (2011). Il Moral Foundation Questionnaire: Analisi della struttura fattoriale della versione italiana. Giornale di Psicologia, 5, 7-18.
Cannon, P. R., Schnall, S., & White, M. (2011). Transgressions and expressions: Affective facial muscle activity predicts moral judgments. Social Psychological and Personality Science, 2, 325-331.
Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. American Psychologist, 59, 581-594.
Carraro, L., Castelli, L., & Macchiella, C. (2011). The automatic conservative: Ideology-based attentional asymmetries in the processing of valenced information. PloS ONE, 6: e26456.
Castelli, L., & Carraro, L. (2011). Ideology is related to basic cognitive processes involved in attitude formation. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 1013-1016.
Cohrs, J. C., Moschner, B., Maes, J., & Kielmann, S. (2005). The motivational bases of right-wing authoritarianism and social dominance orientation: Relations to values and attitudes in the aftermath of September 11, 2001. Personality and Social Psychology Bulletin, 31, 1425-1434.
Curtis, V., & Biran, A. (2001). Dirt, disgust, and disease: Is hygiene in our genes? Perspectives in Biology and Medicine, 44, 17-31.
Ekman, P. (1994). All emotions are basic. In R. J. Davidson & P. Ekman (Eds.), The nature of emotion: Fundamental questions (pp. 15-19). New York, NY: Oxford University Press.
Eskine, K. J., Kacinik, N. A., & Prinz, J. J. (2011). A bad taste in the mouth: Gustatory disgust influences moral judgment. Psychological Science, 22, 295-299.
Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B.A. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96, 1029-1046.
Graham, J., Nosek, B. A., & Haidt, J. (2012). The moral stereotypes of liberals and conservatives: Exaggeration across the political divide. PLoS ONE, 7: e50092.
Graham, J., Nosek, B. A., Haidt, J., Iyer, R., Koleva, S., & Ditto, P. H. (2011). Mapping the moral domain. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 366-385.
Haidt, J., & Joseph, C. (2004). Intuitive ethics: How Innately prepared intuitions generate culturally variable virtues. Daedalus, 133, 55-66.
Heaven, P. C. L, & Oxman, L. N. (1999). Human values, conservatism and stereotypes of homosexuals. Personality & Individual Differences, 27, 109-118.
Helzer, E., & Pizarro D. A. (2011). Dirty liberals! Reminders of cleanliness promote conservative political and moral attitudes. Psychological Science, 22, 517-522.
Inbar, Y., & Pizarro, D. A. (2009). How disgust influences moral, social, and legal judgments. The Jury Expert, 21, 12-19.
Inbar, Y., Pizarro, D., Iyer, R., & Haidt, J. (2012). Disgust sensitivity, political conservatism, and voting. Social Psychological and Personality Science, 3, 537-544.
Inbar, Y., Pizarro, D. A., Knobe, J. A., & Bloom, P. (2009). Disgust sensitivity predicts intuitive disapproval of gays. Emotion, 9, 435-439.
Iyer R., Koleva S., Graham J., Ditto P., & Haidt, J. (2012). Understanding libertarian morality: The psychological dispositions of self-identified libertarians. PLoS ONE, 7: e42366.
Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61, 651-670.
Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. Annual Review of Psychology, 60, 307-333.
Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, 339-375.
Jost, J. T., Nosek, B. A., & Gosling, S. D. (2008). Ideology: Its resurgence in social, personality, and political psychology. Perspectives on Psychological Science, 3, 126-136.
Kanai, R., Feilden, T., Firth, C., & Rees, G. (2011). Political orientations are correlated with brain structure in young adults. Current Biology, 21, 677-680.
Kant, I. (2012). Critica della ragion pratica. Bari: Laterza.
Oxley, D. R., Smith, K. B., Alford, J. R., Hibbing, M. V., Miller, J. L., Scalora, M., Hatemi, P. K., & Hibbing, J. R. (2008). Political attitudes vary with physiological traits. Science, 321, 1667-1670.
Schaller, M., & Duncan, L. A. (2007). The behavioral immune system: Its evolution and social psychological implications. In Forgas, Haselton, & von Hippel (Eds.), Evolution and the social mind: Evolutionary psychology and social cognitions (pp. 293-307). New York: Psychology Press.
Schnall, S., Haidt, J., Clore, G. L., & Jordan, A. (2008). Disgust as embodied moral judgment. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1096-1109.
Schwartz, S. H. (1992) Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. Advances in Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
Susskind, J. M., Lee, D. H., Cusi, A., Feiman, R., Grabski, W., & Anderson, A. K. (2008). Expressing fear enhances sensory acquisition. Nature Neuroscience, 11, 843-850.
Terrizzi, J. A. Jr., Shook, N. J., & Ventis, W. L. (2010). Disgust: A predictor of social conservatism and prejudicial attitudes toward homosexuals. Personality and Individual Differences, 49, 587-592.
Tomkins, S. S. (1963). Left and right: A basic dimension of ideology and personality. In R. W. White (Ed.), The study of lives (pp. 388-411). Chicago: Atherton.
Tomkins, S. S. (1965). The psychology of being right and left. Transaction, 3, 21-27.
Van Lange, P. A. M., Bekkers, R., Chirumbolo, A., & Leone, L. (2012). Are conservatives less likely to be prosocial than liberals? From games to ideology, political preferences and voting. European Journal of Personality, 26, 461-473.
Van Leeuwen, F., & Park, J. H. (2009). Perceptions of social dangers, moral foundations, and political orientation. Personality and Individual Differences, 47, 169-173.
Zhong, C., & Liljenquist, K., (2006). Washing away your sins: Threatened morality and physical cleansing. Science, 313, 1451-1452.