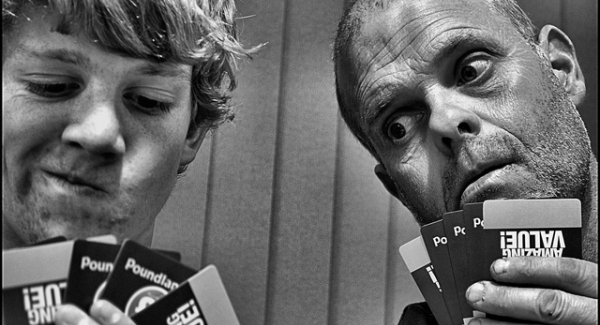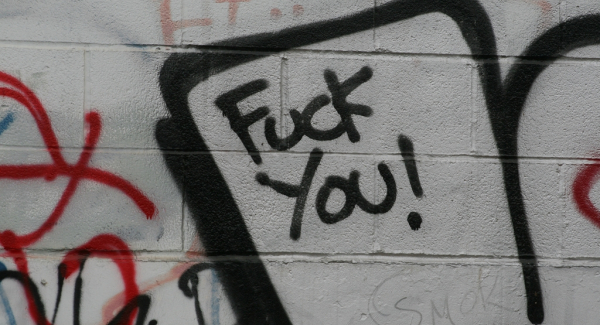keywords: moralità, percezione sociale.
Nel capolavoro Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde (1886), Robert Louis Stevenson separa in due distinte identità gli impulsi morali e immorali che convivono all’interno dell’essere umano. Così, da una parte troviamo Jekyll educato, di sani principi e ben inserito nella sua comunità e, dall’altra, Hyde depravato, violento e asociale.
Questa dialettica tra bene e male, tra essere buoni o cattivi, che è centrale sia nella letteratura che in tutto il pensiero filosofico occidentale (Da Re, 2008), non riguarda soltanto la percezione di Sé (Allison, Messick, & Gothals, 1989; Blasi, 1988). Gli esseri umani, infatti, non solo sono impegnati a comprendere quali siano le norme e i principi a cui attenersi per essere “una brava persona”, a ragionare e prendere delle decisioni di fronte a scenari morali, a comportarsi in modo adeguato, ma sono anche profondamente interessati a capire se le altre persone presenti nel proprio contesto sociale sono morali oppure immorali. A questo proposito, la recente letteratura nell’ambito della percezione sociale (si veda glossario) ha sottolineato la centralità della moralità, ed in particolar modo di caratteristiche quali l’onestà, la correttezza e l’affidabilità, nel processo di formazione di impressioni (si veda glossario) interpersonale e su individui che appartengono al proprio gruppo (ingroup) e a gruppi differenti (outgroup).
Moralità: Dimensione fondamentale della percezione
Nonostante siano ormai numerose le evidenze empiriche sul ruolo della dimensione morale nella percezione sociale, la letteratura psico-sociale ha accumulato un grande ritardo nello studio della moralità (Leach, Ellemers, & Barreto, 2007), soprattutto se confrontata con altre discipline come la psicologia dello sviluppo (Killen & Smetana, 2006) o del ragionamento (Foot, 1967; Thomson, 1985). Com’è possibile che gli psicologi sociali si siano dimenticati della moralità che già Aristotele nella sua Etica Nicomachea (1999; I, 1094a 1-b 11) poneva al vertice delle virtù come bene a cui tutti devono aspirare?
Questo ritardo è dovuto principalmente al fatto che gli psicologi che si sono occupati di capire quali informazioni usiamo quando ci dobbiamo formare un’opinione su altri hanno ritenuto a lungo che le dimensioni fondamentali della percezione sociale fossero solo due. A seconda della tradizione di ricerca considerata, tali dimensioni sono state definite con le etichette di “agency” e “communion”, “potere” e “benevolenza”, “calore” e “competenza” (Abele, Cuddy, Judd, & Yzerbyt, 2008; Asch, 1946; Judd, James-Hawkins, Yzerbyt, & Kashima, 2005; Rosenberg, Nelson, & Vivekananthan, 1968). In accordo con le linee di ricerca più recenti, in questo articolo utilizzeremo i termini “calore” e “competenza” (Fiske, Cuddy, & Glick, 2007). La dimensione di calore comprende quei tratti connessi alle relazioni sociali come onesto, amichevole, simpatico; la dimensione della competenza, invece, include le caratteristiche che attengono alle capacità del target sociale come intelligente, abile, zelante. La centralità di queste due dimensioni nella percezione sociale è determinata dal fatto che esse consentono di rispondere a due quesiti fondamentali per adattarsi bene al mondo sociale e alla vita della propria comunità. Infatti, mentre il calore consente di definire se l’altra persona rappresenti un’opportunità o una minaccia, ovvero se ha cattive o buone intenzioni, la competenza consente di definire se gli attori sociali sono in grado di mettere in atto le proprie intenzioni, benevole o malevole che siano (Fiske et al., 2007). Sebbene sia il calore che la competenza abbiano un ruolo centrale nel definire la percezione degli altri, la ricerca ha altresì dimostrato che il calore sociale ha un peso maggiore nel determinare impressioni e giudizi (Abele & Bruckmuller, 2011; De Bruin & Van Lange, 2000; Ybarra, Chan, & Park, 2001; Wojciszke, 2005; Wojciszke, Bazinska, & Jaworski, 1998). In sintesi, quando dobbiamo capire se un’altra persona ci piace oppure non ci piace, siamo più interessati e influenzati dalla sua simpatia, socievolezza o sincerità piuttosto che dalla sua intelligenza e abilità.
I modelli di percezione sociale a due dimensioni oltre ad aver ricevuto un vasto supporto empirico sono ‘economici’ e semplici da un punto di vista teorico. Tuttavia, in questo ampio filone di letteratura, le caratteristiche morali (come onesto, sincero, retto) sono confluite nella macro-dimensione di calore insieme alle caratteristiche di socievolezza (estroverso, simpatico, cordiale). Questa visione basata su due fattori omogenei e monolitici al proprio interno non ha permesso di analizzare il contributo specifico della moralità né di stabilire se la primarietà di calore su competenza sia dovuta proprio alla presenza dei tratti morali all’interno di questa dimensione. È stato dunque necessario attendere sessant’anni dalle ricerche pionieristiche di Asch (1946) prima di iniziare a considerare il ruolo distintivo della moralità nella percezione sociale (Leach et al., 2007).
Moralità vs. Socievolezza nella percezione interpersonale
Sebbene gran parte delle ricerche di percezione sociale abbiano considerato la dimensione del calore umano nel suo complesso, più di recente è stato teoricamente ed empiricamente dimostrato che la dimensione di calore comprende due componenti distinte: Moralità e socievolezza (Brambilla, Rusconi, Sacchi, & Cherubini, 2011; Brukmuller & Abele, 2013; Pagliaro, 2012; Szymkow, Chandler, Ijzerman, Parzuchowski, & Wojciszke, 2013). Mentre la socievolezza riguarda lo stabilire connessioni con gli altri (ad es., amichevole, piacevole), la moralità è associata a caratteristiche relative alla correttezza di un target sociale, quali la fiducia, l’onestà, l’affidabilità. In linea con tale argomentazione, lavori nell’ambito della psicologia della personalità hanno mostrato che moralità e socievolezza costituiscono due fattori di personalità distinti e dissociabili (De Raad & Peabody, 2005). Infatti, una persona può essere molto onesta e corretta, ma non essere necessariamente socievole e amichevole con gli altri o viceversa. Pensiamo al Padrino di Francis Ford Coppola: Il protagonista interpretato da Marlon Brando è socievole, è un padre affettuoso legato al proprio clan ma non è sicuramente una persona morale.
Sulla base di tale distinzione, alcuni lavori hanno indagato lo specifico impatto dei tratti morali e di socievolezza nel processo di formazione delle impressioni. Ad esempio, Cottrell, Neuberg e Li (2007) chiesero a degli studenti di indicare le caratteristiche più importanti che una persona dovrebbe idealmente possedere. Dai risultati l’affidabilità emerse come la caratteristica più importante, mentre tratti più propriamente riferiti alla socievolezza erano valutati come meno importanti. Più di recente, Brambilla e collaboratori (Brambilla et al., 2011) hanno investigato il ruolo dei tratti di moralità, socievolezza e competenza nel processo di ricerca di informazioni che precede la formulazione di un giudizio o un’impressione. I risultati di questi studi hanno mostrato come le persone, quando cercano informazioni su un target sconosciuto, siano maggiormente interessate a ricercare e selezionare dati nell’ambito della moralità piuttosto che della socievolezza o della competenza (Brambilla et al., 2011).
La primarietà della dimensione morale non riguarda solo il processo di selezione delle informazioni ma coinvolge anche la formulazione di un giudizio globale e le intenzioni di agire in un certo modo verso altri individui. Una seconda serie di studi ha mostrato che le persone quando sono chiamate a formulare un giudizio su altri sono maggiormente influenzate da informazioni riguardanti la moralità, rispetto a quelle di competenza e di socievolezza (Brambilla, Sacchi, Rusconi, Cherubini, & Yzerbyt, 2012). Al riguardo, Pagliaro, Brambilla, Sacchi, D’Angelo e Ellemers (2013) hanno condotto una ricerca in un contesto scolastico. Nello specifico ai lavoratori di un plesso scolastico – insegnanti e assistenti amministrativi – era chiesto di immaginare l’arrivo di un nuovo dirigente scolastico descritto come molto (vs. poco) morale e molto (vs. poco) competente. In linea con quanto rilevato dalle ricerche di laboratorio, le impressioni globali erano meglio predette dalle informazioni circa la moralità del futuro nuovo dirigente, rispetto a quelle relative alla competenza. Inoltre, insegnanti e tecnici amministrativi erano maggiormente disposti a interagire e cooperare con un dirigente onesto e sincero, rispetto a un dirigente capace e intelligente.
L’insieme di questi risultati indica pertanto che la primarietà di calore individuata dalle ricerche precedenti può essere meglio spiegata in riferimento alle caratteristiche morali, piuttosto che a quelle relative alla socievolezza.
La moralità e la percezione del proprio gruppo
Il ruolo decisivo e primario dei tratti morali nella percezione sociale riguarda anche i giudizi circa il gruppo di appartenenza (ingroup). È stato ampiamente dimostrato che una parte rilevante dell’identità degli individui è connessa all’appartenenza ai gruppi sociali (si veda la Teoria dell’Identità Sociale; Tajfel & Turner, 1979). Ovvero, ognuno di noi si definisce, ad esempio, anche in quanto uomo o donna, giovane o anziano, italiano o francese, interista o milanista. Di conseguenza, al fine di ottenere e mantenere una rappresentazione di sè positiva, le persone cercano di entrare a far parte di gruppi ad alto status o ad alto potere oppure, quando questo non è possibile, cercano di elevare l’immagine del proprio gruppo anche a discapito degli outgroup. In questo processo, un discreto numero di ricerche ha dimostrato che le caratteristiche morali hanno un ruolo più importante di quelle riferibili alla competenza (e alla socievolezza) nel differenziare positivamente il proprio ingroup (Pagliaro & Di Cesare, 2013).
Leach et al. (2007) hanno realizzato diversi studi sui fattori in grado di determinare una valutazione positiva dell’ingroup. In un primo studio gli autori hanno analizzato le valutazioni fornite dai partecipanti in merito alla competenza (ad es., capace e intelligente) alla socievolezza (ad es., amichevole e disponibile) e alla moralità (ad es., onesto e sincero) del proprio ingroup dimostrando che competenza, socievolezza e moralità costituiscono tre distinte dimensioni. Nello stesso studio gli autori hanno chiesto ai partecipanti di indicare in quale misura fosse desiderabile per il proprio gruppo di appartenenza possedere caratteristiche riconducibili alle tre dimensioni. I risultati hanno mostrato che gli individui ritengono più importante e desiderabile per l’ingroup possedere tratti relativi alla moralità. Inoltre, gli autori hanno rilevato come l’identificazione con l’ingroup e il senso di orgoglio di appartenere a tale gruppo sia predetta unicamente dall’attribuzione di tratti morali all’ingroup e non da quelli di competenza o di socievolezza. A conclusioni analoghe sono giunti alcuni lavori realizzati in ambito organizzativo. Al riguardo, Ellemers, Kingma, Van der Bugt e Barreto (2011) hanno intervistato impiegati di numerose aziende chiedendo loro di valutare le organizzazioni di appartenenza e compilare scale di commitment e soddisfazione lavorativa. I risultati mostrano che solo la dimensione morale è in grado di predire l’orgoglio verso la propria organizzazione, la soddisfazione lavorativa, e l’impegno nel lavoro.
Il ruolo centrale dei tratti morali nel definire la percezione del proprio gruppo emerge anche da lavori che hanno analizzato le condotte intragruppo, ovvero i comportamenti all’interno del gruppo di appartenenza. In una prima serie di studi, Ellemers, Pagliaro, Barreto e Leach (2008) invitavano i partecipanti a intraprendere dei comportamenti al fine di migliorare il basso status del proprio gruppo, che poteva sia essere indotto artificialmente in laboratorio dai ricercatori (dando dei feedback fittizi sulla prestazione dei gruppi in un compito di problem-solving) sia essere preesistente (meridionali vs. settentrionali). I risultati mostrano che i partecipanti tendono ad adottare in misura maggiore un certo comportamento quando questo è definito in termini morali, piuttosto che in rapporto ad altre dimensioni.
Mentre gli studi di Ellemers e collaboratori (2008) hanno dimostrato la primarietà delle norme morali nel regolare le condotte intragruppo, studi successivi hanno indagato le motivazioni che sottendono tale risultato. Nello specifico, Pagliaro, Ellemers e Barreto (2011) hanno mostrato che gli individui, nell’aderire alle norme morali, prevedono e anticipano psicologicamente rispetto da parte degli altri e acquisizione di una posizione centrale all’interno dell’ingroup. Infatti, all’interno dei gruppi sociali manifestare divergenza rispetto a norme definite in termini morali costituisce una minaccia per l’identità sociale (Tajfel & Turner, 1979) più forte rispetto al manifestare divergenza rispetto a norme definite in termini di competenza (Kouzakova, Ellemers, Harink, & Scheepers, 2012).
Nel complesso, quindi, a livello di gruppo la dimensione morale sembra svolgere una funzione cruciale nella definizione dell’identità, e nella regolazione della vita intragruppo, consentendo agli individui di distinguere positivamente i propri gruppi di appartenenza (Pagliaro & Di Cesare, 2013).
La moralità e la percezione di altri gruppi
La moralità si è dunque rivelata cruciale non soltanto nella percezione interpersonale ma anche nella percezione del proprio gruppo di appartenenza. Rimane da comprendere se la dimensione morale svolga un ruolo primario anche nel modo con cui noi ci rapportiamo ai membri di gruppi diversi da quelli a cui apparteniamo (outgroup).
In un primo lavoro, Leach, Minescu, Poppe e Hagendoorn (2008) hanno esaminato i contenuti degli stereotipi riferiti a Ceceni e ad Ebrei fra la popolazione russa. I risultati mostrano, analogamente a quanto è emerso per le ricerche di tipo interpersonale, che le caratteristiche di socievolezza e moralità sono distinguibili fra loro. Ispirato da questi risultati, Brambilla (2010) ha chiesto a studenti universitari italiani di indicare in quale misura diversi gruppi sociali – ad esempio tedeschi, meridionali, settentrionali – fossero socievoli, amichevoli, onesti, sinceri, competenti e capaci. I risultati confermano che i gruppi sono diversamente valutati lungo le dimensioni di socievolezza, moralità e competenza. Questi risultati, congiuntamente a quanto emerso dal lavoro di Leach e collaboratori (2007), sottolineano la necessità di distinguere fra le caratteristiche di socievolezza e moralità nell’esplorare i contenuti stereotipici dei gruppi sociali.
Più di recente, Brambilla e colleghi (2012) hanno investigato l’importanza delle dimensioni di competenza, socievolezza e moralità nel predire le impressioni e le emozioni provate verso gruppi sociali. In tre studi gli autori hanno chiesto a studenti universitari di formarsi un’impressione su un gruppo immigrato a loro sconosciuto. I risultati mostrano che le impressioni globali e le prime risposte affettive sono predette unicamente dalla moralità. Così, il gruppo immigrato era percepito più positivamente quando descritto come morale, sincero e onesto, rispetto a quando descritto come poco onesto e sincero; le manipolazioni di competenza e socievolezza, invece, non avevano alcun effetto sulle valutazioni.
Il ruolo decisivo della moralità nella percezione intergruppi non riguarda unicamente le impressioni globali e le risposte affettive, ma coinvolge anche le intenzioni di comportarsi in un certo modo. Brambilla, Hewstone e Colucci (2013), sempre considerando il gruppo degli immigrati, hanno mostrato che l’attribuzione di caratteristiche morali agli immigrati è associato al desiderio di interagire con loro e con la volontà di promuovere politiche a favore dell’immigrazione.
Adottando un approccio sperimentale, Brambilla, Sacchi, Pagliaro e Ellemers (2013) hanno confermato l’importanza della moralità, rispetto a socievolezza e competenza, nel predire il desiderio di interagire e cooperare con i membri degli outgroup (in questo caso un target indiano). Gli autori mostrano che tanto più un membro dell’outgroup è percepito come immorale quanto più è percepito come minaccioso per la sopravvivenza e l’ordine pubblico. È tale percezione di minaccia, poi, a determinare una tendenza comportamentale a valenza negativa.
Nel complesso, l’insieme di evidenze riportate in questo articolo mostra non solo come la moralità costituisca una dimensione distinta da socievolezza e competenza ma anche la sua centralità nella percezione sociale e nel processo di formazione di impressione. Le caratteristiche morali, infatti, sembrano essere determinanti nel definire se un’altra persona – vista sia come un singolo individuo che come membro di un gruppo sociale – è positiva o negativa, buona o cattiva. Alcuni degli studi citati non solo hanno mostrato la rilevanza psicologica dei tratti morali nella rappresentazione degli altri ma hanno cercato di comprendere il perché di questa primarietà. A questo proposito, alcune ricerche hanno sottolineato come le informazioni sulla moralità siano cruciali proprio perché ci permettono di chiarire un punto essenziale per il buon adattamento all’interno del nostro contesto, ovvero se l’altro costituisca una possibile risorsa, qualcuno di cui ci si può fidare, con cui si può cooperare oppure un pericolo, una minaccia simbolica e realistica all’integrità del Sé o all’integrità del gruppo (Brambilla et al., 2012; Brambilla et al., 2013). Poiché le relazioni tra individui, gruppi e categorie sociali differenti che entrano in contatto tra loro sono spesso minate da pregiudizio e stereotipi, comprendere quale sia la dimensione dominante nella percezione sociale è cruciale, ad esempio, per pianificare in modo adeguato gli eventuali interventi mirati alla riduzione del pregiudizio e alla promozione di inclusione sociale.
Glossario
Percezione sociale. È quella parte della psicologia sociale che si occupa di comprendere come ci formiamo delle impressioni sulle altre persone presenti nel nostro contesto sociale – siano singoli individui o gruppi – e come arriviamo a formulare un giudizio su di loro.
Formazione di impressioni. È un processo cognitivo attraverso cui gli individui selezionano le informazioni, le accumulano, le elaborano e le organizzano in memoria al fine di giudicare gli altri e di pianificare nei loro confronti l’interazione e il comportamento più adeguato (approccio vs. evitamento).
Bibliografia
Abele, A. E., & Bruckmuller, S. (2011). The bigger one of the “Big Two”? Preferential processing of communal information. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 935-948.
Abele, A. E., Cuddy, A. J. C., Judd, C. M., & Yzerbyt, V. (2008). Fundamental dimensions of social judgment. European Journal of Social Psychology, 38, 1063-1065.
Allison, S. T., Messick, D. M., & Goethals, G. R. (1989). On being better but not smarter than others: The Muhammad Ali effect. Social Cognition, 7, 275-296.
Aristotele (1999). Etica Nicomachea, trad it. Natali C. Roma-Bari: Laterza.
Asch, S. E. (1946). Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41, 258–290.
Blasi, A. (1988). Identity and the development of the self. In D. K. Lapsley & F. C. Power (Eds.), Self, ego, and identity: Integrative approaches (pp. 226–242). New York: Springer.
Brambilla, M. (2010). Fundamental Dimensions of Social Judgment: Sociability and Morality as Distinct Characteristics of Social Warmth. Unpublished doctoral dissertation. University of Bologna (Italy).
Brambilla, M., Hewstone, M., & Colucci F. P. (2013). Enhancing moral virtues: Increased perceived outgroup morality as a mediator of intergroup contact effects. Group Processes and Intergroup Relations, 15, 305-315.
Brambilla, M., Rusconi, P., Sacchi, S., & Cherubini, P. (2011). Looking for honesty: The primary role of morality (vs. sociability and competence) in information gathering. European Journal of Social Psychology, 41, 135–143.
Brambilla, M., Sacchi, S., Pagliaro, S., & Ellemers, N. (2013). Morality and intergroup relations: Threats to safety and group image predict the desire to interact with outgroup and ingroup members. Journal of Experimental Social Psychology, 49, 811-821.
Brambilla, M., Sacchi, S., Rusconi, P., Cherubini, P., & Yzerbyt, V. Y. (2012). You want to give a good impression? Be honest! Moral traits dominate group impression formation. British Journal of Social Psychology, 51, 149-166.
Bruckmuller, S., & Abele, A. E. (2013). The density of the big two: How are agency and communion structurally presented? Social Psychology, 44, 63-74.
Cottrell, C. A., Neuberg, S. L., & Li, N. P. (2007). What do people desire in others? A sociofunctional perspective on the importance of different valued characteristics. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 208–231.
Da Re, A. (2008). Filosofia morale. Milano: Bruno Mondadori.
De Bruin, E. N. M., & Van Lange, P. A. M. (2000). What people look for in others: Influences of the perceiver and the perceived on information selection. Personality and Social Psychology Bulletin, 26, 206-219.
De Raad, B., & Peabody, D. (2005). Cross-culturally recurrent personality factors: Analyses of three factors. European Journal of Personality, 19, 451–474.
Ellemers, N., Kingma, L., Van den Burgt, J., & Barreto, M. (2011). Corporate Social Responsibility as a source of organizational morality, employee commitment and satisfaction. Journal of Organizational Moral Psychology, 1, 97-124.
Ellemers, N., Pagliaro, S., Barreto, M., & Leach, C. W. (2008). Is it better to be moral than smart? The effects of morality and competence norms on the decision to work at group status improvement. Journal of Personality and Social Psychology, 95, 1397-1410.
Fiske, S. T., Cuddy, A. J. C., & Glick, P. (2007). Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. Trends in Cognitive Sciences, 11, 77-83.
Foot, P. (1967). The problem of abortion and the doctrine of the double effect. New York: Oxford University Press Oxford.
Judd, C. M., James-Hawkins, L., Yzerbyt, V., & Kashima, Y. (2005). Fundamental dimensions of social judgment: understanding the relations between judgments of competence and warmth. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 899-913.
Killen, M., & Smetana J.G. (2006). Handbook of moral development. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Kouzakova, M., Ellemers, N., Harinck, F., & Scheepers, D. (2012). The implications of value conflict: How disagreement on values affects self-involvement and perceived common ground. Personality and Social Psychology Bulletin, 38, 798-807.
Leach, C. W., Ellemers, N., & Barreto, M. (2007). Group virtue: The importance of morality (vs. competence and sociability) in the positive evaluation of in-groups. Journal of Personality and Social Psychology, 93, 234-249.
Leach, C. W., Minescu, A., Poppe, E., & Hagendoorn, L. (2008). Generality and specificity in stereotypes of out-group power and benevolence: Views of Chechens and Jews in the Russian federation. European Journal of Social Psychology, 38, 1165-1174.
Pagliaro, S. (2012). On the relevance of morality in social psychology: An introduction to a virtual special issue. European Journal of Social Psychology, 42, 400-405.
Pagliaro, S., & Di Cesare, C. (2013). La moralità in psicologia sociale: L’importanza di un approccio basato sui gruppi. Psicologia Sociale, 2, 193-210.
Pagliaro, S., Brambilla, M., Sacchi, S., D'Angelo, M., & Ellemers, N. (2013). Initial impressions determine behaviours: Morality predicts the willingness to help newcomers. Journal of Business Ethics, 117, 37-44.
Pagliaro, S., Ellemers, N., & Barreto, M. (2011). Sharing moral values: Anticipated in-group respect as a determinant of adherence to morality-based (but not competence-based) group norms. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 1117-1129.
Rosenberg, S., Nelson, C., & Vivekananthan, P. S. (1968). A multidimensional approach to the structure of personality impressions. Journal of Personality and Social Psychology, 9, 283-294.
Stevenson, R. L. (1886). Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde.
Szymkow, A., Chandler, J., Ijzerman, H., Parzuchowski, M., & Wojciszke, B. (2013). Warmer hearts, warmer rooms: How positive communal traits increase estimates of ambient temperature. Social Psychology, 44, 167-176.
Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Monterey, C.A.: Brooks Cole.
Thomson, J. J. (1985). The trolley problem. The Yale Law Journal, 279, 1395–1415.
Wojciszke, B. (2005). Morality and competence in person- and self-perception. European Review of Social Psychology, 16, 155-188.
Wojciszke, B., Bazinska, R., & Jaworski, M. (1998). On the dominance of moral categories in impression formation. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 1251-1263.
Ybarra, O., Chan, E., & Park, D. (2001). Young and old adults’ concerns about morality and competence. Motivation and Emotion, 25, 85-100.