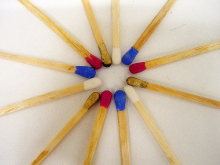Ogni giorno dobbiamo scegliere centinaia di volte (più o meno consciamente) tra comportamenti ecologici e non-ecologici. Svegliarsi con una sveglia meccanica o elettrica? Fare la doccia o il bagno? Con un bagnoschiuma ecologico o non-ecologico? Bere il caffè classico o biologico? Chiudere l’acqua mentre ci laviamo i denti o lasciarla aperta?
Lo spazio fisico è il contenitore che rende possibili e, allo stesso tempo, vincola tutte le nostre azioni, ma, come disse Hoffmann (1981), “solo i pesci non sanno che è acqua quella in cui nuotano” (pp. 16-17). La dimensione spaziale spesso resta fuori dalla nostra consapevolezza, ma questo non significa che i riferimenti spaziali non siano elaborati dal nostro cervello.
Varie forme di pregiudizio
È certamente un’esperienza comune e ricorrente quella di vedere in televisione (e anche in prima persona) o di leggere sui giornali di episodi caratterizzati da frasi ingiuriose, o addirittura di aggressioni vere e proprie, dirette ai danni di persone indifese appartenenti a gruppi stigmatizzati, come ad esempio gli omosessuali, i disabili, gli immigrati, gli anziani, le persone obese.
Immaginate di essere saliti su un autobus di linea e di stare viaggiando per le vie della vostra città. All’improvviso un semaforo davanti al mezzo scatta sul rosso e voi, vedendolo, vi preparate ad affrontare la prossima frenata aggiustando la postura e anticipando gli effetti della frenata. L’autista, però, si accorge del semaforo un po’ più tardi di voi e, per rimediare, frena in modo più brusco di quanto previsto proiettando tutti i passeggeri in avanti. Che differenza c’è tra lo spostamento che avete attuato preventivamente e quello che avete subito?